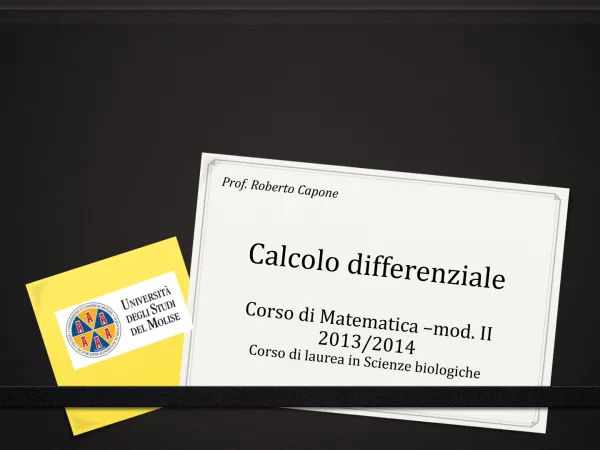
Derivate: Introduzione e Calcolo
Informazioni sul documento
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 1.53 MB |
| Materia | Analisi Matematica |
| Tipo di documento | Appunti per lezione |
Riassunto
I.Il Concetto di Derivata nel Calcolo Differenziale
Questo documento tratta il fondamentale concetto di derivata all'interno del calcolo differenziale e del suo sviluppo storico, partendo dai problemi classici della determinazione della retta tangente ad una curva in un punto. L'introduzione della nozione di limite è cruciale per definire il rapporto incrementale e, conseguentemente, la derivata di una funzione in un punto. Vengono illustrate le diverse notazioni per la derivata (Lagrange, Cauchy, Newton, Leibniz) e la sua relazione con l'equazione della retta tangente.
1. Introduzione Storica e Problemi che portano alla Derivata
Il documento inizia tracciando un breve percorso storico del calcolo differenziale, contrapponendolo al calcolo integrale. Mentre quest'ultimo affonda le radici nella matematica greca, il calcolo differenziale trova la sua nascita e sviluppo nel XVII secolo, principalmente grazie ai contributi di Newton e Leibniz. L'esigenza di risolvere problemi di tipo cinematico, come la determinazione della velocità istantanea, e problemi geometrici, come la ricerca della retta tangente ad una curva in un punto, ha portato alla formulazione del concetto di derivata. Il problema della tangente, in particolare, rappresenta un punto focale iniziale, spingendo gli studiosi a cercare metodi per approssimare tale retta tramite rette secanti sempre più vicine.
2. Il Rapporto Incrementale e la Definizione di Derivata
Per definire rigorosamente la derivata, il testo introduce il concetto di rapporto incrementale. Partendo da una funzione y = f(x) definita in un intervallo [a, b], si considera un punto A(c, f(c)) sul grafico della funzione. Incrementando l'ascissa di A di una quantità h, si ottiene un nuovo punto B(c + h, f(c + h)). Il rapporto incrementale, definito come [f(c + h) - f(c)] / h, rappresenta la pendenza della retta secante passante per A e B. La derivata della funzione nel punto c, indicata con f'(c), viene poi definita come il limite del rapporto incrementale per h che tende a 0, se tale limite esiste ed è finito. Questa definizione fornisce un metodo rigoroso per calcolare la pendenza della retta tangente alla curva nel punto considerato. Il testo prosegue poi illustrando le diverse notazioni per la derivata, attribuendole a Lagrange, Cauchy, Newton e Leibniz.
3. Equazione della Retta Tangente e il Legame tra Derivabilità e Continuità
Una volta definita la derivata, il documento prosegue mostrando la sua stretta relazione con l'equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un punto. Si afferma che una funzione reale f è derivabile in un punto x₀ se e solo se il suo grafico possiede in quel punto una retta tangente non verticale. In tal caso, la derivata f'(x₀) rappresenta il coefficiente angolare di tale retta. Il testo prosegue poi con un teorema fondamentale che stabilisce la relazione tra derivabilità e continuità: ogni funzione reale derivabile in un punto è necessariamente continua in quel punto. Viene fornita una dimostrazione di questo teorema, sottolineando che l'implicazione inversa non è vera; una funzione continua in un punto può non essere derivabile nello stesso punto, come illustrato dall'esempio della funzione f(x) = |x| in x = 0.
4. Derivata Sinistra Derivata Destra e Punti di Non Derivabilità
Il documento introduce le definizioni di derivata sinistra e derivata destra, preparando il terreno per l'analisi dei punti di non derivabilità. La derivata sinistra in un punto x₀ è definita come il limite sinistro del rapporto incrementale, mentre la derivata destra è definita come il limite destro. Se entrambe le derivate sono finite ma diverse, il punto è detto angoloso. Se i limiti tendono a +∞ e -∞ (o viceversa), si ha una cuspide, distinguendo tra cuspidi rivolte verso l'alto e verso il basso. Infine, se entrambi i limiti tendono a +∞, si ha un flesso a tangente verticale. Il testo fornisce esempi concreti per illustrare questi diversi casi di non derivabilità, rafforzando la comprensione del concetto di derivata e delle sue implicazioni.
II. Derivabilità Continuità e Punti di Non Derivabilità
Il documento analizza il legame tra continuità e derivabilità, dimostrando che una funzione derivabile in un punto è necessariamente continua, ma non viceversa. Vengono quindi approfonditi i tipi di punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi e flessi, con esempi e definizioni precise di derivata sinistra e derivata destra. L'analisi dei punti di non derivabilità è fondamentale per la comprensione completa del comportamento delle funzioni derivabili.
1. Relazione tra Derivabilità e Continuità
La sezione inizia analizzando il rapporto fondamentale tra derivabilità e continuità di una funzione. Viene enunciato e dimostrato il teorema che afferma che ogni funzione reale derivabile in un punto è necessariamente continua in quel punto. La dimostrazione sfrutta la definizione di derivata come limite del rapporto incrementale. È importante sottolineare che il viceversa non è vero: una funzione può essere continua in un punto senza essere ivi derivabile. Questo concetto è chiarito tramite un semplice esempio: la funzione f(x) = |x| è continua in x = 0 ma non derivabile nello stesso punto. Questa distinzione è cruciale per una piena comprensione delle proprietà delle funzioni e del loro comportamento in punti specifici del dominio. L'analisi della derivabilità, quindi, richiede un'attenta considerazione della continuità, ma non si limita ad essa, aprendo la strada all'esplorazione di situazioni più complesse.
2. Derivata Sinistra e Destra Introduzione ai Punti di Non Derivabilità
Per una comprensione più profonda della derivabilità, il documento introduce i concetti di derivata sinistra e derivata destra. Questi concetti sono definiti come limiti del rapporto incrementale, considerando rispettivamente gli incrementi h che tendono a 0 da sinistra e da destra. L'introduzione di queste derivate unilaterali è fondamentale per analizzare il comportamento di una funzione in punti dove la derivabilità potrebbe non essere definita in modo tradizionale. La sezione prosegue introducendo il concetto di punti di non derivabilità, anticipando una classificazione più dettagliata che verrà presentata nelle sottosezioni successive. La distinzione tra derivata sinistra e destra prepara il terreno per una comprensione più raffinata del comportamento di una funzione nei suoi punti critici, andando oltre la semplice valutazione della derivata in un punto.
3. Punti Angolosi Un Primo Tipo di Non Derivabilità
Questa sottosezione si concentra su un tipo specifico di punto di non derivabilità: il punto angoloso. Un punto x₀ è angoloso se la derivata sinistra e la derivata destra in x₀ esistono entrambe, ma sono finite e diverse. Questa definizione evidenzia una discontinuità nella pendenza della curva nel punto considerato. Un esempio fornito nel testo illustra un punto angoloso nel diagramma cartesiano della funzione f(x) = |lnx| nel punto P(1, 0). L'analisi dei punti angolosi mostra come la derivabilità possa essere compromessa anche in situazioni dove la funzione è continua, sottolineando la complessità e la ricchezza del concetto di derivabilità.
4. Cuspidi Un Secondo Tipo di Non Derivabilità
La sezione prosegue descrivendo un altro tipo di punto di non derivabilità: la cuspide. In presenza di una cuspide, i limiti del rapporto incrementale da sinistra e da destra sono entrambi infiniti, ma con segni opposti. Se la derivata sinistra tende a +∞ e quella destra a -∞, si ha una cuspide rivolta verso il basso; se i segni sono invertiti, la cuspide è rivolta verso l'alto. La funzione f(x) = ³√x fornisce un esempio di cuspide. Questo caso evidenzia situazioni in cui la tangente alla curva diventa verticale, o tende all'infinito, in un determinato punto del dominio, illustrando un ulteriore aspetto della non derivabilità.
5. Flessi a Tangente Verticale Un Terzo Tipo di Non Derivabilità
Infine, la sezione considera i flessi a tangente verticale come un terzo tipo di punto di non derivabilità. In questo caso, sia la derivata sinistra che la derivata destra tendono a +∞ (o entrambi a -∞), indicando un punto di cambiamento di concavità con tangente verticale. L'analisi di questi tre tipi di punti di non derivabilità – punti angolosi, cuspidi e flessi a tangente verticale – fornisce una classificazione completa delle situazioni in cui una funzione continua può non essere derivabile, sottolineando la necessità di un'analisi approfondita del comportamento locale della funzione per una sua comprensione completa. Queste distinzioni sono fondamentali per una corretta analisi del comportamento delle funzioni e per la loro rappresentazione grafica.
III.Teoremi Fondamentali del Calcolo Differenziale
Vengono presentati alcuni dei teoremi fondamentali del calcolo differenziale: il Teorema di Rolle, il Teorema di Lagrange (o del valor medio), e il Teorema di Cauchy (degli incrementi finiti). Ogni teorema viene brevemente descritto, evidenziando il suo significato geometrico e la sua importanza nell'analisi delle funzioni derivabili. Il Teorema di Fermat sulle funzioni con derivata nulla è anch'esso menzionato.
1. Teorema di Rolle
Il teorema di Rolle, attribuito a U. Dini nella sua dimostrazione del 1878, afferma che data una funzione reale continua in un intervallo chiuso e limitato [a, b], derivabile nei punti interni, e tale che f(a) = f(b), allora esiste almeno un punto ξ interno ad [a, b] in cui la derivata si annulla: f'(ξ) = 0. La dimostrazione considera il caso banale di una funzione costante e il caso in cui la funzione non è costante. Nel secondo caso, per il teorema di Weierstrass, la funzione ammette un massimo e un minimo. Se almeno uno di questi è interno all'intervallo, la derivata in quel punto deve essere zero. Il teorema di Rolle ha una forte interpretazione geometrica: se una funzione assume lo stesso valore agli estremi di un intervallo, deve esistere almeno un punto interno in cui la retta tangente è orizzontale.
2. Teorema di Lagrange del Valor Medio
Il teorema di Lagrange, o del valor medio, afferma che data una funzione reale continua in un intervallo chiuso e limitato [a, b] e derivabile nei punti interni, esiste almeno un punto ξ interno ad [a, b] tale che f'(ξ) = [f(b) - f(a)] / (b - a). Geometricamente, questo significa che esiste almeno un punto in cui la pendenza della retta tangente è uguale alla pendenza della retta secante che congiunge i punti (a, f(a)) e (b, f(b)). La dimostrazione del teorema si basa sulla costruzione di una funzione ausiliaria che soddisfa le ipotesi del teorema di Rolle, permettendo di dedurre l'esistenza del punto ξ. Il teorema di Lagrange è fondamentale per l'analisi delle funzioni e per dimostrare altri teoremi importanti del calcolo differenziale.
3. Teorema di Cauchy degli Incrementi Finiti
Il teorema di Cauchy, o degli incrementi finiti, generalizza il teorema di Lagrange a due funzioni. Date due funzioni reali f e g continue in [a, b] e derivabili nei punti interni, con g'(x) ≠ 0 per ogni x nell'intervallo aperto (a, b), esiste almeno un punto ξ interno ad [a, b] tale che [f(b) - f(a)] / [g(b) - g(a)] = f'(ξ) / g'(ξ). Geometricamente, questo significa che esiste almeno una retta tangente alla curva (f(x), g(x)) che è parallela alla retta che congiunge i punti (f(a), g(a)) e (f(b), g(b)). Il teorema di Cauchy fornisce un risultato potente per l'analisi di rapporti di funzioni e ha importanti applicazioni nel calcolo dei limiti.
4. Teorema di Fermat Funzioni con Derivata Nulla
Il teorema di Fermat sulle funzioni con derivata nulla afferma che se una funzione f è derivabile in un punto x₀ interno ad un intervallo I, e x₀ è un punto di massimo o minimo relativo per f, allora f'(x₀) = 0. La dimostrazione di questo teorema si basa sul teorema di Lagrange applicato ad intervalli opportunamente scelti intorno a x₀. Questo teorema fornisce una condizione necessaria (ma non sufficiente) per l'esistenza di un estremo relativo. In altre parole, se una funzione ha un massimo o un minimo in un punto interno del suo dominio e in quel punto è derivabile, allora la derivata deve essere nulla in quel punto. La condizione f'(x₀) = 0 è necessaria ma non sufficiente per la presenza di un massimo o minimo relativo, in quanto potrebbero esistere punti in cui la derivata è zero ma non ci sono estremi relativi (ad esempio, punti di flesso).
IV. Funzioni Crescenti Decrescenti Convesse e Concave
Il documento esplora le proprietà delle funzioni crescenti e decrescenti, fornendo le condizioni necessarie e sufficienti per la loro monotonia. Si procede poi con l'analisi delle funzioni convesse e concave, definendo le loro caratteristiche geometriche e fornendo le condizioni di derivabilità necessarie e sufficienti per la loro identificazione. L'utilizzo della derivata seconda è fondamentale in questa sezione.
1. Funzioni Crescenti e Decrescenti Condizioni Necessarie e Sufficienti
La sezione inizia definendo formalmente le funzioni crescenti e decrescenti (strettamente crescenti e strettamente decrescenti) in un sottoinsieme X di R. Vengono poi presentate le condizioni necessarie e sufficienti per la monotonia di una funzione: una funzione è monotona crescente (rispettivamente decrescente) in X se e solo se soddisfa determinate disuguaglianze. Si introduce poi un teorema che enuncia una condizione necessaria per la monotonia: se una funzione f è monotona crescente (rispettivamente decrescente) in X, allora la sua derivata f'(x) è maggiore o uguale a 0 (rispettivamente minore o uguale a 0) in ogni punto di X in cui la derivata esiste. Questa condizione, sebbene necessaria, non è sufficiente a garantire la monotonia della funzione.
2. Condizioni per l Esistenza di Minimi e Massimi Relativi
La sezione prosegue analizzando le condizioni necessarie e sufficienti per l'esistenza di un minimo o massimo relativo di una funzione. Viene enunciato un teorema che fornisce una condizione necessaria: se una funzione f è dotata di derivata sinistra (rispettivamente destra) in un punto x₀ che è di accumulazione a sinistra (rispettivamente a destra) per il dominio della funzione, e se x₀ è un punto di minimo o massimo relativo, allora la derivata sinistra (rispettivamente destra) deve essere nulla. Un altro teorema stabilisce una condizione sufficiente: se x₀ è un punto di accumulazione solo a destra per il dominio, e la funzione è dotata di derivata in x₀, allora se f'(x₀) > 0 (rispettivamente f'(x₀) < 0), f ha un minimo (rispettivamente massimo) relativo stretto in x₀. Questi teoremi forniscono strumenti per identificare punti di minimo e massimo relativi, cruciali per l'analisi del comportamento di una funzione.
3. Funzioni Convesse e Concave Definizione e Caratterizzazione
La parte finale della sezione introduce il concetto di funzioni convesse e concave. Una funzione è convessa (rispettivamente concava) in un intervallo X se, per ogni coppia di punti x' e x'' in X con x' < x'', tutti i punti del grafico di f con ascissa x ∈ (x', x'') sono al di sotto (rispettivamente al di sopra) della retta congiungente (x', f(x')) e (x'', f(x'')). Il testo quindi fornisce una caratterizzazione delle funzioni convesse e concave derivabili: una funzione f derivabile è convessa (rispettivamente concava) in X se e solo se il suo grafico è sempre al di sopra (rispettivamente al di sotto) della retta tangente in ogni punto. Infine, vengono presentate le condizioni per funzioni derivabili due volte: una funzione f derivabile due volte è convessa (rispettivamente concava) in X se e solo se la sua derivata seconda f''(x) è maggiore o uguale a 0 (rispettivamente minore o uguale a 0) per ogni x ∈ X. Queste caratterizzazioni forniscono strumenti analitici per determinare la convessità o concavità di una funzione.
V.Il Teorema di De L Hôpital
Infine, il documento introduce il potente Teorema di De L'Hôpital, utile per risolvere i limiti che si presentano sotto forma indeterminata (0/0 o ∞/∞). Questo teorema offre uno strumento fondamentale per il calcolo dei limiti nel contesto del calcolo differenziale.
1. Enunciato del Teorema di De L Hôpital
Il documento presenta il teorema di De L'Hôpital come uno strumento per risolvere limiti di rapporti di funzioni che si presentano nella forma indeterminata 0/0 o ∞/∞. Il teorema afferma che se il limite del rapporto f(x)/g(x) per x che tende a x₀ è una forma indeterminata di questo tipo, e se esiste il limite del rapporto delle derivate f'(x)/g'(x) per x che tende a x₀, allora anche il limite del rapporto originale f(x)/g(x) esiste ed è uguale al limite del rapporto delle derivate. Questo teorema fornisce un metodo potente per semplificare il calcolo di limiti complessi, riducendo l'indeterminazione tramite la derivazione delle funzioni coinvolte. La condizione g'(x) ≠ 0 per x ≠ x₀ è implicita nell'enunciato, garantendo che la derivata al denominatore non si annulli nell'intorno del punto in esame, evitando ulteriori forme indeterminate.
2. Applicazione del Teorema per Rimuovere l Indeterminatezza
L'applicazione del teorema di De L'Hôpital si concentra sulla capacità di rimuovere l'indeterminazione presente nel limite di un rapporto di funzioni. Quando ci si trova di fronte a forme indeterminate del tipo 0/0 o ∞/∞, l'applicazione del teorema prevede il calcolo del limite del rapporto delle derivate delle funzioni numeratore e denominatore. Se il limite di questo nuovo rapporto esiste, esso rappresenta anche il limite del rapporto originale. Questo procedimento può essere iterato se anche il rapporto delle derivate presenta una forma indeterminata. L'efficacia del teorema risiede nella sua capacità di trasformare un limite complesso in un limite spesso più semplice da calcolare, sfruttando le proprietà delle derivate per semplificare l'espressione e rimuovere l'indeterminazione iniziale.
