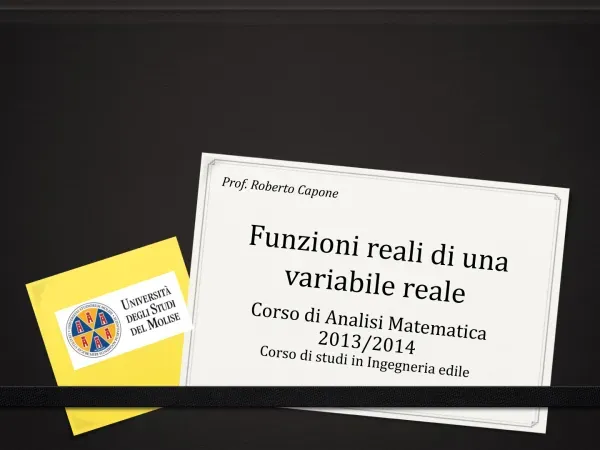
Funzioni: Definizione e Tipi
Informazioni sul documento
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 2.53 MB |
| Specialità | Matematica |
| Tipo di documento | Slide di lezione (pdf) |
Riassunto
I.Definizione di Funzione e Insiemi Relativi
Il documento introduce il concetto di funzione matematica, definendola come una relazione che associa ad ogni elemento di un insieme di definizione (dominio) un unico elemento di un insieme di arrivo (codominio). Vengono introdotti i concetti di funzione iniettiva (ogni elemento del codominio ha al massimo una controimmagine nel dominio), funzione suriettiva (ogni elemento del codominio ha almeno una controimmagine nel dominio), e funzione biettiva (funzione sia iniettiva che suriettiva). Si discute inoltre dell'importanza del dominio e del codominio nella definizione di una funzione.
1. Introduzione al Concetto di Funzione
Il testo inizia introducendo il termine 'funzione', che, sebbene presente già negli scritti di Leibniz (1646-1716), inizialmente si riferiva a espressioni analitiche che descrivevano la dipendenza di una quantità numerica da altre. Solo successivamente, nel secolo scorso, la nozione ha raggiunto la sua formulazione definitiva, più generale e astratta. Questa evoluzione storica sottolinea l'importanza di comprendere la definizione moderna e rigorosa del concetto di funzione, che va oltre le semplici espressioni analitiche del passato. L'evoluzione del concetto di funzione evidenzia il progresso della matematica nel formalizzare e generalizzare concetti inizialmente più intuitivi o limitati a contesti specifici. Questa progressione verso una definizione più rigorosa e ampia è fondamentale per la comprensione della matematica moderna e delle sue applicazioni.
2. Dominio e Codominio di una Funzione
Un elemento chiave nella definizione di una funzione è la specificazione del suo dominio e codominio. L'insieme X, definito come insieme di definizione o dominio della funzione f, rappresenta l'insieme di tutti i possibili valori di input per la funzione. Il sottoinsieme T, chiamato insieme dei valori o codominio, contiene tutti gli elementi che sono immagine di elementi del dominio attraverso la funzione f. La chiara distinzione tra dominio e codominio è fondamentale perché definisce completamente l'ambito di applicazione e il range di output della funzione. Una funzione ben definita richiede sempre la specificazione precisa sia del suo dominio che del suo codominio, evitando ambiguità nella sua interpretazione e applicazione. La comprensione di questi due insiemi è essenziale per analizzare le proprietà e il comportamento di una funzione.
3. Funzioni Iniettive Suriettive e Biunivoche
Il documento prosegue definendo tre tipi cruciali di funzioni: iniettive, suriettive e biunivoche. Una funzione f: X ⊆ S → T è iniettiva se ogni elemento del codominio T ha al massimo una controimmagine in S, ovvero se elementi distinti nel dominio vengono mappati in elementi distinti nel codominio. Per dimostrare che una funzione reale di variabile reale non è iniettiva, basta trovare due elementi distinti x1 e x2 nel dominio tali che f(x1) = f(x2). Una funzione è suriettiva se ogni elemento del codominio T ha almeno una controimmagine in S. Infine, una funzione è biunivoca (o biettiva) se è sia iniettiva che suriettiva, garantendo una corrispondenza uno-a-uno tra dominio e codominio. La distinzione tra questi tipi di funzioni è fondamentale per comprendere le loro proprietà e le loro applicazioni in diversi contesti matematici. La classificazione di una funzione in base a queste proprietà aiuta a determinarne le caratteristiche e le possibili trasformazioni o operazioni applicabili.
II. Funzione Inversa
Si definisce la funzione inversa solo per le funzioni biettive. Essa inverte l'associazione definita dalla funzione originale. I grafici di una funzione biettiva e della sua inversa sono simmetrici rispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrante.
1. Definizione di Funzione Inversa
La sezione introduce il concetto di funzione inversa, specificando che essa è definita solo per funzioni biettive (sia iniettive che suriettive). Data una funzione biettiva f definita in una parte X di S e a valori nell'insieme T, la sua funzione inversa, indicata con f⁻¹, è definita in f(X) (l'immagine di X attraverso f) e a valori in S. f⁻¹ associa ad ogni elemento y di f(X) quell'unico elemento x di X tale che y = f(x). Questa definizione sottolinea la relazione biunivoca tra la funzione originale e la sua inversa: ogni elemento del codominio di f è associato ad un unico elemento del dominio, e viceversa tramite la funzione inversa. La condizione di biettività è essenziale, poiché garantisce l'esistenza e l'unicità dell'inversa. L'esistenza di un'inversa è una proprietà cruciale per alcune operazioni matematiche e per la soluzione di equazioni.
2. Rappresentazione Grafica della Funzione Inversa
Un aspetto importante della funzione inversa riguarda la sua rappresentazione grafica. Il testo evidenzia che i grafici di una funzione biettiva f e della sua inversa f⁻¹ sono simmetrici rispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrante. Questa simmetria grafica riflette la relazione di inversione tra le due funzioni: se un punto (x, y) appartiene al grafico di f, allora il punto (y, x) appartiene al grafico di f⁻¹. Questa proprietà semplifica la costruzione del grafico della funzione inversa a partire dal grafico della funzione originale. Basta, infatti, scambiare le coordinate x e y di ogni punto del grafico di f per ottenere il grafico di f⁻¹. Questa osservazione fornisce un metodo visivamente intuitivo per comprendere e rappresentare la funzione inversa.
III.Restrizione e Prolungamento di una Funzione
Il documento descrive le operazioni di restrizione (limitazione del dominio) e di prolungamento (estensione del dominio) di una funzione, mantenendo la coerenza della relazione.
1. Restrizione di una Funzione
La restrizione di una funzione è un'operazione che consiste nel limitare il dominio della funzione ad un sottoinsieme. Se una funzione f è definita su un insieme X e assume valori in un insieme T, e X' è un sottoinsieme non vuoto di X, allora la restrizione di f a X', indicata spesso come f|X', è una nuova funzione definita solo su X'. Questa nuova funzione f|X' associa ad ogni elemento x di X' lo stesso valore che assume la funzione f originale. In sostanza, la restrizione mantiene il comportamento della funzione originale ma solo su una porzione più piccola del suo dominio. Questo processo è utile quando si vuole studiare il comportamento di una funzione in un intervallo specifico, o quando si vuole creare una nuova funzione con un dominio più ristretto, semplificando l'analisi o evitando comportamenti indesiderati. La restrizione è un'operazione fondamentale nell'analisi matematica e trova applicazione in numerosi contesti.
2. Prolungamento di una Funzione
Il prolungamento di una funzione, al contrario della restrizione, estende il dominio della funzione ad un insieme più ampio. Considerando due insiemi S e T, un sottoinsieme X' di S, e una funzione g definita su X' a valori in T, un prolungamento di g su un insieme X (che contiene X') è una nuova funzione f definita su X e a valori in T. La condizione essenziale è che la restrizione di f a X' coincida con g, ovvero che f(x) = g(x) per ogni x in X'. Il prolungamento di una funzione introduce quindi una nuova funzione che mantiene il comportamento della funzione originale su un dominio più ristretto, ma lo estende in modo coerente ad un dominio più grande. Questo può essere utile quando si vuole estendere il dominio di una funzione in modo naturale, o per definire una funzione in modo completo su un intervallo più ampio. Le diverse scelte di prolungamento possono portare a funzioni con caratteristiche differenti.
IV. Funzioni Crescenti Decrescenti e Monotone
Vengono definite le funzioni crescenti (in senso stretto e lato), decrescenti (in senso stretto e lato), e monotone (crescenti o decrescenti), specificando il comportamento della funzione all'interno di un intervallo del suo dominio.
1. Funzioni Crescenti in Senso Stretto e Lato
La sezione definisce le funzioni crescenti, distinguendo tra crescita in senso stretto e in senso lato. Una funzione y = f(x) è crescente in senso stretto in un intervallo I, sottoinsieme del suo dominio, se per ogni coppia di elementi x1 e x2 appartenenti ad I, con x1 < x2, risulta f(x1) < f(x2). Questa condizione indica che la funzione assume valori sempre maggiori al crescere della variabile indipendente. La definizione di funzione crescente in senso lato (o non decrescente) è simile, ma la disuguaglianza diventa f(x1) ≤ f(x2), permettendo l'uguaglianza tra i valori della funzione per elementi distinti del dominio. La distinzione tra senso stretto e senso lato è importante perché riflette diversi livelli di monotonicità. Una funzione strettamente crescente è sempre iniettiva, mentre una funzione non decrescente può non esserlo.
2. Funzioni Decrescenti in Senso Stretto e Lato
Analogamente alle funzioni crescenti, vengono definite le funzioni decrescenti, sia in senso stretto che lato. Una funzione y = f(x) è decrescente in senso stretto in un intervallo I se, per ogni coppia di elementi x1 e x2 appartenenti ad I, con x1 < x2, risulta f(x1) > f(x2). In questo caso, la funzione assume valori sempre minori al crescere della variabile indipendente. La definizione di funzione decrescente in senso lato (o non crescente) ammette l'uguaglianza, ovvero f(x1) ≥ f(x2). Come per le funzioni crescenti, la distinzione tra senso stretto e lato è cruciale per la caratterizzazione del comportamento della funzione. Una funzione strettamente decrescente è sempre iniettiva, mentre una funzione non crescente può non esserlo.
3. Funzioni Monotone
Il concetto di funzione monotona racchiude le funzioni crescenti e decrescenti. Una funzione è monotona in senso stretto in un intervallo se è strettamente crescente o strettamente decrescente in quell'intervallo. Analogamente, una funzione è monotona in senso lato se è non crescente o non decrescente. La proprietà di monotonicità è fondamentale nell'analisi delle funzioni, in quanto fornisce informazioni sul loro comportamento e sulla loro invertibilità. Le funzioni monotone strettamente hanno la proprietà di essere iniettive, una caratteristica essenziale per l'esistenza della funzione inversa. La classificazione di una funzione come monotona semplifica l'analisi del suo andamento e delle sue proprietà.
V. Funzioni Pari e Dispari
Si introducono le funzioni pari [f(-x) = f(x)] e le funzioni dispari [f(-x) = -f(x)], caratterizzate da specifiche simmetrie rispetto all'asse y.
1. Funzioni Pari
La sezione definisce una funzione pari come una funzione y = f(x) tale che f(-x) = f(x) per ogni x appartenente al suo dominio X, che deve essere simmetrico rispetto all'origine (se x appartiene a X, allora anche -x deve appartenere a X). Questa condizione implica che il grafico di una funzione pari è simmetrico rispetto all'asse delle ordinate (asse y). La simmetria del grafico rispetto all'asse y è una caratteristica fondamentale delle funzioni pari, che semplifica l'analisi del loro comportamento. La conoscenza della funzione per valori positivi di x è sufficiente per determinare i valori corrispondenti per i valori negativi. Questa proprietà trova ampia applicazione nello studio di diverse funzioni matematiche e nella risoluzione di problemi.
2. Funzioni Dispari
Analogamente alle funzioni pari, il testo definisce le funzioni dispari. Una funzione y = f(x) è dispari se soddisfa la condizione f(-x) = -f(x) per ogni x nel suo dominio X, che, come per le funzioni pari, deve essere simmetrico rispetto all'origine. Questa proprietà implica che il grafico di una funzione dispari è simmetrico rispetto all'origine. La simmetria rispetto all'origine è una caratteristica distintiva delle funzioni dispari, che, come la simmetria rispetto all'asse y per le funzioni pari, semplifica l'analisi del loro comportamento. La conoscenza della funzione per valori positivi di x permette di determinare i valori corrispondenti per i valori negativi, cambiando di segno. Questa proprietà è utile nello studio di specifici tipi di funzioni e nella risoluzione di problemi matematici.
VI.Esempi di Funzioni Potenza Esponenziale Logaritmo e Altre
Il testo presenta esempi di diverse tipologie di funzioni, tra cui funzioni potenza (con esponente intero positivo, negativo e reale), funzioni esponenziali, funzioni logaritmiche, la funzione parte intera, la funzione signum, e funzioni trigonometriche (tangente, seno). Vengono inoltre descritte le funzioni iperboliche, evidenziando le differenze con le funzioni trigonometriche (in particolare la mancanza di periodicità).
1. Funzioni Potenza
La sezione illustra le funzioni potenza, distinguendo diversi casi a seconda dell'esponente. Se n è un intero positivo, la funzione potenza è definita come f(x) = xⁿ per ogni x reale. Se n è pari, la funzione è definita su tutto R, e le sue restrizioni agli intervalli (-∞, 0) e (0, +∞) sono rispettivamente strettamente decrescente e strettamente crescente. Se n è un intero negativo (-n), la funzione potenza è definita come f(x) = x⁻ⁿ = 1/xⁿ per ogni x reale diverso da zero. Se n è pari, la funzione ha codominio (0, +∞) ed è strettamente crescente in (-∞, 0) e strettamente decrescente in (0, +∞). Infine, se α è un numero reale non nullo, la funzione potenza è definita come f(x) = xα, generalizzando ulteriormente il concetto.
2. Funzione Radice n esima
Come caso particolare delle funzioni potenza, viene introdotta la funzione radice n-esima. Se n è pari, la restrizione della funzione xⁿ all'intervallo [0, +∞) è strettamente crescente e quindi invertibile. La sua inversa è la funzione radice n-esima, f(x) = ⁿ√x, definita per x ∈ [0, +∞). Questa funzione rappresenta l'inversa della funzione potenza con esponente pari, ristretta ai numeri reali non negativi. La sua definizione evidenzia la relazione inversa tra la potenza e la radice di ordine n, sottolineando l'importanza della restrizione del dominio per garantire l'invertibilità.
3. Funzioni Esponenziale e Logaritmo
La sezione presenta le funzioni esponenziale e logaritmo, due funzioni inverse l'una dell'altra. Se 'a' è un numero reale positivo e diverso da 1, la funzione esponenziale di base 'a' è definita come f(x) = aˣ per ogni x reale. La funzione logaritmo di base 'a' è definita come f(x) = logₐx per ogni x ∈ (0, +∞). Queste due funzioni sono fondamentali in molti campi della matematica e delle sue applicazioni, e la loro relazione di inversione è una proprietà cruciale per la loro manipolazione e utilizzo nelle equazioni e nei problemi matematici. Le loro proprietà di crescita e decrescimento dipendono dal valore di 'a'.
4. Altre Funzioni Signum e Parte Intera
Infine, vengono introdotte altre funzioni importanti, tra cui la funzione parte intera e la funzione signum. La funzione parte intera, indicata con ⌊x⌋, associa ad ogni numero reale x il più grande intero minore o uguale ad x se x ≥ 0 e il più piccolo intero maggiore o uguale ad x se x < 0. La funzione signum, invece, restituisce -1 se x < 0, 0 se x = 0, e 1 se x > 0. Queste funzioni, seppur semplici nella definizione, sono strumenti importanti nell'analisi matematica e trovano applicazioni in diversi contesti, illustrando come anche funzioni apparentemente semplici possono avere un ruolo significativo in diversi problemi matematici e computazionali. La loro introduzione completa la panoramica sulle diverse tipologie di funzioni.
5. Funzioni Iperboliche
Il documento introduce le funzioni iperboliche, una famiglia di funzioni speciali con proprietà analoghe alle funzioni trigonometriche, ma con importanti differenze. A differenza delle funzioni trigonometriche, le funzioni iperboliche non sono periodiche. L'argomento t delle funzioni iperboliche rappresenta due volte l'area del settore compreso tra l'origine, il punto (cosht, sinht) sull'iperbole equilatera x² - y² = 1, l'arco di iperbole e il segmento sull'asse x. Questa definizione geometrica evidenzia la relazione tra le funzioni iperboliche e l'iperbole equilatera, analogamente a come le funzioni trigonometriche sono correlate alla circonferenza unitaria. La loro non periodicità le distingue dalle funzioni trigonometriche, aprendo a un diverso tipo di comportamento e applicazioni.
VII. Funzioni Periodiche e Calcolo del Periodo
Il documento definisce le funzioni periodiche, caratterizzate dalla ripetizione dei valori a intervalli regolari (periodo T). Si illustra il metodo per il calcolo del periodo, anche nel caso di periodi frazionari.
1. Definizione di Funzione Periodica
La sezione introduce il concetto di funzione periodica. Una funzione y = f(x) è periodica di periodo T (con T > 0) se, per qualsiasi numero intero k, si ha f(x) = f(x + kT). Questo significa che il valore della funzione si ripete ad intervalli regolari di ampiezza T. Il periodo T rappresenta la lunghezza dell'intervallo dopo il quale la funzione ripete il suo andamento. La definizione sottolinea l'importanza del periodo T, che caratterizza completamente il comportamento ripetitivo della funzione. Funzioni periodiche si trovano in molti ambiti della matematica e della fisica, ad esempio nelle funzioni trigonometriche (seno e coseno), e la loro periodicità semplifica lo studio del loro andamento.
2. Esempi di Funzioni Periodiche
Il testo fornisce esempi di funzioni periodiche, come la funzione seno (sen(x)), che ha un periodo di 2π [sen(x) = sen(x + 2kπ)], e la funzione tangente (tg(x)), che ha un periodo di π [tg(x) = tg(x + kπ)]. Questi esempi mostrano come diverse funzioni possono avere periodi diversi, sottolineando la variabilità di questa caratteristica nelle funzioni periodiche. L'analisi di questi esempi aiuta a comprendere l'applicazione pratica della definizione di funzione periodica e a visualizzare graficamente il concetto di ripetizione del valore della funzione a intervalli regolari. La scelta del periodo influisce sull'andamento e sul grafico della funzione.
3. Calcolo del Periodo di Funzioni Periodiche
La sezione affronta il problema del calcolo del periodo di una funzione periodica, soprattutto nei casi in cui i periodi presentano una forma frazionaria. Si indica che, se una funzione f: X ⊆ R → R è periodica in X di periodo T, allora l'insieme X deve soddisfare la proprietà x ∈ X ⇒ x + kT ∈ X per ogni intero k. Inoltre, la funzione deve soddisfare l'uguaglianza f(x) = f(x + kT). Nel caso di periodi frazionari multipli, per calcolare il minimo comune multiplo (m.c.m.) dei periodi, si suggerisce di esprimere i periodi con frazioni aventi lo stesso denominatore, calcolare l'm.c.m. dei numeratori e dividerlo per il denominatore comune. Questo metodo fornisce un approccio sistematico per determinare il periodo di una funzione periodica con periodi frazionari.
VIII. Funzioni Composte e Traslazioni
Si introduce il concetto di funzioni composte, ottenute combinando due o più funzioni, e si spiega l'effetto delle traslazioni sul grafico di una funzione.
1. Funzioni Composte Definizione e Operazione
La sezione introduce il concetto di funzione composta. Date due funzioni, f: A → B e g: B → C, la funzione composta, indicata con g(f(x)), è una nuova funzione che mappa gli elementi di A in C. A ogni x in A viene associata l'immagine di x mediante f, e poi l'immagine di questo risultato mediante g. In sostanza, la funzione composta applica prima la funzione f e poi la funzione g. Questo processo crea una nuova funzione che combina le trasformazioni delle due funzioni originali, creando una funzione più complessa ottenuta dall'applicazione sequenziale di due o più funzioni elementari. Questo concetto è fondamentale per costruire funzioni più elaborate a partire da funzioni più semplici.
2. Traslazione del Grafico di una Funzione
La sezione descrive l'effetto di una traslazione sul grafico di una funzione. Una traslazione del grafico di una funzione secondo un vettore v = (a, b) sposta ogni punto del grafico di 'a' unità lungo l'asse x e di 'b' unità lungo l'asse y. Questa trasformazione geometrica modifica la posizione del grafico senza alterarne la forma. Un esempio viene fornito con la funzione y = 4x², il cui grafico viene traslato secondo un vettore non specificato nel testo. L'applicazione di una traslazione è una trasformazione geometrica semplice ma fondamentale, che permette di modificare la posizione del grafico di una funzione mantenendone inalterata la forma. Questa trasformazione è utile per analizzare e confrontare funzioni diverse.
IX.Estremi di una Funzione Reale di Variabile Reale
Si definiscono gli estremi (minimo e massimo) di una funzione reale di variabile reale, specificando le condizioni per la loro esistenza e introducendo i concetti di limitatezza inferiore e superiore.
1. Minimo e Massimo di una Funzione
La sezione definisce il concetto di minimo e massimo di una funzione reale f definita su un sottoinsieme X di R. Una funzione f possiede un minimo (rispettivamente massimo) in X se il suo codominio f(X) possiede un minimo (rispettivamente massimo). Equivalentemente, esiste un elemento x (rispettivamente x) in X tale che f(x) ≤ f(x) per ogni x in X (rispettivamente f(x) ≥ f(x) per ogni x in X). Il minimo (o massimo) di f(x) viene chiamato minimo (o massimo) della funzione f in X e si indica con min f o max f. Questa definizione formalizza i concetti intuitivi di minimo e massimo, collegandoli all'esistenza di un elemento nel codominio che sia il più piccolo (o il più grande) rispetto agli altri.
2. Funzioni Limitata Inferiormente Superiormente e Limitata
La sezione introduce i concetti di funzioni limitate inferiormente, superiormente e limitate. Una funzione f è limitata inferiormente in X se esiste un numero reale k tale che k ≤ f(x) per ogni x in X. Analogamente, f è limitata superiormente in X se esiste un numero reale k tale che f(x) ≤ k per ogni x in X. k è detto minorante (maggiorante) di f in X. Una funzione è limitata in X se è limitata sia inferiormente che superiormente. Queste definizioni caratterizzano il comportamento della funzione in termini di limitazione dei suoi valori, fornendo informazioni sulla sua crescita o decrescita. L'esistenza di un minorante o maggiorante indica una restrizione nell'intervallo dei valori assunti dalla funzione.
3. Estremo Inferiore e Superiore di una Funzione
Se una funzione f è limitata inferiormente (rispettivamente superiormente) in X, l'estremo inferiore (rispettivamente superiore) di f in X, indicato con inf f o sup f, rappresenta il più grande dei minoranti (rispettivamente il più piccolo dei maggioranti). Questa definizione precisa il concetto di limite inferiore e superiore, fornendo un valore numerico che rappresenta il confine inferiore o superiore dei valori assunti dalla funzione. Inf e Sup sono concetti importanti nell'analisi matematica e forniscono informazioni cruciali sul comportamento delle funzioni, in particolare nel caso di funzioni non limitate.
