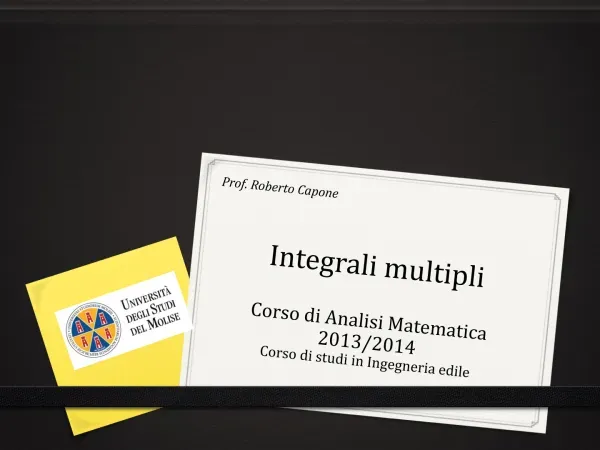
Somme di Riemann: Calcolo Volumi
Informazioni sul documento
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 1.31 MB |
| Specialità | Calcolo |
Riassunto
I.Somme di Riemann e Approssimazione del Volume
Questo documento tratta il concetto fondamentale delle Somme di Riemann come metodo per approssimare il volume di un solido. Si inizia considerando una funzione f definita su un rettangolo, e si suddivide il rettangolo in sottorettangoli. Il volume del solido è approssimato dalla somma dei volumi di parallelepipedi costruiti su ciascun sottorettangolo, con altezza data da f(x,y). Passando al limite, con la suddivisione sempre più fine, si ottiene l'integrale doppio, che rappresenta il volume esatto. L'uso delle Somme di Riemann permette di passare da un problema discreto ad uno continuo, fondamentale per molte applicazioni.
1. Introduzione alle Somme di Riemann per il Calcolo del Volume
La sezione introduce il concetto di Somme di Riemann per approssimare il volume di un solido, estendendo l'idea del calcolo dell'area sottesa ad una curva. Si considera una funzione f, definita e limitata su un rettangolo chiuso e limitato R. Inizialmente, si assume che la funzione sia positiva. Il solido V considerato è compreso tra il rettangolo R e il grafico di f, definito come V = {(x, y, z) ∈ R³ : a ≤ x ≤ b, c ≤ y ≤ d, 0 ≤ z ≤ f(x, y)}. Il primo passo cruciale consiste nel suddividere il rettangolo R in sottorettangoli. Questo si ottiene dividendo l'intervallo [a, b] in n sottointervalli [xᵢ₋₁, xᵢ] con n+1 punti a = x₀ < x₁ < x₂ < ... < xₙ = b, e analogamente l'intervallo [c, d] in m sottointervalli [yⱼ₋₁, yⱼ] con m+1 punti c = y₀ < y₁ < y₂ < ... < yₘ = d. La combinazione di queste suddivisioni crea una partizione di R in n * m sottorettangoli. Questa suddivisione è fondamentale per l'approssimazione del volume tramite le somme di Riemann.
2. Definizione e Calcolo delle Somme di Riemann
Si procede definendo formalmente le somme di Riemann. Si sceglie un punto base (xᵢⱼ*, yᵢⱼ*) in ognuno dei rettangoli Rᵢⱼ della partizione. Si considera poi un parallelepipedo con base Rᵢⱼ e altezza f(xᵢⱼ*, yᵢⱼ*). Il volume di questo parallelepipedo è dato dal prodotto dell'area di base per l'altezza: f(xᵢⱼ*, yᵢⱼ*) * Aᵢⱼ, dove Aᵢⱼ è l'area del sottorettangolo Rᵢⱼ. Ripetiamo questo processo per ogni sottorettangolo e sommiamo i volumi dei parallelepipedi ottenuti. Questa somma è un'approssimazione del volume totale di V. Formalmente, la somma di Riemann della funzione f, corrispondente alla suddivisione di R nei sottorettangoli Rᵢⱼ e alla scelta dei punti base (xᵢⱼ*, yᵢⱼ*) ∈ Rᵢⱼ, è definita come la somma ∑ᵢⱼ f(xᵢⱼ*, yᵢⱼ*) * Aᵢⱼ. Oltre alla somma di Riemann, vengono introdotte anche la somma inferiore e la somma superiore, relative alla partizione P, utili per definire il concetto di integrabilità.
3. Convergenza delle Somme di Riemann e Integrabilità
La sezione approfondisce la convergenza delle somme di Riemann. Si afferma che le somme di Riemann della funzione f convergono al limite S quando l'ampiezza della suddivisione tende a zero. Formalmente, fissato un ε > 0, si deve poter trovare un δ > 0 tale che, per ogni suddivisione di ampiezza δ(P) < δ e per ogni scelta dei punti base xᵢⱼ*, yᵢⱼ*, la somma di Riemann corrispondente sia vicina a S entro ε. Le somme inferiori e superiori rappresentano approssimazioni per difetto e per eccesso del volume V. Se il limite delle somme di Riemann esiste, la funzione f si dice integrabile sul rettangolo. In questo caso, il volume (con segno) della regione solida V compresa tra il grafico di z = f(x, y) e il rettangolo R è dato dal valore del limite. Per funzioni positive, l'integrale definisce il volume del solido: f ≥ 0 ⇒ Volume V = ∫∫ f(x, y) dx dy. Un teorema fondamentale stabilisce che una funzione limitata è integrabile sul rettangolo se e solo se l'estremo superiore delle somme inferiori è uguale all'estremo inferiore delle somme superiori, e questi valori sono uguali all'integrale doppio.
II.Integrali Doppi su Rettangoli
La sezione si concentra sul calcolo degli integrali doppi su rettangoli. Si spiega che, sebbene la definizione si basi sulle Somme di Riemann, in pratica si usa la tecnica di riduzione a integrali iterati. Questo metodo semplifica notevolmente il calcolo, riducendolo a due integrali semplici successivi. Il risultato dell'integrale doppio rappresenta il volume (con segno) della regione compresa tra il grafico della funzione e il rettangolo di integrazione. La continuità della funzione f garantisce l'esistenza dell'integrale doppio.
1. Calcolo degli Integrali Doppi su Rettangoli Metodo Pratico
Questa sezione del documento si concentra sul metodo pratico per il calcolo degli integrali doppi su rettangoli. Mentre la definizione teorica si basa sulle somme di Riemann, il testo sottolinea che nella pratica il calcolo effettivo si esegue raramente utilizzando direttamente la definizione. Invece, si preferisce un approccio che riduce il problema a due integrali semplici successivi. Questa riduzione si ottiene tramite l'integrazione iterata, un metodo che semplifica notevolmente il processo di calcolo. L'integrazione iterata sfrutta la proprietà di poter integrare prima rispetto ad una variabile e poi rispetto all'altra, trattando la variabile non ancora integrata come una costante. Questo procedimento facilita notevolmente il calcolo, trasformando un integrale doppio in due integrali semplici più facilmente risolvibili con le tecniche di integrazione note.
2. Integrali Iterati e Significato Geometrico
Il testo introduce il concetto di integrale iterato, sottolineandone il significato geometrico. L'integrale iterato, ottenuto tramite integrazione ripetuta, fornisce un risultato numerico che rappresenta il volume del solido compreso tra il grafico della funzione e il rettangolo di integrazione. Il documento fa riferimento al principio di Cavalieri, secondo il quale due solidi con sezioni trasversali di uguale area hanno lo stesso volume. Questa analogia aiuta a visualizzare il significato geometrico dell'integrale iterato nel calcolo del volume. La sezione spiega come l'integrale iterato fornisce una soluzione pratica ed efficiente per il calcolo di integrali doppi su rettangoli, evitando la complessità della definizione basata sulle somme di Riemann. La scelta dell'ordine di integrazione (prima rispetto a x, poi a y o viceversa) non altera il risultato finale, a patto che la funzione sia continua sul rettangolo considerato.
3. Teorema di Riduzione e Condizioni di Integrabilità
Un teorema fondamentale, il teorema di riduzione, viene enunciato per garantire l'equivalenza tra l'integrale doppio e l'integrale iterato. Questo teorema stabilisce che se la funzione f è continua sul rettangolo R = [a, b] × [c, d], allora essa è integrabile e l'integrale doppio è uguale all'integrale iterato. Questa affermazione fornisce una solida base teorica per il metodo pratico di calcolo degli integrali doppi presentato in precedenza. La continuità della funzione è una condizione sufficiente per garantire l'integrabilità, semplificando notevolmente la verifica delle condizioni necessarie per applicare il teorema di riduzione e per poter effettivamente calcolare l'integrale doppio tramite integrazione iterata. Il teorema quindi lega la definizione teorica dell'integrale doppio, basata sulle somme di Riemann e sul concetto di limite, al metodo pratico di calcolo tramite integrali iterati, rendendo quest'ultimo rigorosamente giustificato.
III.Integrazione su Domini Generici e Regioni Semplici
Il documento estende poi il concetto di integrale doppio a domini di integrazione più generali, non necessariamente rettangolari. Vengono definite le regioni y-semplici (e implicitamente quelle x-semplici), che permettono di applicare ancora il metodo degli integrali iterati, semplificando il calcolo anche in questi casi più complessi. Domini non semplici possono essere suddivisi in regioni semplici per poter applicare gli integrali iterati.
1. Estensione dell Integrazione a Domini Non Rettangolari
La sezione introduce l'estensione del concetto di integrale doppio a domini di integrazione più complessi rispetto ai semplici rettangoli. Si sottolinea che, mentre la teoria sviluppata finora si concentra su rettangoli, nelle applicazioni è frequente la necessità di integrare su domini di forma arbitraria. Questa estensione è fondamentale per la modellizzazione matematica di problemi reali, dove le regioni di interesse raramente assumono la forma semplice di un rettangolo. Il documento prepara il terreno per affrontare l'integrazione su domini più complessi, anticipando la necessità di tecniche di integrazione più sofisticate rispetto a quelle utilizzate per i rettangoli. La sfida sta nel trovare metodi per semplificare il calcolo dell'integrale doppio su domini di forma irregolare, mantenendo il rigore matematico delle tecniche già introdotte per i rettangoli. Questa sezione introduce concetti cruciali per affrontare questa sfida, come la suddivisione di domini complessi in regioni più semplici.
2. Definizione di Regioni Semplici y semplici
La sezione definisce formalmente il concetto di regione y-semplice (e implicitamente anche x-semplice) nel piano. Una regione D ⊂ R² è detta y-semplice se è compresa tra i grafici di due funzioni della variabile x, ovvero se può essere descritta nella forma D = {(x, y) ∈ R² : a ≤ x ≤ b, φ₁(x) ≤ y ≤ φ₂(x)}, dove φ₁(x) e φ₂(x) sono due funzioni continue nell'intervallo [a, b]. Questa definizione fornisce una caratterizzazione geometrica precisa di un tipo particolare di regioni, che si prestano a un trattamento semplificato nell'integrazione. L'importanza di questa definizione risiede nella possibilità di applicare ancora il metodo dell'integrazione iterata anche per domini non rettangolari, semplificando notevolmente il calcolo dell'integrale doppio. La definizione di regioni y-semplici fornisce un primo strumento per estendere la tecnica di integrazione iterata, precedentemente applicata solo ai rettangoli, a una classe più ampia di domini di integrazione.
3. Integrazione su Domini Non Semplici e Suddivisione in Regioni Semplici
La sezione tratta il caso di domini non semplici, estendendo la possibilità di calcolo dell'integrale doppio anche a regioni più complesse. Si afferma che se un dominio D può essere suddiviso in un numero finito di regioni semplici D₁, D₂, ..., Dₖ che non hanno punti in comune eccetto eventualmente sulla frontiera, allora ogni funzione continua sull'unione di queste regioni è integrabile. L'integrale doppio su D è quindi dato dalla somma degli integrali doppi su ciascuna regione semplice: ∫∫D f(x, y) dx dy = ∑ₖ ∫∫Dₖ f(x, y) dx dy. Questa proprietà è fondamentale perché permette di ridurre il calcolo di integrali doppi su domini complessi alla somma di integrali doppi su regioni più semplici, per le quali è possibile applicare le tecniche di integrazione iterata precedentemente descritte. La suddivisione del dominio in regioni semplici rappresenta quindi una strategia chiave per affrontare l'integrazione su domini non rettangolari, rendendo il calcolo più gestibile e applicabile a una vasta gamma di problemi.
IV.Applicazioni degli Integrali Doppi Densità e Baricentro
Un'importante applicazione degli integrali doppi è il calcolo della massa di una lamina piana con densità superficiale variabile ρ(x,y). Utilizzando le Somme di Riemann, si approssima la massa totale come somma delle masse dei piccoli rettangolini, e passando al limite si ottiene l'integrale doppio della densità su tutta la regione occupata dalla lamina: massa = ∫∫ ρ(x,y) dx dy. Analogamente, si calcola il baricentro e i momenti d'inerzia della lamina.
1. Calcolo della Massa di una Lamina Piana con Densità Variabile
Questa sezione illustra l'applicazione degli integrali doppi al calcolo della massa di una lamina piana con densità superficiale variabile. Se la densità è costante (ρ₀), il rapporto tra la massa contenuta in un rettangolo R incluso nella regione D occupata dalla lamina e l'area di R è costante ed uguale a ρ₀. Se la densità non è costante, si considera il rapporto massa(R)/Area(R) come una densità media. La densità nel punto (x, y) è definita come il limite di questo rapporto quando l'area di R tende a zero. Utilizzando il metodo di approssimazione tramite le somme di Riemann, si suddivide un rettangolo contenente D in sottorettangoli Rᵢⱼ, ponendo la densità ρ uguale a zero fuori da D. Se Rᵢⱼ è molto piccolo e la densità è continua, si assume che ρ sia approssimativamente costante in Rᵢⱼ. Passando al limite, la massa totale della lamina D si ottiene tramite l'integrale doppio: massa(D) = ∫∫D ρ(x, y) dx dy. Questo ragionamento si estende ad altre grandezze fisiche, come la carica elettrica distribuita su una regione piana.
2. Determinazione del Baricentro di una Lamina Piana
La sezione prosegue mostrando come determinare il baricentro di una lamina piana con densità superficiale di massa variabile e continua ρ(x, y) che occupa una regione D. Si parte da un'approssimazione discreta della lamina, suddividendo D in piccoli rettangolini Rᵢⱼ. Si considera un sistema di punti materiali Pᵢⱼ(xᵢⱼ, yᵢⱼ) con masse mᵢⱼ = ρ(xᵢⱼ, yᵢⱼ) * Area(Rᵢⱼ), dove i Pᵢⱼ sono punti base arbitrari nei rettangolini. La coordinata x del baricentro di questo sistema di punti è data da: x̄ = (Σᵢ mᵢxᵢ) / M, dove M è la massa totale. Passando al limite, per ampiezze di suddivisione tendenti a zero, e se la funzione f(x, y) = x * ρ(x, y) è integrabile, si ottiene la coordinata x del baricentro della lamina continua: x̄ = (1/M) ∫∫D x * ρ(x, y) dx dy. Un ragionamento analogo si applica per la coordinata y del baricentro.
3. Calcolo dei Momenti d Inerzia di una Lamina Piana
Infine, la sezione estende il ragionamento al calcolo dei momenti d'inerzia di una distribuzione piana di massa. Il momento d'inerzia di una particella di massa m rispetto a un asse è definito come mr², dove r è la distanza della particella dall'asse. Per una lamina piana con densità ρ(x, y) che occupa la regione D, il momento d'inerzia rispetto all'asse y è dato da ∫∫D x²ρ(x, y) dx dy, e analogamente per l'asse x. Fisicamente, il momento d'inerzia misura la resistenza di un corpo a mettersi in rotazione attorno ad un asse. Anche in questo caso, il calcolo si basa sul passaggio al limite da un modello discreto (un sistema di particelle) a un modello continuo (la lamina), utilizzando l'integrale doppio per esprimere la grandezza fisica in modo preciso. L'applicazione degli integrali doppi permette di calcolare grandezze fisiche importanti come massa, baricentro e momenti d'inerzia in modo rigoroso per sistemi continui.
V.Cambiamento di Variabili negli Integrali Doppi
Questa sezione introduce il cambiamento di variabili negli integrali doppi, una tecnica potente per semplificare il calcolo quando il dominio di integrazione o la funzione integranda presentano simmetrie particolari. Si utilizza la trasformazione T(u,v) = (x(u,v), y(u,v)) e il suo Jacobiano, |det(J)|, per trasformare l'integrale nel nuovo sistema di coordinate. Le coordinate polari sono un esempio di trasformazione particolarmente utile per domini circolari o settori circolari.
1. Introduzione al Cambiamento di Variabili Semplificazione del Calcolo
Questa sezione introduce il cambiamento di variabili negli integrali doppi come tecnica per semplificare il calcolo, sfruttando eventuali simmetrie nel dominio di integrazione o nella funzione integranda. Spesso, esprimere un dominio D in nuove variabili (ad esempio, u e v) può trasformare un dominio complesso in uno più semplice, facilitando l'integrazione. Il testo accenna alla linearità delle trasformazioni, notando che una trasformazione lineare T mappa parallelogrammi del piano uv in parallelogrammi del piano xy. Si evidenzia l'esistenza di un rapporto costante tra l'area di un parallelogramma S e quella della sua immagine T(S), con il fattore di proporzionalità dato dal modulo del determinante della matrice associata alla trasformazione. Questa osservazione è fondamentale per capire come il cambiamento di variabili influenza l'area del dominio di integrazione e, di conseguenza, il valore dell'integrale.
2. Estensione a Domini Non Parallelogrammi e Misura secondo Peano Jordan
La sezione estende la considerazione del cambiamento di variabili a domini più generali, non solo parallelogrammi. Si osserva che una trasformazione lineare mappa poligoni in poligoni, mantenendo lo stesso fattore di proporzionalità tra le aree. Questa proprietà, estesa a poligoni inclusi o contenenti S, e usando la definizione di misura secondo Peano-Jordan, porta alla conclusione che la relazione di proporzionalità tra l'area di un insieme e quella della sua immagine vale per tutti gli insiemi dotati di area. Questa estensione è cruciale per applicare il cambiamento di variabili a domini di integrazione più complessi. La definizione di misura secondo Peano-Jordan fornisce il quadro teorico per generalizzare il risultato dal caso dei parallelogrammi a insiemi più generali, garantendo la validità del metodo del cambiamento di variabili per una vasta classe di domini.
3. Formula del Cambiamento di Variabili e il Jacobiano
La sezione introduce la formula del cambiamento di variabili negli integrali doppi. Se T è una funzione lineare, per ogni insieme S misurabile secondo Peano-Jordan, si ha Area(T(S)) = |det(Jₜ)| * Area(S), dove Jₜ è lo Jacobiano della trasformazione. Se lo Jacobiano è sempre non nullo e limitato (trasformazione diffeomorfismo), per ogni funzione f: T → R integrabile su T, vale la formula: ∫∫D f(x, y) dx dy = ∫∫S f(x(u, v), y(u, v)) |det(Jₜ)| du dv. Il Jacobiano, quindi, gioca un ruolo fondamentale nel cambiamento di variabili, agendo come fattore di scala tra le aree nel dominio originale e nel dominio trasformato. La formula dimostra come modificare correttamente l'integrale doppio per riflettere il cambiamento di variabili, considerando sia la trasformazione della funzione integranda che la variazione dell'area dovuta alla trasformazione del dominio. L'esempio delle coordinate polari viene citato come applicazione pratica di questa formula.
4. Applicazione alle Coordinate Polari
Infine, la sezione evidenzia l'utilità del cambiamento di variabili in coordinate polari (ρ, θ) quando il dominio di integrazione è un disco, una corona circolare o un settore circolare. In questi casi, la trasformazione T(ρ, θ) = (ρcosθ, ρsinθ) mappa il dominio in rettangoli nel piano ρθ, semplificando notevolmente il calcolo dell'integrale doppio. L'utilizzo delle coordinate polari è un esempio concreto e molto frequente di applicazione del cambiamento di variabili, dimostrandone l'utilità pratica nella risoluzione di integrali doppi. La scelta delle coordinate polari, grazie al suo Jacobiano (ρ), trasforma domini con simmetria radiale in rettangoli nel nuovo sistema di coordinate, consentendo una più semplice integrazione iterata.
VI.Integrali Tripli
Il documento conclude estendendo i concetti a integrali tripli, definendoli come il limite delle Somme di Riemann in tre dimensioni. Analogamente agli integrali doppi, si utilizzano formule di riduzione per semplificare il calcolo, trasformando l'integrale triplo in tre integrali semplici successivi. Il calcolo di volumi di solidi e altre applicazioni fisiche sono discusse, così come il cambiamento di variabili anche per gli integrali tripli.
1. Definizione dell Integrale Triplo su un Parallelepipedo
La sezione introduce l'integrale triplo, estendendo il concetto di integrale doppio a funzioni di tre variabili. Si inizia considerando il caso più semplice: una funzione f(x, y, z) definita su un parallelepipedo R = [a, b] × [c, d] × [r, s]. Per definire l'integrale triplo, si seziona il parallelepipedo R mediante piani paralleli agli assi coordinati, creando una partizione di R in piccoli parallelepipedi. Si sceglie un punto base (xᵢⱼₖ, yᵢⱼₖ, zᵢⱼₖ) in ognuno di questi parallelepipedi. La tripla somma di Riemann è definita come la somma dei prodotti di f(xᵢⱼₖ, yᵢⱼₖ, zᵢⱼₖ) per il volume Vᵢⱼₖ di ogni parallelepipedo. L'integrale triplo di f sul parallelepipedo R è quindi definito come il limite di queste somme di Riemann al tendere a zero dell'ampiezza della partizione. Analogamente agli integrali doppi, la continuità della funzione garantisce l'esistenza dell'integrale.
2. Integrabilità e Formule di Riduzione
La sezione discute le condizioni di integrabilità per le funzioni di tre variabili. Similarmente al caso bidimensionale, una funzione limitata è integrabile sul parallelepipedo se e solo se l'estremo superiore delle somme inferiori è uguale all'estremo inferiore delle somme superiori. Questi estremi sono poi uguali all'integrale triplo. Se la funzione è continua sul parallelepipedo, l'integrale è garantito esistere. Vengono inoltre introdotte le formule di riduzione, che consentono di calcolare l'integrale triplo come tre integrali semplici successivi. Queste formule permettono di calcolare l'integrale triplo in modo iterativo, integrando prima rispetto ad una variabile, poi ad un'altra, e infine alla terza. L'ordine di integrazione è fondamentale per la semplificazione del calcolo, e l'esistenza di tre possibili ordini di integrazione offre flessibilità per la scelta del metodo più efficiente.
3. Estensione a Regioni Generali e il Volume di Peano Jordan
L'integrale triplo viene esteso a regioni E⊂R³ più generali di un parallelepipedo. Analogamente al caso bidimensionale, si definisce l'integrale di una funzione limitata f: E → R su una regione limitata E come l'integrale su un parallelepipedo R ⊃ E della funzione che coincide con f su E e vale zero al di fuori di E. Il volume tridimensionale di Peano-Jordan di un insieme E è definito come l'integrale su E della funzione costante uno. Questa estensione consente di calcolare il volume di solidi di forme complesse. Le formule di riduzione, analoghe a quelle per gli integrali doppi, vengono estese anche a questo caso. Le proprietà degli integrali doppi trovano un analogo negli integrali tripli, aprendo la strada a un'ampia gamma di applicazioni in fisica e in altri campi.
4. Formule di Riduzione e Cambiamento di Variabili negli Integrali Tripli
La sezione si concentra sulle formule di riduzione per il calcolo pratico degli integrali tripli. Vengono presentati diversi modi per ordinare le variabili di integrazione, ognuno corrispondente ad una formula di riduzione a tre integrazioni semplici successive. Il metodo di integrazione per fili viene menzionato, dove la prima integrazione avviene lungo un segmento in cui x e y sono fissati, mentre z varia. La sezione introduce anche il cambiamento di variabili negli integrali tripli, estendendo le considerazioni del caso bidimensionale. Una trasformazione T di classe C¹ da R³ in sé, descritta da relazioni del tipo x = x(u, v, w), y = y(u, v, w), z = z(u, v, w), viene utilizzata per trasformare l'integrale. Un teorema sul cambiamento di variabili viene enunciato, specificando le condizioni di biunivocità e la non nullità del determinante Jacobiano per la validità della formula di trasformazione.
