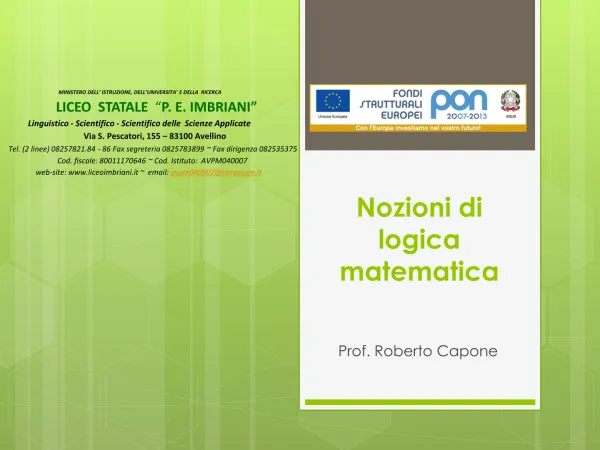
Logica Matematica: Nozioni Base
Informazioni sul documento
| Autore | Roberto Capone |
| Scuola | Liceo Statale “P. E. Imbriani” |
| Materia | Matematica |
| Tipo di documento | Appunti per le lezioni |
| Luogo | Avellino |
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 1.05 MB |
Riassunto
I.Proposizioni e Connettivi Logici
Questo documento introduce la logica proposizionale, spiegando cosa sono le proposizioni (affermazioni vere o false) e come si combinano usando i connettivi logici: negazione (¬), congiunzione (∧, 'e'), disgiunzione (∨, 'o'), implicazione (⟹, 'se...allora') e doppia implicazione (⟺, 'se e solo se'). Vengono illustrate le tavole di verità per valutare il valore di verità delle proposizioni composte e le Leggi di De Morgan, che descrivono la relazione tra negazione, congiunzione e disgiunzione. Si definiscono inoltre le proposizioni logicamente equivalenti e la loro importanza nell'analisi logica.
1. Definizione di Proposizione
La sezione introduce il concetto fondamentale di proposizione in matematica, definendola come un'affermazione che può essere valutata come vera o falsa. Esempi di proposizioni includono 'Roma è la capitale d'Italia', '5 è un numero pari', e 'i gatti sono mammiferi'. Viene fatta una distinzione tra proposizioni semplici e proposizioni composte o molecolari, come '6 è un numero pari e non è divisibile per 5'. Il testo sottolinea l'importanza di un linguaggio preciso e non ambiguo in matematica, a differenza del linguaggio naturale. Si introduce anche il concetto di enunciato aperto, ovvero una frase contenente una variabile, che diventa una proposizione vera o falsa solo quando la variabile assume un valore specifico. L'insieme di verità di un enunciato aperto è l'insieme dei valori che rendono l'enunciato vero.
2. Connettivi Logici Negazione Congiunzione e Disgiunzione
Questa parte descrive i principali connettivi logici utilizzati per combinare proposizioni. La negazione (¬) inverte il valore di verità di una proposizione; la congiunzione (∧, 'e') è vera solo se entrambe le proposizioni connesse sono vere; la disgiunzione (∨, 'o') è falsa solo se entrambe le proposizioni sono false. Il testo spiega come rappresentare queste operazioni tramite tavole di verità, che mostrano il valore di verità della proposizione composta per ogni combinazione di valori di verità delle proposizioni componenti. Un esempio pratico illustra come la congiunzione e la disgiunzione creano proposizioni composte dal valore di verità dipendente dalla veridicità delle singole proposizioni. Viene spiegato inoltre come si costruisce la negazione di una proposizione anteponendo il connettivo 'non'.
3. Proposizioni Logicamente Equivalenti e Leggi di De Morgan
La sezione introduce il concetto di proposizioni logicamente equivalenti, ovvero proposizioni che hanno le stesse tavole di verità. Si presentano le Leggi di De Morgan, che stabiliscono l'equivalenza tra la negazione di una congiunzione e la disgiunzione delle negazioni, e tra la negazione di una disgiunzione e la congiunzione delle negazioni. Queste leggi sono fondamentali per manipolare e semplificare espressioni logiche. L'importanza delle tavole di verità nel determinare l'equivalenza logica tra proposizioni viene ribadita, mostrando che proposizioni logicamente equivalenti hanno tavole di verità identiche. Si usa l'esempio di Paolo che gioca a tennis per illustrare una proposizione elementare e la sua possibile negazione.
4. Proprietà dei Connettivi Logici
Questa parte elenca alcune importanti proprietà dei connettivi logici, tra cui la legge della doppia negazione (¬¬p = p), le proprietà di idempotenza (p ∧ p = p e p ∨ p = p), le proprietà associative e le proprietà distributive. Queste proprietà consentono di manipolare e semplificare espressioni logiche complesse. L'esempio di 'Se arrivo tardi alla stazione, allora perdo il treno' introduce il concetto di implicazione come connessione tra due proposizioni, preparando il terreno per una trattazione più approfondita nell'implicazione e nella doppia implicazione nelle sezioni successive. Si introduce la proprietà commutativa della congiunzione e della disgiunzione.
II.Equivalenze Logiche e Negazione dell Implicazione
Il testo approfondisce il concetto di equivalenza logica tra proposizioni, mostrando come alcune combinazioni di connettivi producano risultati identici. Viene analizzata in particolare la negazione dell'implicazione, chiarendo come questa si relaziona con altri connettivi. Si utilizzano esempi concreti per illustrare i concetti, come l'esempio di "se esco presto dal lavoro, vengo a cena da te" per spiegare la negazione di un'implicazione.
1. Equivalenza Logica e Tavole di Verità
La sezione inizia definendo l'equivalenza logica tra due proposizioni: due proposizioni sono logicamente equivalenti se le loro tavole di verità coincidono. Questo significa che per ogni combinazione di valori di verità delle proposizioni atomiche che le compongono, le proposizioni composte assumono lo stesso valore di verità. L'equivalenza logica è uno strumento fondamentale per semplificare espressioni logiche complesse e per dimostrare teoremi. Si fa riferimento al simbolo '𝑝 = 𝑞' per indicare l'equivalenza logica tra le proposizioni p e q. Viene sottolineato il ruolo delle tavole di verità come strumento essenziale per stabilire se due proposizioni sono logicamente equivalenti. Un esempio pratico confronta la negazione della disgiunzione di due proposizioni elementari con la congiunzione delle loro negazioni, mostrando un caso di equivalenza logica.
2. Negazione dell Implicazione
La parte centrale si concentra sulla negazione dell'implicazione. Il testo evidenzia che la negazione di un'implicazione 𝑝 ⟹ 𝑞 non è semplicemente la sua inversione. Per negare l'implicazione, si utilizza la congiunzione della premessa (p) e della negazione della conclusione (¬q). In altre parole, ¬(𝑝 ⟹ 𝑞) equivale a 𝑝 ∧ ¬𝑞. Questo viene illustrato confrontando le tavole di verità di 𝑝 ⟹ 𝑞 e di 𝑝 ∨ 𝑞, mostrando che ¬(𝑝 ⟹ 𝑞) è logicamente equivalente a 𝑝 ∧ ¬𝑞. Un esempio pratico chiarisce il concetto: negando la proposizione "se esco presto dal lavoro, vengo a cena da te", si ottiene la proposizione "esco presto dal lavoro e non vengo a cena da te". L'analisi delle tavole di verità permette di verificare l'equivalenza logica tra le diverse espressioni.
3. Milano come Esempio di Implicazione
Il documento utilizza l'esempio delle proposizioni 'p: Milano è una città italiana' e 'q: Milano è una città europea' per illustrare l'implicazione e la sua negazione. Vengono analizzate le proposizioni 𝑝 ⟹ 𝑞, 𝑝 ⟹ ¬𝑞, e ¬𝑝 ⟹ ¬𝑞, determinandone il valore di verità. Questo esempio serve a concretizzare i concetti teorici dell'implicazione e della sua negazione, mostrando come il valore di verità delle proposizioni composte dipende dal valore di verità delle proposizioni elementari che le costituiscono. L'uso di una città specifica, Milano, rende l'esempio facilmente comprensibile e intuitivo, aiutando a fissare i concetti appena introdotti.
III.Condizione Necessaria e Sufficiente
La sezione tratta il concetto di condizione necessaria e sufficiente, spiegando il significato della doppia implicazione (⟺). Vengono presentati diversi modi di leggere la doppia implicazione e si usa l'esempio dei triangoli equilateri per illustrare come una proprietà (essere equilatero) sia condizione necessaria e sufficiente per un'altra (avere tutti gli angoli congruenti). I concetti di inversa di una proposizione vengono introdotti.
1. Doppia Implicazione e Connettivo Se e Solo Se
Questa sezione introduce la doppia implicazione (⟺), rappresentata dal connettivo "se e solo se". Si spiega che la proposizione composta p ⟺ q è vera se e solo se p e q hanno lo stesso valore di verità (entrambe vere o entrambe false). Si definisce l'inversa di una proposizione del tipo p ⟹ q come la proposizione q ⟹ p. Il connettivo "se e solo se" viene presentato come un modo per esprimere la condizione necessaria e sufficiente, in cui la verità di una proposizione implica e viene implicata dalla verità dell'altra. La sezione sottolinea che la doppia implicazione rappresenta una relazione di equivalenza logica più forte dell'implicazione semplice, richiedendo la verità reciproca tra le due proposizioni. L'uso del connettivo ⟺ crea una relazione biunivoca tra le proposizioni, a differenza della semplice implicazione che è unidirezionale.
2. Esempi di Doppia Implicazione
La sezione fornisce esempi pratici di doppia implicazione. Viene utilizzato l'esempio della luna e di Giove per illustrare come la proposizione 'La luna è una stella ⟺ Giove è un pianeta' sia falsa perché una delle due proposizioni (o entrambe) sono false. Un esempio più rilevante riguarda i triangoli equilateri: la proposizione 'Un triangolo è equilatero ⟺ ha i tre angoli congruenti' è vera perché la condizione di avere tre angoli congruenti è sia necessaria che sufficiente per essere un triangolo equilatero, e viceversa. Questo esempio evidenzia l'utilità della doppia implicazione per esprimere relazioni di equivalenza tra proprietà geometriche. Si presentano diverse formulazioni equivalenti per esprimere la doppia implicazione, tra cui 'p se e solo se q', 'p equivale a q', 'se p allora q e viceversa', e 'p è condizione necessaria e sufficiente per q'.
IV.Tautologie Regole di Deduzione e Quantificatori
Il documento introduce le tautologie (proposizioni sempre vere) e le regole di deduzione, come il modus ponens e il modus tollens, strumenti fondamentali per la dimostrazione in logica. La sezione conclude con una spiegazione dei quantificatori (universale ∀ e esistenziale ∃), utilizzati per esprimere proprietà che valgono per tutti o per almeno un elemento di un insieme. Esempi concreti illustrano l'utilizzo dei quantificatori.
1. Tautologie
La sezione definisce una tautologia come una proposizione composta che risulta sempre vera, indipendentemente dai valori di verità delle proposizioni atomiche che la compongono. In altre parole, la sua tavola di verità contiene solo valori 'vero'. Le tautologie rappresentano identità logiche fondamentali e sono importanti nella dimostrazione di teoremi e nella semplificazione di espressioni logiche. Non viene fornito un esempio specifico di tautologia nel testo, ma il concetto è presentato come una proprietà delle proposizioni composte. La definizione implica che una tautologia rappresenta una verità logica inconfutabile, valida in ogni circostanza.
2. Regole di Deduzione Modus Ponens e Modus Tollens
Questa parte introduce il concetto di regole di deduzione, specificando che una regola di deduzione è valida se porta a una conclusione corretta indipendentemente dai valori di verità delle proposizioni coinvolte nel ragionamento. Vengono presentati due esempi di regole di deduzione valide: il modus ponens e il modus tollens. Il modus ponens afferma che, date le premesse 'p ⟹ q' e 'p', si può dedurre 'q'. Il modus tollens, invece, afferma che, date le premesse 'p ⟹ q' e '¬q', si può dedurre '¬p'. Questi schemi inferenziali sono strumenti fondamentali per costruire dimostrazioni logiche e per derivare nuove conoscenze da premesse date. Esempi concreti, come quello di Socrate e della sua mortalità, e un esempio con Mario e una partita, illustrano l'applicazione pratica del modus ponens e del modus tollens.
3. Quantificatori Universale ed Esistenziale
La sezione finale introduce i quantificatori, strumenti essenziali per esprimere proprietà che riguardano tutti gli elementi o almeno un elemento di un insieme. Il quantificatore universale (∀) indica che una proprietà è vera per tutti gli elementi di un insieme; il quantificatore esistenziale (∃) indica che esiste almeno un elemento nell'insieme che soddisfa una certa proprietà. Il testo fornisce esempi: 'Ogni uomo è mortale' (∀x ∈ Uomini | x è mortale) e 'Esiste un numero naturale che è multiplo di 3 e di 5' (∃x ∈ N | x è multiplo di 3 e di 5). L'utilizzo dei quantificatori permette di estendere l'ambito della logica oltre le singole proposizioni, consentendo di trattare affermazioni che riguardano insiemi di oggetti. Un ulteriore esempio riguarda l'esistenza di un numero naturale che precede un altro numero naturale scelto arbitrariamente.
V.Cenni Storici sulla Logica
Infine, il documento offre una breve panoramica storica della logica, citando il contributo di Aristotele, Descartes, e Kant allo sviluppo della disciplina, sottolineando l'evoluzione della logica dalla sua formulazione iniziale ad approcci più moderni.
1. Aristotele e le Basi della Logica
La sezione storica inizia riconoscendo Aristotele come il fondatore della logica come scienza. Il testo evidenzia che Aristotele ha analizzato concetti, categorie, proposizioni, termini e sillogismi, ponendo le basi per la logica come strumento propedeutico a ogni forma di conoscenza. L'importanza del contributo di Aristotele risiede nell'aver formalizzato per la prima volta la logica come disciplina sistematica, fornendo strumenti per analizzare e organizzare il ragionamento. La sua influenza è stata fondamentale per lo sviluppo successivo della logica, anche se i suoi metodi sono stati poi superati e raffinati nel corso dei secoli. La sua analisi dei sillogismi, in particolare, rappresenta un punto di partenza fondamentale nella storia della logica formale.
2. Descartes e il Rigore Matematico
Il contributo di René Descartes viene descritto come un tentativo di applicare il rigore del ragionamento matematico ad altri campi del sapere, inclusa la filosofia. Descartes si chiese se il metodo rigoroso della matematica potesse essere la base di qualsiasi conoscenza, cercando di estendere la precisione e la chiarezza del ragionamento matematico anche alle discipline filosofiche. Questo approccio ha influenzato profondamente il modo di concepire la conoscenza e il ragionamento, portando ad una maggiore attenzione alla chiarezza e alla precisione concettuale. Descartes, riprendendo alcuni temi aristotelici, ha cercato di applicare un metodo rigoroso alla filosofia, influenzando così lo sviluppo del pensiero moderno.
3. Kant e la Logica Trascendentale
La sezione si conclude con una breve trattazione del contributo di Immanuel Kant. Nel XVIII secolo, il contributo delle correnti filosofiche allo sviluppo della logica moderna non fu così significativo, ma Kant, nella sua 'Critica della ragion pura', definì la 'logica trascendentale'. Questa branca della logica generale si occupa delle condizioni di possibilità e delle modalità con cui la conoscenza può riferirsi ai concetti empirici. La logica trascendentale di Kant rappresenta un'ulteriore evoluzione del pensiero logico, spostando l'attenzione sulle condizioni a priori della conoscenza e sul rapporto tra logica e esperienza. Questo aspetto della logica kantiana, seppur brevemente accennato, sottolinea l'evoluzione del concetto di logica al di là della semplice analisi del ragionamento formale.
