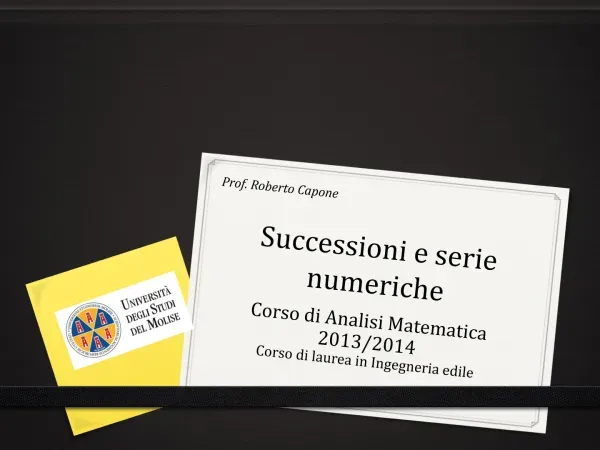
Successioni numeriche: definizione ed esempi
Informazioni sul documento
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 0.95 MB |
| Materia | Matematica |
| Tipo di documento | Appunti di lezione |
Riassunto
I.Successioni Numeriche Definizioni e Classificazioni
Questo documento tratta le successioni numeriche, definendole come funzioni che associano ad ogni numero naturale un numero reale. Vengono analizzate diverse tipologie di successioni: successioni monotone (crescenti o decrescenti), successioni limitate, successioni convergenti (che tendono ad un limite finito) e successioni divergenti (che tendono a infinito). Un esempio chiave è la successione di Fibonacci, dove ogni termine è la somma dei due precedenti (1, 1, 2, 3, 5...). Lo studio del limite di una successione è fondamentale per comprenderne il comportamento al crescere di n. Vengono inoltre introdotti concetti importanti come infinitesimi ed infiniti.
1. Definizione di Successione
Il documento inizia definendo una successione numerica come una funzione che mappa l'insieme dei numeri naturali (ℕ) nell'insieme dei numeri reali (ℝ). Formalmente, è rappresentata come f: ℕ → ℝ, dove f(n) = aₙ, con aₙ che indica il termine n-esimo della successione. Si specifica che spesso le successioni sono definite a partire da un certo intero n₀, quindi il loro dominio è del tipo n ∈ ℕ | n ≥ n₀. Questa definizione fondamentale stabilisce il punto di partenza per l'analisi delle diverse proprietà e tipologie di successioni che verranno trattate nel seguito del documento. La notazione aₙ, n∈ℕ, viene utilizzata per indicare la successione stessa, sottolineando la dipendenza del termine dalla posizione n all'interno della sequenza. La possibilità di definire una successione a partire da un valore n₀ arbitrario amplia la flessibilità del concetto, consentendo di studiare successioni che non partono necessariamente da n=1.
2. Rappresentazione Grafica delle Successioni
Il testo prosegue descrivendo come le successioni possono essere rappresentate graficamente sul piano cartesiano. I valori di n sono riportati sull'asse delle ascisse, mentre i corrispondenti termini aₙ sono rappresentati sull'asse delle ordinate. Il grafico risultante è costituito da una serie di punti isolati, in contrasto con le funzioni continue. Come esempio viene menzionata la rappresentazione grafica della successione dei numeri dispari. Questa sezione sottolinea l'aspetto visivo e intuitivo della rappresentazione delle successioni, utile per una comprensione più immediata del loro comportamento. La descrizione di un grafico a punti discreti enfatizza la natura discreta delle successioni stesse, a differenza delle funzioni continue che presentano un grafico formato da linee ininterrotte. L'utilizzo di un esempio concreto, come la successione dei numeri dispari, facilita la comprensione del concetto di rappresentazione grafica.
3. Esempi di Successioni
La sezione dedicata agli esempi fornisce illustrazioni concrete di successioni, mostrando diversi comportamenti. Un esempio mostra una frazione che si avvicina a zero al crescere di n, mentre un altro esempio mostra una potenza che cresce indefinitamente. Questi esempi semplici servono a illustrare concetti più complessi che verranno approfonditi successivamente, come la convergenza a zero o la divergenza a infinito. L'inclusione di esempi diversificati permette di introdurre in modo intuitivo le diverse tipologie di successioni, preparando il terreno per una successiva trattazione più formale. La scelta di esempi semplici ma significativi facilita la comprensione dei concetti base, mostrando come il comportamento di una successione possa variare in modo significativo a seconda della sua definizione.
4. Successioni Limitata Convergenti e Divergenti
Il documento definisce tre importanti proprietà delle successioni: limitatezza, convergenza e divergenza. Una successione è limitata inferiormente se esiste un valore m tale che aₙ ≥ m per ogni n; è limitata superiormente se esiste un valore M tale che aₙ ≤ M per ogni n; ed è limitata se è sia inferiormente che superiormente limitata. La convergenza di una successione è definita in relazione all'esistenza di un limite reale l, tale che per ogni ε > 0, aₙ si trova nell'intervallo (l-ε, l+ε) definitivamente. La divergenza, invece, implica che la successione tende a +∞ o -∞. L'introduzione di queste definizioni è fondamentale per la classificazione e l'analisi del comportamento asintotico delle successioni. La definizione rigorosa di convergenza e divergenza fornisce gli strumenti necessari per studiare il comportamento delle successioni al tendere di n all'infinito. La comprensione della limitatezza aiuta a determinare se una successione è confinata entro determinati valori o può assumere valori arbitrariamente grandi o piccoli.
5. Successioni Monotone
Una sezione importante è dedicata alle successioni monotone. Una successione è monotona crescente se aₙ ≤ aₙ₊₁ per ogni n, strettamente crescente se aₙ < aₙ₊₁. Analogamente, si definiscono le successioni monotone decrescenti e strettamente decrescenti. Il documento cita un teorema sul limite delle successioni monotone: una successione monotona crescente e superiormente limitata converge al suo estremo superiore, mentre una successione monotona decrescente e inferiormente limitata converge al suo estremo inferiore. Questo teorema fornisce un importante risultato sulla convergenza di successioni con una particolare regolarità nel comportamento dei loro termini. La distinzione tra successioni monotone e strettamente monotone è cruciale per la comprensione del loro comportamento. La dimostrazione del teorema (non inclusa nel documento) si basa sulla completezza dei numeri reali.
II.Limiti di Successioni
Il documento approfondisce il concetto di limite di una successione. Viene definita la convergenza di una successione, spiegando che una successione converge ad un valore l se i suoi termini si avvicinano indefinitamente a l. Si introduce anche il concetto di divergenza, con successioni che tendono a +∞ o -∞. Si analizzano teoremi importanti come il teorema di permanenza del segno e il teorema del confronto, strumenti cruciali per determinare il limite di successioni complesse. Il collegamento tra limiti di funzioni e limiti di successioni è affrontato tramite il teorema ponte.
1. Successioni Convergenti
La sezione definisce una successione convergente come una successione {aₙ} per cui esiste un numero reale l ∈ ℝ tale che, per ogni ε > 0, la disuguaglianza |aₙ - l| < ε è verificata definitivamente (cioè per tutti gli n maggiori di un certo indice N). In altre parole, fissata una striscia di ampiezza 2ε centrata in l, da un certo punto in poi tutti i termini della successione cadono all'interno di questa striscia. Questa definizione formalizza l'idea intuitiva che i termini della successione si avvicinano arbitrariamente al valore l. La condizione |aₙ - l| < ε è equivalente a l - ε < aₙ < l + ε, sfruttando le proprietà del valore assoluto. L'importanza di questa definizione risiede nel fatto che essa fornisce un criterio rigoroso per stabilire se una successione converge ad un limite, permettendo di analizzare il comportamento asintotico delle successioni in modo preciso e quantitativo. La scelta di ε arbitrariamente piccolo sottolinea la possibilità di avvicinarsi al limite con una precisione sempre maggiore.
2. Successioni Divergenti
Il documento definisce una successione divergente a +∞ se per ogni M > 0, la disuguaglianza aₙ > M è verificata definitivamente. Ciò significa che, comunque si scelga un valore M grande a piacere, i termini della successione supereranno M da un certo punto in poi. Analogamente, una successione diverge a -∞ se per ogni M > 0, aₙ < -M definitivamente. La definizione di divergenza formalizza l'idea che i termini della successione crescono (o decrescono) illimitatamente. A differenza della convergenza, dove i termini si avvicinano ad un valore finito, nella divergenza i termini si allontanano indefinitamente da qualsiasi valore finito. Questa sezione completa la classificazione delle successioni in base al loro comportamento asintotico. La scelta di M arbitrariamente grande sottolinea l'illimitatezza della crescita (o decrescita) dei termini della successione.
3. Infiniti e Infinitesimi
Il documento introduce brevemente i concetti di successione infinitesima e successione infinita. Una successione {aₙ} è infinitesima se il suo limite per n che tende a infinito è zero, ovvero lim (n→+∞) aₙ = 0. Una successione è infinita se il suo limite per n che tende a infinito è infinito (positivo o negativo). Queste definizioni rappresentano casi particolari di convergenza (a zero) e divergenza (a infinito). La distinzione tra infinitesimi e infiniti è fondamentale per la classificazione delle successioni in base al loro comportamento asintotico. Gli infinitesimi rappresentano successioni che tendono a zero, mentre gli infiniti rappresentano successioni che tendono a infinito. Questa breve sezione fornisce una nomenclatura specifica per questi casi particolari, arricchendo il linguaggio utilizzato per descrivere il comportamento delle successioni.
4. Teoremi sui Limiti Permanenza del Segno e Confronto
Il documento presenta il teorema di permanenza del segno in due forme. La prima afferma che se una successione {aₙ} converge ad un limite a > 0, allora i termini aₙ sono definitivamente positivi; se invece converge ad un limite a < 0, i termini aₙ sono definitivamente negativi. La seconda forma afferma che se {aₙ} converge ad a e aₙ ≥ 0 definitivamente, allora a ≥ 0. Un altro teorema importante è il teorema del confronto: se aₙ ≤ bₙ ≤ cₙ definitivamente e lim (n→∞) aₙ = lim (n→∞) cₙ = l, allora anche lim (n→∞) bₙ = l. Questi teoremi forniscono strumenti fondamentali per determinare il limite di una successione. Il teorema di permanenza del segno stabilisce una relazione tra il segno del limite e il segno dei termini della successione, mentre il teorema del confronto permette di determinare il limite di una successione tramite il confronto con altre successioni di limite noto. Questi teoremi sono strumenti cruciali nella dimostrazione di altri risultati e nella semplificazione dell'analisi dei limiti.
5. Legame tra Limiti di Funzioni e Limiti di Successioni Teorema Ponte
Infine, il documento introduce il 'teorema ponte', che stabilisce un collegamento tra i limiti di funzioni e i limiti di successioni. Se f è una funzione reale definita in un sottoinsieme X di ℝ, regolare nel punto x₀ ∈ ℝ di accumulazione per X, e {xₙ} è una successione di punti di X - {x₀} tale che lim (n→∞) xₙ = x₀, allora lim (n→∞) f(xₙ) = lim (x→x₀) f(x). Questo teorema permette di utilizzare le proprietà dei limiti di funzioni per determinare i limiti di successioni, semplificando l'analisi in molti casi. Questo teorema costituisce un ponte tra due ambiti dell'analisi matematica, consentendo di sfruttare risultati noti nell'ambito delle funzioni per studiare il comportamento delle successioni. La regolarità della funzione nel punto x₀ è una condizione necessaria per la validità del teorema.
III.Serie Numeriche Convergenza e Divergenza
La parte finale del documento si concentra sulle serie numeriche, definite come la somma di infiniti termini di una successione. Un concetto fondamentale è la convergenza di una serie, ovvero se la somma dei suoi termini converge ad un valore finito. Si introduce la condizione necessaria per la convergenza (il termine generale deve tendere a zero). Vengono presentati diversi criteri di convergenza per le serie a termini positivi, tra cui il criterio del confronto, il criterio del rapporto (d'Alembert) e il criterio della radice (Cauchy). Infine, si discutono le serie a termini qualsiasi, con particolare attenzione alle serie a segni alterni e al criterio di Leibniz per la loro convergenza.
1. Definizione di Serie Numerica
Il documento definisce una serie numerica come la somma di infiniti termini di una successione {aₙ}, rappresentata come ∑(da n=1 a ∞) aₙ. Si introduce il concetto di somma parziale n-esima, Sₙ = a₁ + a₂ + ... + aₙ, che rappresenta la somma dei primi n termini della serie. Lo studio del limite di queste somme parziali, lim (n→∞) Sₙ, determina il carattere della serie: se il limite esiste ed è finito, la serie converge e la sua somma è il valore del limite; se il limite è infinito (positivo o negativo), la serie diverge; se il limite non esiste, la serie è indeterminata. Questa definizione fondamentale introduce il concetto chiave di convergenza e divergenza delle serie. La costruzione della successione delle somme parziali Sₙ è fondamentale per studiare il comportamento della serie nel suo insieme, passando dallo studio dei termini individuali a quello della somma totale. La distinzione tra convergenza e divergenza è basilare per la classificazione delle serie.
2. Condizione Necessaria per la Convergenza
Il documento enuncia una condizione necessaria (ma non sufficiente) per la convergenza di una serie: se la serie ∑(da n=1 a ∞) aₙ converge, allora il limite del termine generale deve essere zero, ovvero lim (n→∞) aₙ = 0. Questa condizione, se non verificata, garantisce la divergenza della serie, ma non la sua convergenza. In altre parole, se il limite del termine generale non è zero, la serie sicuramente diverge; se invece il limite è zero, la serie potrebbe convergere o divergere. Questa condizione necessaria fornisce un primo test semplice per determinare la divergenza di una serie. La sua importanza risiede nella possibilità di escludere immediatamente la convergenza nel caso in cui il limite del termine generale sia diverso da zero. È importante sottolineare che la condizione è solo necessaria, non sufficiente, quindi se il limite è zero sono necessari ulteriori test per stabilire se la serie converge effettivamente.
3. Serie Geometrica e Criteri di Convergenza
Il documento analizza la serie geometrica, ∑(da n=0 a ∞) ρⁿ, come caso particolare importante. La convergenza di questa serie dipende dal valore di ρ: converge a 1/(1-ρ) se |ρ| < 1, e diverge altrimenti. Per le serie a termini positivi, vengono introdotti il primo e il secondo criterio del confronto, basati sul confronto del termine generale della serie in esame con quello di una serie di cui è noto il carattere (convergente o divergente). Questi criteri sono strumenti fondamentali per determinare la convergenza o divergenza di una serie. La serie geometrica serve come esempio concreto per illustrare il concetto di convergenza e divergenza a seconda del valore di un parametro. I criteri del confronto offrono un metodo pratico per stabilire il carattere di una serie confrontandola con altre serie di cui è già noto il comportamento.
4. Serie a Termini Positivi Criteri di Convergenza
Per le serie a termini positivi (o non negativi), il documento presenta altri criteri di convergenza: il primo criterio del confronto (se una serie converge, ogni sua minorante converge; se diverge, ogni sua maggiorante diverge), il criterio della radice (di Cauchy) e il criterio del rapporto (di d'Alembert). Questi criteri forniscono metodi per stabilire la convergenza o la divergenza basati sul comportamento del termine generale o sul rapporto tra termini consecutivi. La condizione di termini positivi semplifica l'analisi, in quanto una serie a termini positivi o converge o diverge positivamente, escludendo il caso di indeterminazione. Questi criteri forniscono metodi più potenti rispetto al semplice confronto diretto, permettendo di analizzare la convergenza anche in casi più complessi. La scelta del criterio più adatto dipende dalla struttura della serie da analizzare.
5. Serie a Termini Qualsiasi e Criterio di Leibniz
Il documento tratta infine le serie a termini qualsiasi (con termini sia positivi che negativi), con particolare attenzione alle serie a segni alterni. Per queste ultime, si introduce il criterio di Leibniz: se i valori assoluti dei termini formano una successione monotona decrescente che tende a zero, la serie converge. Una serie a termini qualsiasi converge assolutamente se converge la serie dei suoi valori assoluti. Il criterio di Leibniz fornisce un metodo per stabilire la convergenza di una particolare classe di serie a termini qualsiasi. La convergenza assoluta implica la convergenza, ma non viceversa. Questo criterio è utile per stabilire la convergenza di serie con termini di segno alterno che non possono essere analizzate con i criteri precedentemente presentati per serie a termini positivi.
IV.Esempi di Successioni
Il documento presenta diversi esempi pratici di successioni, tra cui la successione di Fibonacci, successioni definite da polinomi e il rapporto tra polinomi, e la successione geometrica. Questi esempi illustrano concetti chiave come la convergenza, la divergenza e la monotonia delle successioni, rendendo più chiare le teorie presentate.
1. La Successione di Fibonacci
Il documento introduce la successione di Fibonacci, definita dalla ricorrenza aₙ₊₂ = aₙ₊₁ + aₙ, con a₁ = 1 e a₂ = 1. Questa successione, i cui primi termini sono 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ... , viene utilizzata come esempio introduttivo. Si osserva che il rapporto tra termini consecutivi, aₙ₊₁/aₙ, si avvicina alla sezione aurea. Questo esempio mostra una successione definita ricorsivamente, ovvero dove ogni termine dipende dai termini precedenti. La successione di Fibonacci, oltre ad essere un esempio concreto, introduce concetti come la ricorsione e la relazione con la sezione aurea, un numero con importanti significati geometrici e nella natura. L'approssimazione alla sezione aurea evidenzia un aspetto interessante del comportamento asintotico di questa particolare successione.
2. Esempi di Successioni con Comportamenti Diversi
Il documento presenta altri esempi di successioni per illustrare diversi comportamenti. Un esempio è una successione di frazioni del tipo 1/n, dove al crescere di n la frazione si avvicina a zero. Un altro esempio è una successione di potenze, nᵏ, che mostra una crescita illimitata al crescere di n. Questi esempi semplici servono a illustrare concetti importanti come la convergenza a zero e la divergenza a infinito. La scelta di esempi semplici e intuitivi aiuta a visualizzare i diversi modi in cui una successione può evolvere. L'esempio della successione 1/n mostra un caso di convergenza a un limite finito, mentre l'esempio di nᵏ evidenzia un caso di divergenza a infinito. Questi esempi preparano il terreno per una trattazione più formale dei concetti di limite, convergenza e divergenza.
3. Successioni definite da Polinomi e Rapporto di Polinomi
Il documento considera successioni il cui termine generico è dato da un polinomio di grado h in n. Viene poi analizzato il caso in cui il termine generico è il rapporto tra due polinomi, di grado h e k rispettivamente. In questo caso, se h > k la successione diverge; se h < k, la successione converge a zero; se h = k, la successione converge ad un valore finito. Questi esempi mostrano come la struttura algebrica del termine generico influenza il comportamento asintotico della successione. L'analisi del rapporto tra polinomi introduce un livello di complessità maggiore rispetto agli esempi precedenti, mostrando come le successioni possono essere definite anche da funzioni più complesse. La relazione tra i gradi dei polinomi determina il comportamento asintotico della successione, evidenziando l'importanza della struttura algebrica nella determinazione del limite.
4. Successioni e il Numero di Nepero
Il documento menziona la successione (1 + 1/n)ⁿ, che converge al numero di Nepero (e) per n che tende a infinito. Questo esempio mostra come una successione può convergere ad una costante matematica importante. Questo esempio collega il concetto di successione al numero di Nepero (e), una costante fondamentale nell'analisi matematica e in molte altre aree della scienza. Il calcolo del limite di questa successione richiede metodi specifici dell'analisi matematica, mostrando l'applicazione pratica delle tecniche studiate nel documento. L'inclusione di questo esempio arricchisce la trattazione, mostrando il legame tra successioni e costanti matematiche di rilevanza.
5. Successione Geometrica
Infine, il documento presenta la successione geometrica, definita da aₙ = qⁿ, dove q è un numero reale fissato. Il limite di questa successione per n che tende a infinito dipende dal valore di q: se |q| < 1, la successione converge a 0; se |q| > 1, diverge; se q = 1, converge a 1; se q = -1, la successione oscilla tra -1 e 1 e non ha limite. Questo esempio mostra una successione semplice ma con un comportamento che dipende da un parametro, illustrando ulteriormente diversi casi di convergenza e divergenza. L'esempio della successione geometrica è particolarmente istruttivo in quanto presenta un comportamento chiaro e semplice da analizzare, legato direttamente al valore della ragione q. Questo caso permette di studiare diversi scenari di convergenza e divergenza in modo intuitivo.
