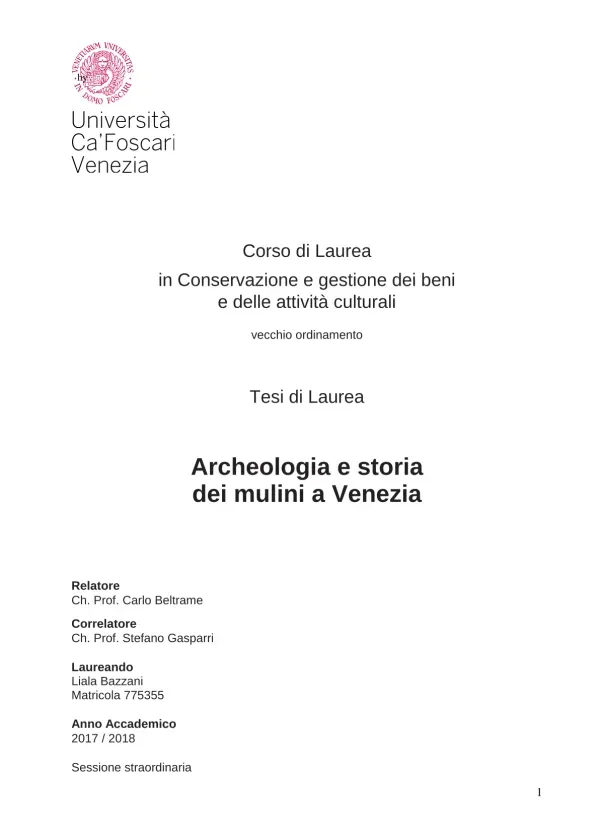
Mulini Veneziani: Storia e Archeologia
Informazioni sul documento
| Autore | Liala Bazzani |
| school/university | Università di Venezia |
| subject/major | Conservazione e Gestione dei Beni e delle Attività Culturali |
| Tipo di documento | Tesi di Laurea |
| academic_year/year_document_was_written | 2017/2018 |
| city_where_the_document_was_published | Venezia |
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 2.97 MB |
Riassunto
I.I Mulini Idraulici nella Laguna di Venezia Storia e Tecnologia
Questo documento analizza la storia dei mulini ad acqua (mulini idraulici) nella Laguna di Venezia, esplorando le loro tecniche costruttive e il loro impatto socio-economico nel Medioevo. Si esamina l'evoluzione tecnologica dei mulini, dalle prime descrizioni di Vitruvio e Plinio, passando per i diversi tipi di ruote (a ritrecine, per di sopra, a cassette) e il loro utilizzo in contesti geografici specifici. L'importanza dei mulini nella produzione di farina è centrale, ma il testo evidenzia anche l'impiego dell'energia idraulica in altre attività come la follatura dei tessuti (gualchiere) e la lavorazione del ferro (fucine). Si approfondisce il ruolo dei mulini nella vita economica e sociale di Venezia, considerando anche la loro relazione con la produzione del sale nella Laguna.
1. Descrizione Storica dei Mulini Idraulici
Il documento inizia tracciando una panoramica storica dei mulini idraulici, citando Vitruvio Pollione (I secolo a.C.) e il suo De Architectura, che fornisce una dettagliata descrizione del funzionamento di un mulino ad acqua. Vitruvio descrive l'utilizzo di ruote con pale colpite dall'impeto del fiume per azionare il meccanismo di macinazione. Plinio il Vecchio (I secolo d.C.), nella sua Naturalis Historia, conferma l'esistenza di ruote idrauliche in Italia, ma sottolinea che la loro diffusione capillare avvenne solo nel pieno Medioevo. Questo ritardo, nonostante la presenza di mulini già nell'antichità, è spiegato con la grande disponibilità di manodopera schiavile e bestiame nell'Impero Romano, che rendeva meno necessaria la ricerca di alternative energetiche. La crisi dell'Impero e le conseguenti invasioni barbariche, con la diminuzione della popolazione e della manodopera, favorirono invece lo sviluppo di nuove fonti di energia, tra cui l'acqua. Il sistema monastico benedettino, con le sue regole sull'autosufficienza e sul lavoro manuale dei monaci, contribuì significativamente all'espansione dell'uso dell'energia idraulica per i mulini.
2. Tipologie di Mulini Idraulici e Meccanismi di Funzionamento
Il testo prosegue descrivendo diverse tipologie di mulini idraulici e i loro meccanismi di funzionamento. Si distinguono principalmente tre tipi di ruote: la ruota "a ritrecine", orizzontale con pale piatte o a cucchiaio, azionata da un getto d'acqua; la ruota "per di sopra" o "a cassette", dove l'acqua, a un livello più alto, colpisce le pale dall'alto sfruttando il peso dell'acqua stessa; e altri tipi non specificati. La descrizione del meccanismo di macinazione evidenzia la presenza della nottola, un perno che trasmette il moto rotatorio dell'albero alla macina superiore. L'importanza di un buon sistema di canalizzazione e raccolta dell'acqua è sottolineata, soprattutto per i mulini che funzionano con piccoli volumi d'acqua ad alta velocità, adatti alle zone montane. Si descrive anche il sistema di canalizzazione dell'acqua, con bacini, canali inclinati (docce) e cataratte per regolare il flusso. La costruzione di un mulino richiedeva ingenti spese per l'edificio, gli ingranaggi e le opere idrauliche, oltre al diritto all'uso dell'acqua, evidenziando l'investimento economico richiesto per la loro costruzione e gestione.
3. Altre Applicazioni dell Energia Idraulica
Il documento amplia l'analisi mostrando come l'energia idraulica, oltre alla macinazione dei cereali, venisse impiegata in altre attività. Si descrive la gualchiera, una macchina idraulica utilizzata per la follatura dei tessuti, introdotta nel X secolo. Il suo funzionamento si basa su un sistema a camme che trasforma il moto rotatorio in alternato, sollevando e facendo ricadere dei magli sul tessuto per compattarlo. Si discute lo sviluppo della gualchiera grazie alla crescita dell'industria laniera. Un altro esempio è dato dalle fucine e dal battiferro, dove l'applicazione dell'energia idraulica, a partire dal XII secolo, permise di raggiungere temperature sufficientemente alte per fondere il ferro, migliorando la qualità del metallo lavorato. Il sistema a camme veniva utilizzato anche per azionare i mantici delle fucine, consentendo un controllo più preciso della temperatura. Infine, si accenna alle segherie idrauliche, la cui invenzione è fatta risalire al XII secolo, con l'utilizzo iniziale di un sistema a camme e successivamente di quello a biella-manovella per sollevare e abbassare la lama. La sega multilame, introdotta successivamente, rese l'attività molto più redditizia.
II.I Mulini Galleggianti Un Innovazione nella Macinazione
Il documento descrive l'invenzione e la diffusione dei mulini galleggianti nella Laguna di Venezia, presentandoli come una soluzione innovativa per sfruttare la forza della corrente del fiume. Si analizzano le diverse tipologie di mulini galleggianti, evidenziando i vantaggi e gli svantaggi legati alla loro installazione e alla loro vulnerabilità a eventi naturali come le alluvioni. L'esempio del generale Belisario, che li impiegò durante l'assedio di Roma nel 537 d.C., è citato come una testimonianza storica significativa dell'utilizzo di questa tecnologia.
1. Origine e Prime Testimonianze dei Mulini Galleggianti
La prima testimonianza documentata di un mulino galleggiante risale al 537 d.C., durante la guerra gotica. Procopio di Cesarea, nella sua "Storia delle Guerre", narra come il generale bizantino Belisario, a seguito del blocco degli acquedotti romani da parte del re goto Vitige, inventò un nuovo meccanismo molitorio montato su barche per sfruttare la corrente del Tevere. Questo esempio evidenzia l'ingegno e l'adattamento tecnologico per superare le difficoltà in situazioni di emergenza. L'invenzione dimostra una capacità di innovazione notevole, adattando l'esistente tecnologia dei mulini a un nuovo contesto ambientale e sfruttando una nuova fonte di energia, la corrente fluviale. Successivamente, l'utilizzo di mulini galleggianti si diffuse lungo i fiumi con una portata d'acqua adeguata, rivelandosi una soluzione pratica e flessibile per la macinazione in contesti dove la disponibilità di acqua corrente era limitata o irregolare. La capacità di adattare la tecnologia esistente a nuove necessità e contesti, rende questo tipo di mulino una testimonianza interessante dell'innovazione tecnologica dell'epoca.
2. Tipologie e Caratteristiche dei Mulini Galleggianti
Il documento distingue due tipi principali di mulini galleggianti. Il primo, meno stabile, consisteva in un unico scafo con un doppio ingranaggio, una cabina per la macina e due ruote sui fianchi. Il secondo tipo, più stabile ed efficiente, era composto da due o tre scafi affiancati e solidamente legati, con la ruota motrice posizionata tra gli scafi per trasmettere il movimento alla macina situata su uno dei battelli. L'ancoraggio era garantito da cime e catene per assicurare la stabilità necessaria al funzionamento. In alcuni casi, venivano costruite chiuse, spesso palizzate in legno, per indirizzare la corrente verso la ruota del mulino. Alcuni mulini galleggianti erano progettati per essere spostati lungo il corso d'acqua, offrendo una maggiore flessibilità operativa. Questa mobilità, tuttavia, si traduceva in una maggiore vulnerabilità rispetto ai mulini fissi, che erano soggetti a danni causati dalle alluvioni, dalle piene dei fiumi e dal trasporto di materiali che potevano danneggiare la ruota o gli scafi.
3. Vulnerabilità e Rischi dei Mulini Galleggianti
I mulini galleggianti, pur presentando vantaggi in termini di flessibilità e adattamento a diversi contesti fluviali, presentavano anche notevoli vulnerabilità. Le alluvioni rappresentavano un pericolo significativo, con il rischio di sommersione completa dell'impianto o di rottura degli ormeggi, con conseguente trasporto a valle del mulino. Le piene dei fiumi, trasportando detriti e materiali di varia natura, potevano danneggiare la grande ruota o gli scafi dei natanti. Infine, la presenza dei mulini galleggianti costituiva un ostacolo alla navigazione fluviale, occupando una parte significativa del corso d'acqua e rappresentando quindi un serio pericolo per le imbarcazioni. La descrizione di questi rischi evidenzia la necessità di una attenta gestione e di una valutazione attenta dei fattori ambientali prima della realizzazione di un impianto di questo tipo.
III.L Energia Eolica I Mulini a Vento
Oltre all'energia idraulica, il documento tocca l'argomento dei mulini a vento, introducendo l'energia eolica come fonte alternativa per la macinazione. Si traccia la diffusione dei mulini a vento dall'Asia all'Europa, notando la loro maggiore presenza nell'Europa settentrionale rispetto all'area mediterranea. Le differenze tra i modelli tedesco e olandese vengono brevemente descritte, e si sottolinea il loro impiego in attività diverse dalla macinazione, come il drenaggio e la segheria.
1. Origine e Diffusione dei Mulini a Vento
Il documento introduce l'energia eolica e i mulini a vento, segnalando che la prima notizia di questi mulini proviene dalla Persia, risalendo all'epoca di Omar I (VII secolo). Altre testimonianze provenienti dalla stessa area geografica sono riportate da geografi del X secolo. La diffusione dei mulini a vento in Europa avvenne inizialmente nell'Europa settentrionale, favorita dalle caratteristiche topografiche delle grandi pianure e dal vantaggio di evitare le interruzioni di lavoro causate dalle gelate invernali, a differenza dei mulini ad acqua. La diffusione nell'Europa mediterranea fu più lenta, probabilmente a causa di un problema del gelo meno rilevante e della maggiore velocità dei corsi d'acqua rispetto alle pianure settentrionali. La descrizione evidenzia l'importanza del contesto geografico e climatico nella diffusione e nello sviluppo di questa tecnologia, che, pur essendo antica, trovò applicazione su larga scala solo in alcune regioni. L'analisi del contesto geografico e climatico permette di capire il diverso successo di questa tecnologia in aree geografiche diverse.
2. Tipologie di Mulini a Vento e Meccanismi
Il testo descrive brevemente due tipologie principali di mulini a vento: il mulino tedesco, detto "caprone" o "a capra", dove l'intero edificio ruota attorno a un palo di sostegno; e il mulino olandese, dove l'edificio rimane fisso e solo il tetto, che sostiene le pale, si orienta secondo la direzione del vento. In entrambi i casi, il meccanismo di funzionamento prevedeva la trasmissione del moto rotatorio delle pale a un fuso, che a sua volta azionava il meccanismo di macinazione, con la macina posizionata in basso. Il documento, pur non entrando nei dettagli costruttivi, sottolinea la diversità tecnologica tra i due modelli principali, evidenziando l'evoluzione della tecnologia dei mulini a vento nel tempo. L'analisi si concentra sulla funzione principale, la macinazione, ma accenna alla successiva applicazione ad altre attività come il drenaggio dell'acqua e il funzionamento delle seghe, mostrando la versatilità della tecnologia.
3. Diffusione dei Mulini a Vento in Italia e a Venezia
La diffusione dei mulini a vento in Italia è documentata a partire dal 1322, con la richiesta di Bartolomeo Verde di costruire un mulino nell'isola di San Cristoforo della Pace a Venezia. Sebbene le testimonianze aumentino nel tempo, il documento evidenzia come questa tecnologia non abbia mai raggiunto in Italia, e in particolare a Venezia, la stessa diffusione e importanza dei mulini idraulici. L'analisi evidenzia le differenze nell'impiego delle diverse tecnologie, legate a fattori ambientali, economici e culturali, e la prevalenza dei mulini ad acqua nel contesto veneziano. La presenza di una documentazione limitata rende complesso tracciare la reale diffusione dei mulini a vento nel territorio veneziano, ma ciò dimostra l'importanza dei mulini ad acqua nel contesto della laguna.
IV.La Laguna di Venezia e l Attività Molitoria Un Rapporto Complesso
Il documento si concentra sull'analisi della presenza di mulini nella Laguna di Venezia, facendo riferimento a fonti archivistiche, in particolare le sentenze dei Giudici del Piovego. Si ricostruisce l'evoluzione dell'attività molitoria nella laguna, evidenziando le diverse fasi di espansione e regressione legate alle variazioni del livello marino e alle trasformazioni ambientali. Figure chiave come il Doge Agnello Particiaco e Tribuno Menio sono citate in relazione a sentenze che riguardano i mulini. Il documento evidenzia anche la difficoltà di tracciare una mappatura precisa dei mulini a causa della scarsità di reperti archeologici, sottolineando l'importanza delle fonti documentarie per la ricostruzione della storia di questa attività. L'analisi delle sentenze permette di ricostruire l'evoluzione della proprietà dei mulini, spesso in mano a monasteri e istituzioni ecclesiastiche, e le loro trasformazioni nel tempo. Importanti località come Mazzorbo vengono analizzate per la loro significativa attività molitoria.
1. Fonti Storiche e Metodologia di Ricerca
L'analisi dell'attività molitoria nella Laguna di Venezia si basa principalmente su fonti archivistiche, in particolare le sentenze dei Giudici del Piovego (istituiti nel 1282), conservate al Museo Correr. Queste sentenze, prevalentemente del XIV secolo, ma con riferimenti a documenti più antichi (dal 982), riguardano questioni legate all'uso delle acque, comprendendo canali, strade, saline, valli da pesca e ponti. I Giudici del Piovego, magistratura con competenze tecniche, amministrative e giuridiche, si occupavano di regolare l'utilizzo delle risorse idriche della laguna, tutelando le proprietà pubbliche e risolvendo controversie tra privati ed enti ecclesiastici. La metodologia di ricerca si concentra sull'analisi di queste fonti documentarie, date le scarse testimonianze archeologiche relative ai mulini lagunari. La scarsità di ritrovamenti archeologici rende l'analisi storica complessa, ma le sentenze forniscono informazioni preziose sull'evoluzione della proprietà, gestione e utilizzo dei mulini nel tempo.
2. Evoluzione dell Attività Molitoria nella Laguna
Il documento ricostruisce l'evoluzione dell'attività molitoria nella Laguna di Venezia attraverso l'analisi delle sentenze. Si evidenzia una relazione complessa tra l'attività molitoria e le variazioni del livello marino, con fasi di espansione e regressione legate a eventi naturali come alluvioni e trasgressioni marine. Si citano esempi di sentenze che riguardano la concessione di aree per la costruzione di mulini e il loro ripristino dopo eventi calamitosi, come nel caso del Doge Agnello Particiaco (819) e del Doge Tribuno Menio (982). L'analisi mostra come, verso la seconda metà del X secolo, durante una regressione marina, si ripresero le attività molitorie e saline, insediandosi spesso su rovine di strutture altomedievali. L'abbandono definitivo di molti siti, a partire dal XIV secolo, è attribuito all'insalubrità dell'ambiente lagunare a causa dell'esteso impaludamento. Questo quadro evidenzia la dinamicità dell'attività molitoria, in costante adattamento alle condizioni ambientali e alle trasformazioni politiche ed economiche della laguna.
3. Proprietà e Gestione dei Mulini Casi Studio
Il documento approfondisce alcuni casi specifici legati alla proprietà e alla gestione dei mulini, evidenziando la trasformazione della proprietà da collettiva a prevalentemente ecclesiastica. Si fa riferimento a esempi di donazioni, testamenti e contratti di locazione che testimoniano il passaggio dei mulini da un proprietario all'altro, con restauri e modifiche nel tempo. Si analizzano in dettaglio le sentenze relative all'isola di Mazzorbo, citando figure come Marco Mocenigo e Matteo Viaro, mostrando la complessa dinamica di proprietà e gestione dei mulini nel corso dei secoli. Le sentenze analizzate presentano contratti di locazione molto dettagliati, a partire dal XIV secolo, specificando il numero di ruote, le pietre da macina e gli obblighi dell'affittuario nei confronti del monastero proprietario. Si nota una chiara documentazione di contratti di locazione, con obblighi specifici per la manutenzione e l'utilizzo dei mulini, spesso a vantaggio di monasteri o istituzioni religiose. Il lago di Santa Maria degli Angeli, citato come esempio, mostra come l'importanza di un mulino potesse influenzare la toponomastica anche dopo la cessazione della sua attività.
V.Le Macine e le Tecniche di Macinazione
Il documento fornisce una descrizione dettagliata delle macine, specificando le caratteristiche delle pietre, le scanalature (rabigliature) e il loro funzionamento. Si analizzano le differenze nella macinazione a seconda del tipo di grano e la necessità di mantenere la stessa durezza nelle due pietre per evitare un'usura eccessiva. La descrizione tecnica delle macine completa l'analisi della tecnologia dei mulini.
1. Descrizione delle Macine e del loro Funzionamento
La sezione descrive dettagliatamente le macine, il cuore del processo di macinazione nei mulini. Le macine sono costituite da una coppia di dischi di pietra sovrapposti: quella inferiore, fissa, detta fondo o dormiente, poggia su un basamento di legno (palco) e viene mantenuta orizzontale da cunei; quella superiore, mobile, detta coperchio o macina corrente, presenta un foro centrale (occhio della macina) dove viene immesso il cereale. L'occhio della macina, nella parte inferiore, è incavato a forma di farfalla o omega per accogliere la nottola, il perno che trasmette il moto rotatorio dall'albero alla macina superiore. Le dimensioni delle macine sono specificate: spessore di circa 20 cm e diametro variabile tra 100 e 150 cm. Spesso, le macine sono composte da diversi pezzi di pietra uniti da cerchi di ferro. È fondamentale che le due macine abbiano la stessa durezza per evitare un'usura disomogenea e la contaminazione della farina con polvere di pietra. Le superfici macinanti presentano scanalature (a raggiera elicoidale o a settori triangolari, dette rabigliature) per migliorare la frantumazione dei cereali, ridurre l'attrito e facilitare la fuoriuscita della farina.
2. Tipologia di Macinazione e Materiali
Il testo distingue la macinazione in base al tipo di grano e al risultato desiderato. Per la bassa macinazione, dove farina, crusca e cruschello non vengono separati, si preferiscono pietre dure e porose, con un maggior numero di scanalature e una maggiore distanza tra le macine. Per il grano duro, invece, si usano pietre con pori più fini e serrati, con un minor numero di solchi, in quanto il riscaldamento delle superfici è minore. Questa distinzione evidenzia l'adattamento delle tecniche di macinazione alle caratteristiche del grano e alla qualità della farina desiderata. La scelta dei materiali e la lavorazione delle superfici macinanti erano quindi cruciali per l'efficienza e la qualità del processo di macinazione. La cura nella scelta dei materiali e la lavorazione delle pietre dimostra una conoscenza tecnica approfondita del processo di macinazione.
