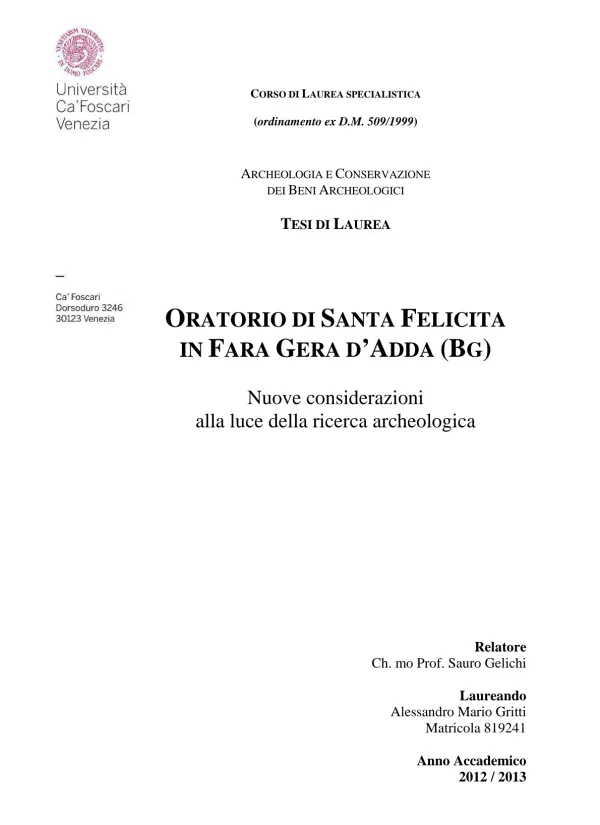
Oratorio S. Felicita: Fara Gera d'Adda
Informazioni sul documento
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 666.70 KB |
Riassunto
I.Scavi Archeologici e Impianto Planimetrico della Chiesa di Sant Alessandro a Fara Gera d Adda
Gli scavi archeologici (Sant'Alessandro di Fara, Fara Gera d'Adda) hanno portato alla luce importanti informazioni sull'impianto planimetrico della chiesa, convalidando le teorie di Pietro Balconi. Sono stati ritrovati i resti di un ingresso laterale e sepolture altomedievali, nonché basamenti di pilastri romani (oggi visibili in Piazzetta Don Pietro Balconi). L'analisi stratigrafica ha rivelato tre livelli di pavimentazione in malta, con una fossa contenente scorie di bronzo, forse indicativa di una fonderia di campane. Un muro con decorazioni pittoriche è stato rinvenuto nella zona absidale. Questi ritrovamenti forniscono preziose informazioni sull'evoluzione della chiesa altomedievale nel corso dei secoli.
1. Scoperta dell Impianto Planimetrico e Convalida delle Teorie di Pietro Balconi
Gli scavi archeologici, estesi su una superficie di circa 7 m³, hanno contribuito a fornire conoscenze più sicure sul passato della chiesa di Sant'Alessandro a Fara Gera d'Adda. In particolare, lo scavo ha permesso di definire con precisione l'impianto planimetrico, convalidando le ipotesi precedentemente formulate da Pietro Balconi. Questo aspetto rappresenta un risultato significativo per la comprensione dell'architettura e della storia della struttura. L'accuratezza dei dati ottenuti dagli scavi ha permesso di ricostruire con maggiore precisione la forma e la disposizione degli spazi interni ed esterni della chiesa, offrendo un quadro più dettagliato dell'edificio nel suo contesto storico. La ricostruzione planimetrica si basa su evidenze concrete emerse dagli scavi, rendendo il risultato più affidabile delle precedenti ipotesi. L'accuratezza dell'impianto planimetrico è stata determinante nella comprensione dell'evoluzione architettonica della chiesa nel tempo, fornendo una solida base per future ricerche.
2. Ritrovamenti di Ingresso Laterale e Sepolture Altomedievali
A ridosso delle fondazioni settentrionali, a 1,20 m sotto la quota del terreno, è stata individuata la soglia di un ingresso laterale, fornendo un'ulteriore informazione sulla struttura e funzionalità dell'edificio. A circa 30 cm sotto la soglia, sono stati ritrovati i resti di due individui, uno subadulto, sepolti in una fossa semplice delimitata da ciottoli di fiume, senza corredo funerario. Questo ritrovamento di sepolture altomedievali arricchisce la conoscenza del contesto sociale e religioso dell'epoca. La scoperta dei resti umani, seppur senza corredo, contribuisce a ricostruire la vita quotidiana e le pratiche funerarie della comunità di Fara Gera d'Adda in età altomedievale. L'orientamento delle sepolture offre ulteriori spunti per l'interpretazione delle credenze religiose e delle pratiche sociali dell'epoca. L'assenza di corredo funerario, invece, potrebbe essere indicativa dello status sociale degli individui o delle pratiche funerarie della comunità locale.
3. Scoperta di Elementi Architettonici Romani e Strati Pavimentali
Proseguendo gli scavi nelle cantine a nord e a sud della struttura, a circa 2,50 m sotto il piano stradale, sono stati riportati alla luce i basamenti di due pilastri e un grande elemento architettonico in marmo d'età romana. Questo elemento, oggi visibile presso la casa coadiutorale in Piazzetta Don Pietro Balconi, testimonia la stratificazione storica del sito. Inoltre, sono stati rinvenuti tre livelli di pavimentazione in malta, il più antico dei quali databile all'alto medioevo. All'interno di quest'ultimo livello, una buca contenente scorie di bronzo e tracce di argilla suggerisce la presenza di una fossa per la fusione di una campana. L'esistenza di più livelli pavimentali evidenzia l'evoluzione della chiesa e delle sue fasi costruttive. L'elemento romano, recuperato dagli scavi, rappresenta una testimonianza pregevole dell'occupazione e delle attività umane nel sito ben prima della costruzione della chiesa. La scoperta della possibile fonderia di campane, databile con difficoltà, fornisce informazioni sulle attività artigianali e sulla tecnologia dell'epoca altomedievale a Fara Gera d'Adda.
4. Resti Altomedievali e Decorazioni Murali
Le indagini lungo i lati settentrionale e occidentale hanno individuato i resti di due fasi altomedievali della chiesa, relative all'ecclesia in honore sancti Alexandri citata nei documenti. Nella zona absidale, è stato rinvenuto un muro di circa 1 m di altezza, costruito con frammenti di tegole romane disposte a spina di pesce. Su questo muro, rivolto a ovest, sono stati rilevati due strati di decorazione pittorica, associabili a differenti piani pavimentali. La scoperta dei resti delle due fasi altomedievali permette di ricostruire l'evoluzione architettonica e funzionale della chiesa di Sant'Alessandro nel corso del tempo. La presenza di decorazioni pittoriche sulle murature, inoltre, fornisce indicazioni preziose sulle tecniche artistiche e sugli aspetti decorativi dell'edificio nel periodo altomedievale. L'utilizzo di materiali di reimpiego, come i frammenti di tegole romane, offre informazioni sul contesto edilizio e sulle pratiche costruttive dell'epoca, arricchendo la conoscenza della storia della chiesa di Sant'Alessandro a Fara Gera d'Adda.
II.Documenti Archivistici e la Storia di Sant Alessandro di Fara
L'analisi di documenti archivistici, principalmente dal Fondo Pergamene della Biblioteca Civica Angelo Mai di Bergamo, ha rivelato quattro privilegi imperiali (diplomi carolingi, Ludovico III, Carlo il Grosso) relativi alla chiesa di Sant'Alessandro di Fara. Questi documenti, tra cui quello considerato la “magna charta della Chiesa di Bergamo”, confermano i diritti di proprietà della diocesi di Bergamo (Bergamo Diocese) sulla chiesa, risalendo a donazioni di re longobardi come Grimoaldo e Cuniperto, e documentando controversie e rivendicazioni di proprietà nel corso dei secoli. Figure chiave: Garibaldo (vescovo), Autprando, Giovanni (vescovo), Adalberto (vescovo). Il documento fornisce dettagli sulla storia della proprietà della chiesa e delle dispute legali che ne hanno contrassegnato l'esistenza. L'analisi dei documenti mette in luce l'importanza storica e politica di Sant'Alessandro di Fara all'interno del contesto più ampio della Chiesa di Bergamo e del Regno Longobardo.
1. Fonti Documentarie e Privilegi Imperiali
La ricerca si basa su documenti archivistici, principalmente provenienti dal Fondo Pergamene della Biblioteca Civica Angelo Mai di Bergamo. Questi documenti, di natura diplomatica, consistono in privilegi emessi da re e imperatori tra la fine del IX e l'inizio del X secolo, riguardanti la cattedra vescovile bergamasca. Sebbene si conoscano diplomi precedenti, solo quattro privilegi altomedievali, specificamente inerenti alla chiesa di Sant'Alessandro di Fara, sono attualmente disponibili. Due di questi sono attribuiti a Carlo il Grosso, mentre gli altri ad Arnolfo e Ludovico il Cieco. Questi documenti offrono informazioni cruciali per ricostruire la storia della chiesa e del suo contesto ecclesiastico. L'analisi di questi diplomi permette di ricostruire la storia delle proprietà della Chiesa, svelando una complessa rete di rapporti tra il potere imperiale e le autorità ecclesiastiche locali. Lo studio si concentra su una selezione di documenti e sulle loro implicazioni storiche, analizzando il linguaggio e il contesto in cui sono stati redatti.
2. Il Privilegio di Carlo il Grosso e la Restituzione dei Beni
Un privilegio imperiale di Carlo il Grosso, emesso dopo la sua successione al trono d'Italia nell'879, è particolarmente importante. In questo documento, l'imperatore, dopo aver visionato documenti dei suoi predecessori (da Carlo Magno in poi) esibitigli da Garibaldo, vescovo di Bergamo, riconferma alla diocesi i diritti di proprietà sulla chiesa di Sant'Alessandro di Fara, sottratta in precedenza da alcuni 'mali homines'. Come risarcimento, l'imperatore dona il monastero di San Michele in Cerreto. L'imperatore inoltre menziona un precedente decreto che affidava l'amministrazione di San Michele in Cerreto ad Autprando, sotto la condizione del ripristino dell'uso monastico e del pagamento di tributi alla diocesi. Questo documento evidenzia il ruolo del potere imperiale nella gestione dei beni ecclesiastici e le controversie relative alla proprietà della Chiesa di Sant'Alessandro. Il privilegio evidenzia sia il potere temporale dell'Impero, sia la necessità di proteggere il patrimonio della Chiesa da abusi e appropriazioni indebite. L'atto di donazione del monastero rappresenta una forma di risarcimento per i danni subiti dalla diocesi e sottolinea la relazione tra potere imperiale e Chiesa.
3. Il Primo Privilegio Carolingio e l Immunità Episcopale
Il primo dei privilegi carolingi, menzionato nel XV secolo nel Liber Censualis di Giovanni Barozio, è considerato la "magna charta della Chiesa di Bergamo". Sebbene inizialmente ritenuto una falsificazione da Luigi Schiaparelli, Paul Kehr ne ha confermato l'autenticità. Questo diploma, di grande importanza per l'intera chiesa bergamasca, contiene la prima dichiarazione esplicita di immunità assoluta per i beni episcopali. Le sue radici potrebbero risalire ad un diploma perduto di Ludovico II. Il documento rimedia alle appropriazioni illecite di beni ecclesiastici a Fara, forse causate dai disordini dell'875 a seguito dell'occupazione militare di Berengario del Friuli e Carlo III. Questo documento mette in luce l'importanza del controllo dei beni ecclesiastici da parte delle autorità ecclesiastiche e l'intervento dell'imperatore a sostegno di tale controllo. L'immunità concessa rappresenta un'eccezione ai poteri dell'autorità laica, consolidando il potere della chiesa e dei suoi beni. Le origini del privilegio e i riferimenti ai conflitti dell'875 forniscono spunti per interpretare il contesto storico del documento.
4. Ulteriori Diplomi e la Situazione Dopo la Morte di Carlo il Grosso
Il periodo successivo alla morte di Carlo il Grosso (888) fu caratterizzato da lotte per il potere in Italia settentrionale, coinvolgendo figure come Berengario del Friuli, Guido di Spoleto, suo figlio Lamberto, e Arnolfo di Carinzia. Un terzo diploma, di cui resta una copia del XII secolo, evidenzia la situazione caotica. Adalberto, vescovo di Bergamo, probabilmente sotto pressione dei Guidoni, ottenne dal re la conferma dei privilegi concessi in passato. L'imperatore conferma i privilegi dei re longobardi e fa riferimento ad un diploma di Carlo III e una bolla papale, ribadendo i diritti sulla chiesa di Fara e altri beni. Questo periodo di instabilità politica si riflette nei documenti, evidenziando le sfide e i tentativi di preservare i diritti ecclesiastici in un contesto di conflitti e cambiamenti di potere. La conferma dei privilegi da parte del sovrano evidenzia il tentativo di stabilire una certa continuità istituzionale e di affermare l'autorità imperiale e la protezione del patrimonio ecclesiastico.
5. Il Diploma di Ludovico III e le Falsificazioni
Un ulteriore diploma di Ludovico III, conservato nella Biblioteca Civica Angelo Mai, è stato oggetto di analisi. Si tratta di una falsificazione dell'XI secolo, imitazione di un originale, che mescola elementi di tre diplomi precedenti. Questo diploma ribadisce i benefici concessi alla diocesi di Bergamo, ma la sua natura di falsificazione mette in discussione l'attendibilità di alcune informazioni. Il documento sottolinea la complessità dell'analisi delle fonti storiche e la necessità di un'attenta critica del testo. Questo documento falsificato, comunque, testimonia il valore dei privilegi imperiali e la loro importanza nella protezione del patrimonio ecclesiastico. La scoperta della falsificazione ci ricorda la necessità di un approccio critico e analitico all'interpretazione delle fonti storiche.
III.Fasi Costruttive della Basilica e Analisi Architettonica
Lo studio ha individuato diverse fasi costruttive della basilica. La Fase II è caratterizzata da un impianto planimetrico specifico, mentre la Fase III , probabilmente ricostruita tra IX e X secolo, presenta ampi tratti di muratura ancora visibili. L'utilizzo di materiali da edifici precedenti (spolio) è evidente. L'analisi architettonica suggerisce una committenza locale influenzata dagli stili della corte longobarda, con soluzioni ambiziose, ma con alcune irregolarità costruttive. L'edificio presenta elementi architettonici di prestigio, anche se l'assenza di colonne suggerisce una committenza non di livello regale. L'analisi architettonica evidenzia l'evoluzione stilistica nel tempo, riflettendo anche le dinamiche sociali e politiche del periodo.
1. Fasi Costruttive Dall Alto Medioevo al Tardo Medioevo
L'analisi architettonica della basilica di Sant'Alessandro di Fara rivela una complessa stratificazione di fasi costruttive. La presenza di resti di due fasi altomedievali, individuati durante gli scavi, indica una lunga storia edilizia. Queste fasi mostrano una successione di interventi, modifiche e ristrutturazioni nel tempo, riflettenti cambiamenti stilistici e funzionali. La sovrapposizione di diversi strati, evidenziata dagli scavi archeologici, testimonia la continua evoluzione della basilica nel corso dei secoli, adattandosi alle esigenze e alle risorse disponibili in ciascun periodo storico. L'analisi stratigrafica ha rivelato la presenza di tre livelli di pavimentazione in malta, con quello inferiore attribuibile alla fase altomedievale più antica. Questi strati, insieme ad altri reperti, consentono la ricostruzione delle diverse fasi costruttive e la comprensione dei processi di trasformazione dell'edificio nel tempo. La complessità delle fasi costruttive indica la lunga durata della storia della basilica e la sua importanza nel contesto di Fara Gera d'Adda.
2. Analisi Architettonica della Fase III Basilica Altomedievale
La Fase III, databile con buona probabilità tra l'ultimo quarto del IX secolo e la prima metà del X, è quella meglio conservata. Ampi tratti di muratura sono ancora in elevato, consentendo una chiara ipotesi ricostruttiva, anche per la Fase II, nonostante i resti di quest'ultima siano limitati alle fondazioni. Si ipotizza una sostanziale affinità architettonica tra le due fasi, pur con lievi differenze. L'analisi si concentra sulle caratteristiche architettoniche della basilica, evidenziando l'utilizzo di materiali da spolio, tipico dell'edilizia altomedievale, a causa del collasso del sistema economico tardoromano. L'analisi dettagliata dei laterizi, di tipo sesquipedale, con dimensioni compatibili con la produzione romana, mostra l'uso di materiali di buona qualità disposti con cura. L'analisi architettonica di questa fase fornisce informazioni sulla committenza e sul contesto sociale che ha portato all'edificazione o alla ristrutturazione della basilica in questo periodo storico, mostrando l'influenza degli stili in voga presso la corte longobarda di metà VIII secolo. L'architettura dell'edificio si configura come un esempio di architettura altomedievale di prestigio.
3. Elementi Architettonici Residui e Ipotesi Ricostruttive
La scarsità di resti in elevato della Fase II ha reso necessario fare affidamento sulla struttura della Fase III per le ipotesi ricostruttive. Il prospetto dell'attuale oratorio è arretrato di oltre 5 metri rispetto alla basilica antica, impostandosi al livello della campata centrale. L'unico elemento preservato della Fase II è un arco ad andamento nord-sud, inglobato nella casa coadiutorale, probabilmente ciò che resta dell'ingresso principale. L'arco, con una luce di circa 2 metri, si allinea con l'asse della facciata e con la porta dell'edificio delle Fasi II-III. L'analisi dei materiali da costruzione, la tecnica costruttiva e la planimetria offrono dettagli preziosi sulla tipologia architettonica e sulle tecniche edilizie del periodo. L'analisi comparativa con altre strutture simili del periodo contribuisce a comprendere meglio l'architettura e l'evoluzione della basilica di Sant'Alessandro di Fara. L'arco rappresenta un frammento chiave per la comprensione dell'ingresso principale e dell'orientamento della basilica.
4. Committenza e Influenza della Monarchia
Sebbene le fonti non consentano di identificare con certezza la committenza della basilica (religiosa o laica, pubblica o privata), è evidente il desiderio di evidenziare relazioni sociali e politiche con gli ambienti di corte. A Bergamo, il controllo diretto della corona tramite il gastaldo era molto forte dopo la soppressione del ducato. A Fara, l'influenza monarchica era particolarmente intensa, essendo il villaggio parte del fisco regio. La basilica è quindi inserita nel quadro di ripresa edilizia della fine del VII secolo, interpretata da Gian Pietro Brogiolo come risultato della rivalità politica tra le corti del regno, che ha generato una competizione sociale tra le élites, portando a cospicui investimenti in architettura. La qualità della manodopera e le soluzioni architettoniche ambiziose, come le proporzioni auree e i rinforzi perimetrali, indicano un'importante committenza, probabilmente locale ma influenzata dagli stili in voga presso la corte longobarda. L'analisi della committenza permette di contestualizzare la basilica nel contesto sociale, politico ed economico del periodo. L'assenza di colonne, elemento decorativo d'eccellenza in chiese di fondazione regia, suggerisce una committenza di carattere più locale, pur colta ed influenzata dagli stili della corte longobarda. L'analisi approfondita di queste caratteristiche è fondamentale per comprendere il ruolo di Sant'Alessandro di Fara nel contesto della storia architettonica dell'Alto Medioevo.
IV.Il Periodo Tardo Medievale e le Tensioni tra la Chiesa e Milano
Nel periodo tardo-medioevale, la chiesa di Sant'Alessandro è coinvolta in dispute territoriali tra la diocesi di Bergamo e Milano. Il diploma di Federico Barbarossa del 1156 conferma i diritti del vescovo di Bergamo, ma le tensioni persistono. Il Rotulum Episcopatus Bergomi documenta controversie con la comunità di Fara (Fara Gera d'Adda), con la sottrazione di proprietà da parte di cittadini milanesi. Figure chiave: Gerardo (vescovo), Guala (vescovo), Giovanni da Scanzo (vescovo). La scomunica di Fara da parte di Giovanni da Scanzo nel 1306 evidenzia la gravità dei conflitti. La documentazione sottolinea le complessità politiche e amministrative del periodo e gli effetti sulle comunità locali.
1. Il Diploma di Federico Barbarossa e l Affermazione del Potere Vescovile
Il periodo tardo-medievale vede l'affermarsi del potere vescovile a Fara Gera d'Adda, in seguito al diploma imperiale di Federico Barbarossa del 17 giugno 1156. Questo documento, emesso a Vuirceburg per intercessione del cancelliere Regennoldo, accoglie le richieste di Gerardo, vescovo di Bergamo, riconfermando in perpetuo le proprietà della diocesi. Il diploma ribadisce i diritti del vescovo su ampi territori, inclusi i castelli di Azzano e Seriate e le valli Seriana e Brembana, confermando un'autorità estesa e significativa. Il documento concede al vescovo omnia regalia et magnitudines de comitatu Pergamensi, ovvero la sovranità sul comitato bergamasco, con tutti i diritti feudali annessi. Questo atto segna un momento chiave nella storia di Fara, affermando il potere della Chiesa di Bergamo e dando inizio ad un lungo periodo di tensioni con altre autorità. L'importanza del diploma sta nell'estensione dei poteri concessi al vescovo, che vanno ben oltre la semplice giurisdizione religiosa. La concessione della sovranità rappresenta un'espansione significativa del potere temporale del vescovado di Bergamo.
2. Tensioni tra Fara il Vescovo di Bergamo e Milano
L'ascesa del potere vescovile a seguito del diploma di Barbarossa non fu priva di conflitti. Fara si trovò nel mezzo di tensioni tra il nuovo potere vescovile e la giurisdizione milanese, consolidata lungo la riva bergamasca dell'Adda. Il Rotulum Episcopatus Bergomi (1258) documenta la presenza di milanesi a Fara (Giovanni e Amizo de Landriano) e la loro sottrazione di proprietà e diritti al vescovo. Questa situazione di attrito si protrasse nel tempo. Nel 1160, Fara era ancora sotto controllo milanese, subendo l'assedio delle truppe imperiali. I consoli faresi si rifiutarono ripetutamente di rinnovare i vincoli feudali con il vescovo, portando a dure reazioni da parte della Curia. Le tensioni tra il potere vescovile di Bergamo e l'influenza milanese su Fara si protrassero per lungo tempo, creando un clima di instabilità politica e sociale. La resistenza dei consoli di Fara a sottomettersi all'autorità del vescovo di Bergamo evidenzia le complessità dei rapporti di potere locali e l'influenza di altre entità politiche, come Milano, sull'area.
3. Compromessi e Scomuniche Il Caso di Giovanni da Scanzo
I vescovi di Bergamo cercarono di risolvere pacificamente le tensioni con Fara attraverso compromessi e convenzioni, come le esenzioni fiscali del 1178 concesse da Guala. Tuttavia, le tensioni persistettero, culminando nella dura reazione di Giovanni da Scanzo nel 1306. A seguito di ripetuti rifiuti da parte dei consoli faresi di prestare giuramento di fedeltà al vescovo, Giovanni da Scanzo scomunicò i Consules, Canevarios, Consiliarios e Officiales, ponendo Fara sotto interdetto. Questo atto ebbe conseguenze drastiche sulla vita religiosa della comunità per un decennio, con la sospensione dei riti religiosi, ad eccezione del battesimo e dell'eucarestia ai moribondi. La scomunica di Fara da parte di Giovanni da Scanzo dimostra il grado di conflitto tra la comunità di Fara e l'autorità ecclesiastica. La drastica misura di porre l'intera comunità sotto interdetto evidenzia l'importanza del controllo ecclesiastico e la determinazione del vescovo ad imporre la sua autorità.
4. Verso una Nuova Dedicazione Santa Felicita
Dopo la scomunica del 1306, Fara fu riammessa ai divini offici e ai sacramenti, e la chiesa di Sant'Alessandro sottoposta a una visita di riforma. Nel 1359, compare per la prima volta la dicitura "in ecclesia S. Felicitatis scita in castro de Fara Ripe Adue", indicando la nuova dedicazione della basilica. La mancanza di maggiori informazioni archeologiche e le difficoltà archivistiche, dovute all'omonimia delle parrocchiali di Fara, lasciano aperte molte domande sulla transizione. Il passaggio dalla dedicazione a Sant'Alessandro a quella a Santa Felicita segnala un evento importante nella storia di Fara. La nuova dedica può essere legata a diversi fattori, tra cui la necessità di riconsacrare la chiesa dopo i danni o la scelta di un nuovo patrono per la comunità. La scarsità di informazioni e la complessità delle ricerche archivistiche rappresentano una sfida nella ricostruzione precisa della storia.
V.Analisi Paleopatologica dei Resti Umani
L'analisi paleopatologica dei resti ossei rinvenuti negli scavi di Fara Gera d'Adda rivela informazioni sulle condizioni di vita della popolazione. L'alta incidenza di tubercolosi bovina e di anemia, insieme a problemi dentali, suggerisce una dieta povera e condizioni di salute precarie. Le entesopatie indicano un duro lavoro fisico. Questa analisi fornisce uno spaccato sulla salute e sulle condizioni di vita della popolazione di Fara Gera d'Adda nel periodo considerato. L'analisi offre un'immagine più completa del contesto sociale ed economico della comunità.
1. Analisi Paleopatologica e Condizioni di Vita a Fara Gera d Adda
L'analisi paleopatologica dei resti ossei provenienti dalla necropoli di Fara Gera d'Adda fornisce informazioni cruciali sulle condizioni di vita della popolazione. L'analisi ha evidenziato la presenza di diverse patologie, offrendo spunti significativi per la comprensione delle condizioni di salute e delle abitudini della comunità. In particolare, si evidenzia la presenza di tubercolosi bovina in tre individui, suggerendo l'allevamento e il consumo di prodotti derivati dai bovini. L'alto numero di casi di cribra orbitalia (12 individui) indica un'alta incidenza di anemia, probabilmente dovuta a una dieta carente. Inoltre, 17 casi di ipoplasia dello smalto e 6 di carie nei subadulti suggeriscono un'alimentazione di scarsa qualità, con carenze nutrizionali e un'assunzione di zuccheri poco controllata. L'analisi dei resti scheletrici permette di ricostruire lo stile di vita e le condizioni sanitarie della popolazione di Fara Gera d'Adda. Le patologie riscontrate offrono uno spaccato importante sulle condizioni di vita e sulle sfide affrontate dalla comunità locale in termini di salute e alimentazione.
2. Segni di Stress Fisico e Attività Occupazionali
L'analisi dei resti ossei ha rivelato anche segni di stress fisico legati alle attività occupazionali. La presenza di entesopatie in circa il 44% dei reperti esaminati indica un lavoro faticoso e ripetuto. Le infiammazioni delle inserzioni a livello clavicolare suggeriscono sforzi reiterati connessi a lavori di trasporto di oggetti sulle spalle. Le entesopatie agli arti inferiori (area femorale e tibiale) indicano una deambulazione su terreni irregolari, con conseguente sforzo costante delle gambe. L'analisi dei segni di stress sui resti scheletrici offre informazioni preziose sulle attività lavorative e sulle condizioni fisiche della popolazione di Fara Gera d'Adda. La combinazione di patologie e segni di stress fisico indica un lavoro agricolo o manuale impegnativo, caratterizzato da sforzi fisici intensi e ripetuti, con un impatto negativo sulla salute degli individui. L'analisi di questi reperti completa il quadro delle condizioni di vita e del contesto sociale ed economico della comunità.
VI.Fase Finale e Dedica a Santa Felicita
La chiesa di Sant'Alessandro, in seguito a probabili danni strutturali, viene ridedicata a Santa Felicita. La documentazione del XVI secolo evidenzia lavori di riparazione e la successiva assegnazione della chiesa alla Scuola del Santissimo Sacramento. La presenza di un portico, documentato nel XVIII secolo, arricchisce ulteriormente la storia della struttura. L'ultima sezione descrive l'evoluzione dell'edificio nel periodo post-medievale e la sua attuale dedicazione a Santa Felicita.
1. Dalla Chiesa di Sant Alessandro all Oratorio di Santa Felicita
La sezione finale del documento tratta della fase conclusiva della storia dell'edificio, segnata dalla transizione dalla dedicazione a Sant'Alessandro a quella a Santa Felicita. Questa evoluzione, documentata a partire dal 1359 con la comparsa della dicitura "in ecclesia S. Felicitatis", lascia aperte diverse questioni interpretative. La mancanza di dati archeologici specifici e la difficoltà delle ricerche archivistiche, accentuata dall'omonimia delle due parrocchie di Fara, rendono incerta la comprensione del processo di cambiamento. La nuova dedicazione rappresenta una svolta significativa nella storia dell'edificio, segnando una nuova fase nella sua vita e nel suo utilizzo all'interno della comunità. Il documento evidenzia il passaggio di denominazione e le difficoltà di indagine a causa di mancanza di documenti e di omonimie.
2. Lavori di Restauro e la Scuola del Santissimo Sacramento
La documentazione successiva al passaggio di denominazione, in particolare quella del XVI secolo, indica la presenza di lavori di restauro sull'edificio. Una visita di Gerolamo Regazzoni nel 1578 documenta l'esecuzione di lavori di riparazione alla cappella maggiore, descritti come interventi per rendere la struttura più robusta e idonea alle celebrazioni religiose. Il testo cita la "serraglia" e l'apertura degli altari, indicando che l'edificio non era più in rovina, ma restaurato e di nuovo utilizzabile. L'affidamento dell'edificio alla Scuola del Santissimo Sacramento tra il 1555 e il 1564 potrebbe essere correlato a questi lavori di ripristino, indicando un nuovo utilizzo per lo spazio. L'analisi di questi interventi mostra la volontà di preservare e riutilizzare l'edificio, adattandolo alle necessità della comunità. La Scuola del Santissimo Sacramento, istituita alcuni anni prima dei lavori, sembra aver avuto un ruolo fondamentale nel processo di riqualificazione e riutilizzo dell'oratorio di Santa Felicita.
3. Documentazione del XVIII Secolo e la Conclusione
La documentazione del XVIII secolo è scarsa. Un elemento significativo è una lettera del 1700 da Santo Saiguini, parroco di Fara, al vescovo Luigi Ruzzini, che cita la costruzione di un portico sul lato settentrionale dell'oratorio, oggi scomparso. Il portico è rappresentato anche nelle mappe del Catasto Teresiano del 1722. La menzione del portico, anche se oggi non più esistente, fornisce un'ulteriore informazione sull'aspetto e sulla funzionalità dell'oratorio nel corso del tempo. La presenza del portico sul lato nord dell'edificio, documentata anche da mappe cartografiche, suggerisce un utilizzo dell'area esterna e una connessione tra lo spazio interno ed esterno dell'oratorio. La lettera di Santo Saiguini al vescovo Luigi Ruzzini rappresenta una testimonianza diretta dell'aspetto e del funzionamento dell'oratorio nel XVIII secolo.
