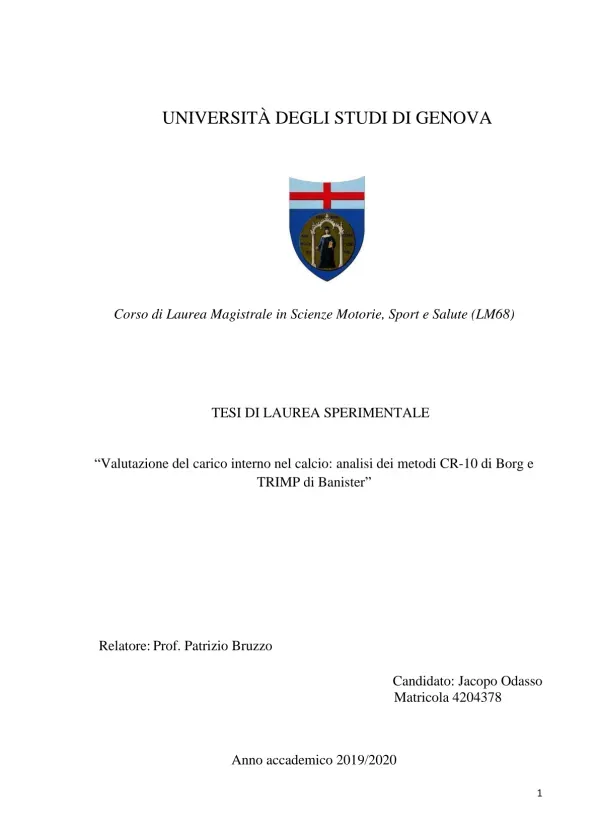
Carico interno calcio: Borg e TRIMP
Informazioni sul documento
| Autore | Jacopo Odasso |
| instructor | Prof. Patrizio Bruzzo |
| Scuola | Università Degli Studi Di Genova |
| Specialità | Scienze Motorie, Sport e Salute (LM68) |
| Tipo di documento | Tesi Di Laurea Sperimentale |
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 1.39 MB |
Riassunto
I.Metodi di Valutazione del Carico di Allenamento nel Calcio
Questo studio sperimentale confronta due metodi per la valutazione del carico di allenamento nel calcio: il metodo Borg CR-10 e il metodo TRIMP. L'obiettivo è determinare la correlazione tra la fatica percepita (misurata con la scala CR-10) e il carico di allenamento effettivo (calcolato con TRIMP) in giocatori dilettanti. Si analizzano parametri come il carico di allenamento, l'indice di monotonia, e la fatica acuta, confrontando i risultati settimanalmente e per singola seduta. L'analisi si concentra sulla preparazione atletica e sulla valutazione della fatica post-allenamento, cruciali per una corretta periodizzazione del carico fisico.
1. Introduzione ai Metodi di Valutazione del Carico di Allenamento
La sezione iniziale pone le basi per la comprensione dell'importanza della valutazione del carico di allenamento nel calcio. Si sottolinea come la preparazione fisica sia fondamentale per il successo agonistico, richiedendo un allenamento costante e mirato per raggiungere una condizione fisica ottimale. La valutazione della fatica, sia percepita che reale, è un aspetto cruciale, rilevante sia per l'allenatore che, soprattutto, per il preparatore atletico. Quest'ultimo, infatti, ha la responsabilità di creare programmi di allenamento, periodizzazioni del carico fisico e micro-cicli di allenamento, adattandoli costantemente alle condizioni dei giocatori. La capacità di modificare l'intensità dell'allenamento in base alla stanchezza fisica e mentale dei calciatori è essenziale per evitare infortuni e massimizzare le prestazioni. Il documento introduce l'analisi del carico di allenamento, dell'indice di monotonia e della fatica acuta, parametri chiave per valutare l'efficacia e la sicurezza dell'allenamento. L'obiettivo è confrontare questi dati settimanalmente e in base alle sedute totali, analizzando le variazioni di tendenza sia con il metodo CR-10 che con il metodo TRIMP, sia a livello complessivo che per singolo atleta, concentrandosi sulla seduta del martedì, la più intensa del microciclo.
2. Il Metodo Borg CR 10 Valutazione Soggettiva della Fatica
Il documento descrive il metodo Borg CR-10 come uno strumento semplice, economico, pratico e non invasivo per la valutazione della fatica percepita dai calciatori. La scala CR-10, basata su dieci livelli di percezione dello sforzo (da 0.5, estremamente leggero, a 10, estremamente forte), permette di quantificare la fatica soggettiva al termine di ogni seduta di allenamento. Sebbene il livello 10 rappresenti una fatica massima raramente raggiunta durante una partita, il metodo fornisce informazioni preziose per la programmazione degli allenamenti successivi. L'utilizzo di un questionario individuale per ogni atleta è stato fondamentale per evitare influenze reciproche tra i giocatori e garantire la sincerità delle risposte, in quanto la valutazione della fatica è soggettiva. Ogni atleta ha avuto circa 30 secondi-1 minuto per rispondere, concentrandosi sulla propria condizione fisica.
3. Il Metodo TRIMP Valutazione Oggettiva del Carico di Allenamento
Il documento presenta il metodo TRIMP come un approccio quantitativo alla valutazione del carico di allenamento, basato sulla frequenza cardiaca. A differenza del metodo CR-10, che si concentra sulla percezione soggettiva, il TRIMP offre una misura più oggettiva del carico esterno. Per semplificare la raccolta dati, si è scelto un metodo diretto di misurazione della frequenza cardiaca, senza utilizzare cardiofrequenzimetri. La frequenza cardiaca è stata rilevata in tre momenti cruciali della seduta di allenamento (FC1, FC2, FC3), al termine dell’attivazione, del lavoro principale e della partitella finale, per poi calcolare la frequenza cardiaca media. Questi dati sono stati poi utilizzati nella formula di calcolo del TRIMP, fornendo un valore numerico che indica l'intensità dell'allenamento. La facilità di utilizzo del metodo, grazie alla precedente preparazione degli atleti, ha permesso di raccogliere dati in modo efficiente e senza ritardi significativi durante le sedute.
4. Confronto tra i Metodi CR 10 e TRIMP e Analisi della Fatica Acuta
La parte centrale del documento si concentra sul confronto tra i due metodi di valutazione del carico di allenamento, il CR-10 e il TRIMP. L’analisi mira a individuare una possibile correlazione tra la fatica percepita (CR-10) e il carico effettivo (TRIMP). Si è calcolata la fatica acuta moltiplicando la media del carico di allenamento per l'indice di monotonia. Valori elevati di fatica acuta indicano un rischio maggiore di infortuni. L'analisi dei dati ha evidenziato una correlazione positiva tra i due metodi in circa il 61% dei casi, suggerendo una certa congruenza tra la fatica percepita e il carico di allenamento effettivo. Tuttavia, la soggettività del metodo CR-10, influenzata da fattori individuali e contestuali, ha portato a discrepanze in alcuni casi, evidenziando la necessità di considerare anche altri parametri oltre alla semplice correlazione numerica tra i due metodi. Si è notata una maggiore discrepanza tra i due metodi nelle sedute meno intense.
II.Il Protocollo di Ricerca Misurazione della Frequenza Cardiaca e Percezione dello Sforzo
La ricerca ha coinvolto 10 giocatori della squadra dilettantistica Baia Alassio (Alassio, Savona), escludendo i portieri per la diversità di allenamento. Sono stati raccolti dati sulla frequenza cardiaca (FC) in tre momenti chiave di ogni seduta di allenamento (FC1, FC2, FC3) per il calcolo del TRIMP. Contestualmente, i giocatori hanno valutato la fatica percepita utilizzando la scala Borg CR-10 al termine di ogni seduta. I materiali utilizzati sono stati semplici: questionari CR-10 e moduli per la registrazione della FC. L'analisi dei dati ha considerato la varianza dei metodi CR-10 e TRIMP, seduta per seduta e per singolo atleta, per valutare l'affidabilità di entrambi gli approcci nella valutazione del carico interno.
1. Selezione dei Soggetti e Raccolta Dati
Lo studio ha coinvolto 10 giocatori della squadra di calcio dilettantistica Baia Alassio, escludendo i portieri per l'omogeneità dei dati. La scelta dei giocatori ha considerato la loro disponibilità e la propensione a infortuni, evitando di compromettere l'allenamento della squadra. Prima dell'inizio della raccolta dati, ogni atleta è stato informato dettagliatamente sulle procedure e ha fornito il consenso informato alla partecipazione. La raccolta dati sulla frequenza cardiaca è stata condotta in tre momenti specifici di ogni allenamento: al termine dell'attivazione (FC1), al termine dell'esercizio più intenso (FC2) e al termine della partitella finale (FC3). Questo protocollo ha permesso di monitorare l'andamento della frequenza cardiaca durante le diverse fasi dell'allenamento, fornendo dati più precisi e completi sull'intensità dello sforzo. La scelta di questi tre punti specifici nella sessione di allenamento è giustificata dalla necessità di avere un dato rappresentativo delle diverse fasi di intensità tipiche di un allenamento di calcio, da quelle di riscaldamento a quelle di massima intensità e sforzo.
2. Metodi di Misurazione Frequenza Cardiaca e Scala CR 10
La frequenza cardiaca è stata misurata direttamente dagli atleti stessi, senza l'utilizzo di cardiofrequenzimetri, per semplificare la procedura e ridurre i costi. Questo metodo diretto, seppur meno preciso di un cardiofrequenzimetro, si è rivelato efficace per la raccolta dei dati, grazie alla previa preparazione degli atleti che hanno dimostrato di saper rilevare autonomamente le proprie pulsazioni in modo corretto. La scelta del metodo diretto ha privilegiato la praticità e l'accessibilità, rendendo la raccolta dei dati più semplice e veloce durante le sedute di allenamento. Contestualmente alla misurazione della frequenza cardiaca, i giocatori hanno compilato un questionario utilizzando la scala Borg CR-10 per valutare la fatica percepita al termine di ogni allenamento. La somministrazione del questionario CR-10 è avvenuta individualmente, per evitare influenze reciproche tra i giocatori. L’utilizzo di un questionario per ogni atleta è stata una scelta strategica per garantire la massima concentrazione individuale nella valutazione della fatica, prevenendo possibili distorsioni dei risultati dovute a confronti o influenze esterne.
3. Gestione Pratica della Raccolta Dati Durante le Sedute di Allenamento
Il processo di raccolta dati è stato integrato nelle sedute di allenamento, cercando di minimizzare l'interruzione delle attività. I 10 giocatori coinvolti si sono brevemente allontanati dal gruppo per circa un minuto per misurare la frequenza cardiaca nei tre momenti prestabiliti. Questa procedura ha garantito che la raccolta dei dati non interferisse significativamente con l'allenamento. I materiali utilizzati sono stati molto semplici: questionari CR-10, moduli per la registrazione della frequenza cardiaca e penne. La facilità di esecuzione della procedura di raccolta dei dati ha contribuito all'efficienza del protocollo di ricerca, minimizzando i tempi di interruzione dell'allenamento. La presenza dei materiali necessari direttamente a bordo campo (e non nello spogliatoio) ha permesso di velocizzare la procedura, limitando i tempi morti. La curiosità di molti altri giocatori della squadra ha ulteriormente facilitato la raccolta dei dati.
III.Descrizione delle Sedute di Allenamento della Baia Alassio
Il microciclo di allenamento della Baia Alassio, squadra di Prima Categoria (girone A regionale) che al momento dello studio occupava l’8° posto in classifica, consisteva in tre allenamenti settimanali (martedì, mercoledì, venerdì) della durata di circa 90 minuti. Le sedute includevano fasi di riscaldamento (partita a campo ridotto, corsa lenta, stretching), lavoro aerobico (navette), lavoro anaerobico (esercizi pliometrici, partitelle 3vs2), e una fase finale con partitella a campo ridotto. L'allenamento del martedì era considerato il più intenso. La squadra è composta da 21 giocatori, con uno staff tecnico che include allenatore, vice-allenatore, due preparatori atletici, e altri ruoli dirigenziali.
1. Struttura del Microciclo di Allenamento
Il documento descrive il microciclo di allenamento della squadra Baia Alassio, militante nel campionato di Prima Categoria girone A regionale. Questo microciclo, organizzato per facilitare la partecipazione dei giocatori che lavorano, prevede tre allenamenti settimanali (martedì, mercoledì e venerdì) di circa un'ora e mezza ciascuno, con inizio alle ore 20:15. Le partite di campionato si svolgono la domenica allo stadio comunale Ferrando di Alassio. La stagione 2019/20 ha visto la Baia Alassio partecipare anche alla Coppa Liguria, raggiungendo, al momento della stesura del documento, l'ottavo posto in classifica a soli quattro punti dalla zona playoff. Il campionato di Prima Categoria è composto da 14 squadre suddivise in due gironi (andata e ritorno), per un totale di 26 giornate. I playoff sono riservati alle squadre classificate dal secondo al sesto posto. La squadra è composta da 21 giocatori e da uno staff tecnico completo, con allenatore, vice allenatore, due preparatori atletici, allenatore dei portieri, dirigenti e altre figure.
2. Dettaglio delle Fasi di Allenamento
La descrizione delle sedute di allenamento evidenzia una struttura ben definita. Il riscaldamento inizia con una partita a campo ridotto (25x10m) con l'obiettivo di aumentare la temperatura corporea e di lavorare sulla tecnica individuale. Segue una fase di corsa lenta e stretching dinamico per la mobilità articolare, concludendo il riscaldamento con due accelerazioni sui 30 metri. La fase centrale dell'allenamento prevede esercizi di diversa intensità: lavoro aerobico con navette, esercizi pliometrici e partitelle a campo ridotto (3vs2) per allenare forza, resistenza e tecnica. Un esercizio chiamato “Temple Run” alterna corsa ad alta intensità a recupero attivo. C’è poi una fase di lavoro a squadra che si concentra su tecnica, visione di gioco e sulla simulazione di transizioni di gioco, con giocatori disposti in settori del campo a seconda del ruolo. L’allenamento culmina con una partitella a campo ridotto (70x50m) che rappresenta la fase più simile alla competizione, allenando diverse capacità fisiche e mentali. La durata e l’intensità di alcuni esercizi sono variabili a discrezione dell’allenatore.
3. Obiettivi Specifici degli Esercizi di Allenamento
Gli obiettivi degli esercizi proposti sono mirati a migliorare specifiche capacità fisiche e tecniche dei giocatori. Il riscaldamento, oltre ad aumentare la temperatura corporea, prepara i giocatori mentalmente all'allenamento. Il lavoro aerobico mira a migliorare la capacità cardiovascolare e l'utilizzo dell'ossigeno da parte dei muscoli. Gli esercizi pliometrici e le partitelle a campo ridotto sviluppano forza, resistenza alla velocità e capacità anaerobiche. Il “Temple Run” è pensato per un recupero attivo, mentre gli esercizi a squadra, con diversi livelli di intensità e spazi di gioco, mirano a migliorare la tecnica individuale, la visione di gioco, la resistenza specifica e l'intesa tra i compagni. La partitella finale a campo ridotto simula una partita vera, allenando tutte le capacità fisiche e mentali necessarie per la competizione. In generale, gli esercizi sono studiati per sviluppare le diverse capacità necessarie per un giocatore di calcio di livello dilettantistico.
IV.Risultati e Conclusioni Correlazione tra i Metodi CR 10 e TRIMP
L'analisi dei 36 dati raccolti ha evidenziato una correlazione positiva nel 61.11% dei casi tra i metodi CR-10 e TRIMP nella valutazione del carico di allenamento. Questo risultato conferma la potenziale validità di entrambi i metodi per la valutazione della fatica nel calcio. Tuttavia, la soggettività della scala Borg CR-10, influenzata da fattori extra-sportivi, ha portato a discrepanze in alcuni casi. L'analisi ha inoltre evidenziato differenze nel carico interno tra le sedute, con l'allenamento del martedì che si è dimostrato il più intenso in termini di frequenza cardiaca e fatica percepita. I valori di TRIMP si sono attestati tra 5.43 e 88.90, indicando una fatica medio-bassa.
1. Analisi della Correlazione tra i Metodi CR 10 e TRIMP
L'analisi dei dati, basata su 36 osservazioni raccolte durante quattro sedute di allenamento, ha rivelato una correlazione positiva tra il metodo Borg CR-10 (percezione soggettiva della fatica) e il metodo TRIMP (carico di allenamento oggettivo) nel 61.11% dei casi. Questo dato suggerisce una certa congruenza tra la fatica percepita dagli atleti e il carico di allenamento effettivamente svolto. La correlazione positiva si è manifestata in modo più evidente nelle sedute con maggiore intensità. Tuttavia, la percentuale non è totalmente schiacciante, con il 38.89% dei casi che non ha mostrato una correlazione positiva. Questa discrepanza è attribuibile alla soggettività del metodo CR-10, che può essere influenzato da fattori individuali e contestuali, come la motivazione, lo stress accumulato durante la giornata o la propensione a sottovalutare o sovrastimare lo sforzo. L'analisi ha evidenziato una tendenza alla sovrastima della fatica nel questionario CR-10, soprattutto nelle sedute meno intense, suggerendo la necessità di considerare anche altri parametri nella valutazione del carico interno. Il numero limitato di soggetti e procedure adottate limita la generalizzabilità dei risultati, nonostante la significatività della correlazione riscontrata.
2. Influenza della Soggettività del Metodo CR 10
Un aspetto importante evidenziato dall'analisi riguarda la soggettività del metodo CR-10. La percezione della fatica da parte dell'atleta può essere influenzata da diversi fattori esterni all'allenamento stesso, come lo stress giornaliero, la motivazione individuale o l'interesse verso l'allenamento. Questo aspetto potrebbe spiegare le discrepanze riscontrate tra la fatica percepita (CR-10) e il carico oggettivo (TRIMP). In particolare, la ricerca ha osservato una tendenza di alcuni atleti a fornire lo stesso valore CR-10 in ogni seduta, indipendentemente dal carico di allenamento. Questa incoerenza è probabilmente dovuta a una sovra o sottovalutazione sistematica della propria fatica. La scala di Borg, pur essendo soggettiva, è comunque uno strumento utile, a patto che venga somministrata nel modo corretto e con la consapevolezza dei suoi limiti. È importante che l’atleta si concentri sul valore numerico e non sulla semplice sensazione di fatica.
3. Analisi dei Valori TRIMP e del Carico di Allenamento
L'analisi dei valori TRIMP (non riportati nel dettaglio per ragioni di spazio) ha mostrato valori compresi tra 5.43 e 88.90, indicando un livello di stanchezza medio-basso. Questi risultati confermano le valutazioni ottenute con il questionario CR-10. L'analisi del carico di allenamento, dell'indice di monotonia e della fatica acuta ha evidenziato una maggiore intensità nella quarta seduta, con un indice di monotonia più alto e una fatica acuta significativamente superiore rispetto alle prime tre sedute. Questo dato è coerente con la maggiore intensità degli esercizi proposti in quella seduta, come lavori di navette e partitelle in inferiorità numerica, che richiedono un maggiore impegno cardiocircolatorio e una maggiore produzione di lattato. L’analisi evidenzia quindi che i diversi tipi di esercizi proposti nelle diverse sedute influenzano diversamente la risposta fisiologica degli atleti, sia in termini di frequenza cardiaca che di percezione soggettiva dello sforzo.
V.Studi Futuri e Miglioramenti Metodologici
Studi futuri dovrebbero focalizzarsi su un campione più ampio di atleti per aumentare la validità scientifica dei risultati. È necessario approfondire l'influenza di fattori individuali e contestuali sulla percezione dello sforzo misurata con la scala CR-10. Un monitoraggio più accurato della frequenza cardiaca durante l'allenamento potrebbe migliorare la precisione del calcolo del TRIMP. L'obiettivo è perfezionare i metodi di valutazione del carico di allenamento e della fatica nel calcio per ottimizzare la preparazione atletica e prevenire gli infortuni.
1. Limiti dello Studio e Suggerimenti per Ricerche Future
La sezione dedicata agli studi futuri riconosce i limiti del presente lavoro, principalmente legati al numero ridotto di soggetti analizzati (10 giocatori della Baia Alassio). Questo numero limitato di dati, pur avendo permesso di evidenziare una correlazione significativa, non garantisce una generalizzazione dei risultati a una popolazione più ampia di calciatori. Per aumentare la validità scientifica dello studio, si suggerisce di ripetere la ricerca con un campione più numeroso e diversificato, includendo giocatori di diverse età, ruoli e livelli di esperienza. Inoltre, l’analisi evidenzia la soggettività del metodo CR-10, influenzata da fattori esterni all'allenamento. Studi futuri potrebbero esplorare metodi più oggettivi per la valutazione del carico interno, come un monitoraggio continuo della frequenza cardiaca tramite cardiofrequenzimetri, o l'integrazione di altri parametri fisiologici, per ottenere una comprensione più completa dello sforzo fisico e della fatica. L'obiettivo è migliorare la precisione e la robustezza delle metodologie di valutazione del carico di allenamento e della fatica nel calcio.
2. Miglioramenti Metodologici per Aumentare l Affidabilità dei Risultati
Per migliorare la qualità e l'evidenza scientifica del lavoro, il documento propone diversi miglioramenti metodologici. L'utilizzo di cardiofrequenzimetri, invece del conteggio manuale delle pulsazioni, permetterebbe una misurazione più precisa e continua della frequenza cardiaca durante l'allenamento, ottenendo dati più accurati per il calcolo del TRIMP. L’analisi suggerisce di investigare ulteriormente l'influenza di fattori individuali e contestuali sulla percezione dello sforzo misurata con la scala CR-10. Questo potrebbe includere l'analisi di parametri come la motivazione, il livello di fitness individuale, l'esperienza di gioco e altri fattori psicologici che possono influenzare la percezione soggettiva della fatica. Un monitoraggio più accurato della frequenza cardiaca, integrato con altre misure fisiologiche, potrebbe fornire un quadro più completo del carico interno e della fatica durante le sedute di allenamento, permettendo una più efficace personalizzazione dei programmi di allenamento.
3. Applicazione Pratica dei Risultati per l Ottimizzazione dell Allenamento
Infine, lo studio suggerisce come i dati sulla frequenza cardiaca, raccolti sia durante gli allenamenti che durante le partite, possano essere utilizzati dal preparatore atletico per ottimizzare i programmi di allenamento e preparare adeguatamente i calciatori alla fatica della competizione. Frequenze cardiache elevate e prolungate durante gli allenamenti o le partite potrebbero indicare uno scarso livello di fitness, richiedendo un miglioramento del programma di allenamento per ridurre la fatica interna. Al contrario, frequenze cardiache troppo basse potrebbero suggerire la necessità di aumentare l'intensità degli allenamenti per un adeguato adattamento all’impegno delle partite. La comprensione del carico interno e della fatica, attraverso metodologie più accurate e complete, permette al preparatore atletico di intervenire in modo efficace per migliorare le prestazioni e ridurre il rischio di infortuni.
