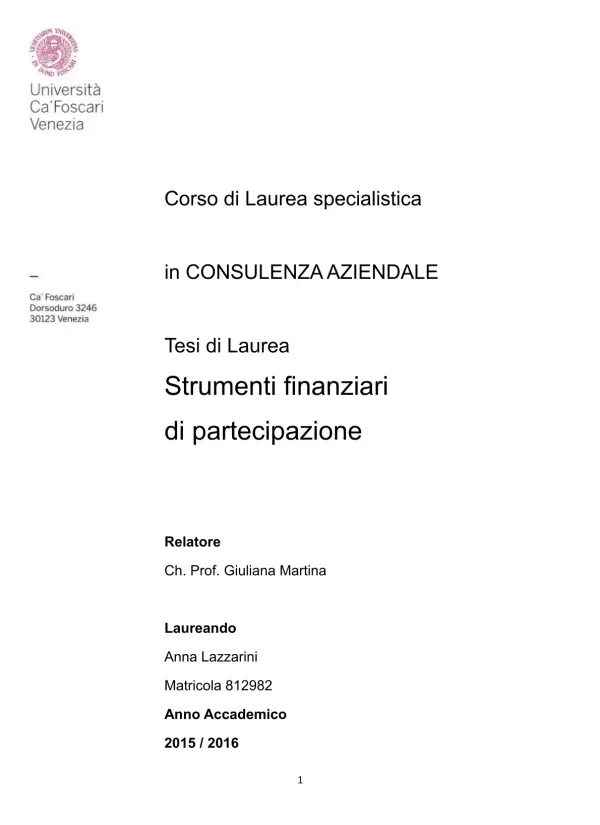
Strumenti Finanziari Partecipazione
Informazioni sul documento
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 460.56 KB |
Riassunto
I.Definizione e Natura degli Strumenti Finanziari Partecipativi
Il documento analizza gli strumenti finanziari partecipativi (art. 2346 c.c.), una forma innovativa di finanziamento con caratteristiche ibride tra azioni e obbligazioni. La normativa è scarna, lasciando ampia autonomia privata nella definizione dei diritti patrimoniali e diritti amministrativi concessi ai sottoscrittori. Questi strumenti sono concepiti per diversificare gli investimenti e offrire alle piccole e medie imprese (PMI) un accesso alternativo al credito rispetto ai canali classici (soci, banche). Una distinzione chiave riguarda la partecipazione al rischio d'impresa: a differenza delle obbligazioni, la remunerazione degli strumenti partecipativi è aleatoria e subordinata all'andamento economico della società. Il capitale di rischio generato da questi strumenti non coincide con il capitale sociale.
1. Introduzione agli Strumenti Finanziari Partecipativi
Il documento introduce la teoria degli strumenti finanziari partecipativi, presentandoli come una forma innovativa di finanziamento per le società per azioni, ibridi tra azioni e obbligazioni. L'obiettivo del legislatore era quello di rendere la struttura finanziaria delle società più efficiente e attrattiva di capitali. Tuttavia, la mancanza di una disciplina specifica, legata ad una forte enfasi sull'autonomia privata, genera incertezze giuridiche, finanziarie e contabili. Si sottolinea la quasi totale assenza di riferimenti e definizioni normative chiare, lasciando ampio spazio all'interpretazione. La carenza di una disciplina applicabile, unita alla peculiarità dell'istituto, crea complessità sia sul piano teorico che pratico. Si evidenzia come la riforma del diritto societario, con i decreti legislativi del 2004 (n. 37 e n. 310), mirasse a superare la rigidità precedente e l'eccessivo indebitamento bancario delle società, favorendo l'utilizzo di capitali di terzi per migliorare la competitività a livello globale. La Legge Delega n. 366 del 2001, con l'obiettivo di favorire la crescita e la competitività delle imprese, rappresenta il contesto normativo di questa innovazione.
2. Confronto con altre Forme di Partecipazione e Finanziamento
Il testo prosegue confrontando gli strumenti finanziari partecipativi con altre forme di partecipazione e finanziamento. Si evidenzia come, secondo vari studiosi, questi strumenti rappresentino una diversificazione dell'investimento e una fonte di finanziamento aggiuntiva o alternativa ai canali classici (soci, banche, leasing). Si analizza la differenza tra la definizione di strumento finanziario partecipativo introdotto dall'art. 2346 c.c. e quella presente nel TUF (Testo Unico dell'intermediazione finanziaria), sottolineando che il primo è focalizzato sulle PMI, mentre il secondo regolamenta il mercato finanziario e la libera circolazione degli strumenti. Viene introdotta la necessità di definire il concetto di partecipazione sociale, analizzando le diverse sfumature del termine nel codice civile (partecipazione agli utili, alla gestione, all'assemblea, al singolo affare). Si distinguono due accezioni principali: il diritto al risultato economico e la distribuzione di dividendi (con l'accettazione del rischio imprenditoriale), e il diritto/dovere di partecipazione alle decisioni inerenti la vita sociale. La difficoltà di definire la 'partecipazione' in modo univoco porta alcuni autori a utilizzare il concetto di 'partecipatività', che include diritti patrimoniali e amministrativi, ma non tutti quelli dei soci. L'importanza di tracciare un confine chiaro tra capitale di rischio e capitale di debito è sottolineata per preservare la posizione dei soci e la tutela dei creditori.
3. Analisi della Partecipazione Patrimoniale e del Rischio d Impresa
La partecipazione patrimoniale è definita come l'insieme dei diritti inerenti la restituzione e la remunerazione dell'apporto, assoggettato al rischio d'impresa. La corresponsione dipende dall'andamento economico della società, esponendo il soggetto a possibili perdite (danno emergente e lucro cessante). Il testo confronta questa situazione con le obbligazioni, che in condizioni fisiologiche garantiscono la restituzione del capitale e gli interessi pattuiti, quindi non sono soggette al rischio d'impresa. Anche le obbligazioni irredimibili, pur avendo una durata a lungo termine, non concorrono al rischio d'impresa e non sono considerate strumenti partecipativi. Si approfondisce l'interpretazione dell'art. 2411 c.c., che riguarda la subordinazione dei diritti degli obbligazionisti alla soddisfazione di altri creditori, e si discute se gli strumenti con incertezza solo sulla tempistica del rimborso possano essere considerati partecipativi. L'obiettivo del legislatore, di tutelare gli investitori in caso di incertezza sul rientro dell'investimento, è sottolineato, con l'estensione dell'ambito applicativo dell'art. 2411, terzo comma. Si evidenzia la difficoltà di stabilire una linea netta tra strumenti con rimborso incerto e strumenti partecipativi.
II.Diritti Patrimoniali e Amministrativi
I titolari di strumenti finanziari partecipativi possono ottenere diritti patrimoniali, come la partecipazione agli utili, soggetti al rischio d'impresa. Possono anche ottenere diritti amministrativi, ma l'articolo 2346 c.c. esclude esplicitamente il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti. Tuttavia, lo statuto può prevedere altri diritti amministrativi, come la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o il diritto di voto su argomenti specifici, creando un nuovo equilibrio di potere all'interno della società. L'esercizio di questi diritti può avvenire nell'assemblea generale dei soci o, per società più grandi, in assemblee speciali di categoria.
III.Confronto con altri Istituti e Aspetti Contabili
Gli strumenti finanziari partecipativi presentano similitudini con le azioni, le obbligazioni (anche quelle irredimibili), le associazioni in partecipazione, e i patrimoni destinati ad uno specifico affare. Tuttavia, costituiscono un genus autonomo. Contabilmente, l'apporto dei sottoscrittori è iscritto in una voce specifica del patrimonio netto, contribuendo al capitale di rischio ma non al capitale sociale. Il diritto alla restituzione dell'apporto è subordinato ai diritti degli altri creditori e non è garantito in alcun modo. La seconda direttiva comunitaria sulla formazione del capitale esclude l'imputazione di questo apporto al capitale sociale.
IV.Aspetti Pratici e Conclusioni
Malgrado la flessibilità offerta dall'autonomia privata, l'utilizzo degli strumenti finanziari partecipativi in Italia è stato limitato a causa della vaghezza normativa. La mancanza di un contenzioso significativo evidenzia questa scarsa applicazione. Lo statuto sociale è fondamentale per definire il contenuto e la circolazione degli strumenti, compresa la possibilità di diritto di opzione, recesso, e la definizione del peso del voto in assemblea, se previsto. La possibilità di strutturare diritti amministrativi (es. voto su argomenti specifici, nomina di amministratori indipendenti) e diritti patrimoniali (es. partecipazione agli utili) in modo flessibile rende questi strumenti potenzialmente adatti a diverse esigenze societarie, ma la scarsa chiarezza normativa ne limita l'adozione.
