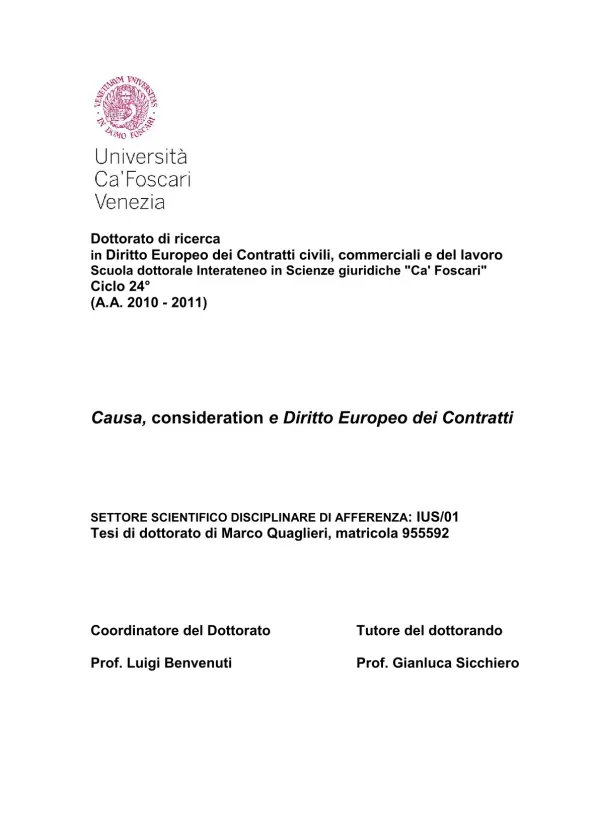
Causa Contratto: Diritto Italiano ed Europeo
Informazioni sul documento
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 1.91 MB |
Riassunto
I.L Evoluzione Storica del Negozio Giuridico e della Causa del Contratto nel Diritto Italiano
Questo documento analizza l'evoluzione storica del concetto di negozio giuridico e, in particolare, della causa del contratto nel diritto civile italiano. Si parte dall'analisi del progetto del Codice Civile del 1865, dove la causa era definita come "una causa lecita per contrattare." Si evidenzia poi l'influenza della Pandettistica e il dibattito dottrinale sulla teoria della volontà, contrastata da approcci più oggettivi che tengono conto degli interessi sociali e dell'affidamento. Autori importanti come Mirabelli, Galgano, Schiavone, Mengoni e Ferrara sono citati per le loro diverse prospettive sull'argomento. Il documento esamina come, nel periodo fascista, la concezione della causa si sia orientata verso una funzione più teleologica e pubblicistica, per poi evolvere nel dopoguerra verso una visione più oggettiva e legata alla funzione economico-sociale del contratto, abbandonando le residue istanze soggettivistiche. Vengono analizzate le posizioni di Betti e Stolfi sul rapporto tra effetto giuridico e sociale del negozio.
1. La Causa nel Progetto del Codice Civile del 1865 e l Emergere del Negozio Giuridico
Il documento inizia analizzando il progetto del Codice Civile italiano del 1865, presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia Cassinis il 19 giugno 1860. In questo progetto, l'articolo sui requisiti essenziali del contratto definiva la causa come "una causa lecita per contrattare." Si introduce poi la locuzione negotium iuridicum, apparsa per la prima volta in un'opera del giurista illuminista Nettelbladt nel 1749. Mirabelli, nella voce Negozio Giuridico dell'Enciclopedia del diritto (1978), sottolinea che la definizione di Nettelbladt non era ancora matura dal punto di vista tecnico-sistematico. L'analisi si concentra sulla possibilità di indagare retrospettivamente gli ordinamenti precedenti all'introduzione del concetto di negozio giuridico da parte della Pandettistica, un'operazione ritenuta non strettamente necessaria ma comunque affrontata da autorevoli dottrine, come quella di Schiavone (voce Negozio Giuridico (dir. rom.), Enc. dir., 1977).
2. Autonomia Privata e il Ruolo della Causa Interessi di Classe e Funzionalizzazione
Un tema centrale dello studio è la funzione dell'autonomia privata nel negozio giuridico. L'attribuzione di immediato effetto al volere dei privati, con un intervento limitato dell'ordinamento, impedisce all'ordinamento stesso di indirizzare l'agire privato verso i propri fini. Il documento, citando Mirabelli (op. cit., p. 4) e Galgano (op. cit., p. 937), esplora come la disciplina del negozio giuridico, anche se elaborata dalla dottrina, possa riflettere interessi di classe. Si analizza come, nella Francia del Giusnaturalismo, il principio del consenso come elemento sufficiente per creare un vincolo giuridico favorisse la classe mercantile a scapito dei proprietari terrieri. Si evidenzia inoltre come il dogma della volontà fosse funzionale agli interessi della classe aristocratico-proprietaria (creditrice), in quanto l'effetto vincolante del consenso è nell'interesse del creditore. Questo evidenzia una funzionalizzazione dell'autonomia privata ad interessi sociali di settore, inizialmente gestita dalla disciplina del consenso e successivamente dall'istituto della causa.
3. L Evoluzione Dottrinale in Germania e in Italia Volontarismo e Interpretazione Tecnico Giuridica
La dottrina tedesca, attraverso la giurisprudenza degli interessi e le opere di Jhering, si allontanò presto dalla teoria del dogma della volontà. In Italia, data la prevalenza di una società agricola, l'adeguamento del metodo interpretativo ai cambiamenti sociali, come avvenuto nel dopoguerra con l'avvento della sociologia giuridica, fu più lento. Questo ritardo, secondo Mengoni (Giurisprudenza e metodo, 1985), portò inizialmente a una minore critica delle teorie volontaristiche, ma permise allo stesso tempo di affinare gli strumenti interpretativi tecnico-giuridici, consentendo un'analisi più approfondita degli scopi oggettivi delle norme. Ferrara, con le sue teorie, contribuì a depotenziare il dogma della volontà, adeguandolo alle esigenze di comune affidamento. Betti, nella sua Teoria generale del negozio giuridico (1994), propose la tesi (già presente nel suo Corso di istituzioni di diritto romano, 1929) che l'effetto giuridico fosse 'sovrapposto' all'effetto sociale del negozio, sottolineando che l'autonomia privata non crea né integra norme giuridiche, ma ne applica quelle preesistenti.
II.La Causa del Contratto dopo il 1942 Oggettività e Funzione Economico Sociale
Dopo l'entrata in vigore del Codice Civile del 1942, la dottrina si è focalizzata su una concezione oggettiva della causa, circoscritta al programma contrattuale e depurata da elementi soggettivistici. Si evidenzia il dibattito sulla distinzione tra causa in astratto (del tipo contrattuale) e causa in concreto (del singolo contratto), con particolare attenzione al ruolo degli interessi delle parti. Autori come Mirabelli, Redenti, Stolfi, Cariota Ferrara, Pugliatti e Santoro Passarelli hanno contribuito a questo dibattito, offrendo diverse interpretazioni del requisito causale. Il documento analizza come l'approccio tecnico-dogmatico sia stato via via affiancato da prospettive più sociologiche, influenzate dai cambiamenti sociali post-bellici e dall'industrializzazione. Viene sottolineata l'importanza del bilanciamento tra interessi privati e interesse pubblico nella valutazione della causa.
1. La Concezione Oggettiva della Causa dopo il 1942
Dopo il Codice Civile del 1942, la dottrina si è orientata verso una concezione oggettiva della causa del contratto, definendola come il programma contrattuale, escludendo le componenti soggettive come 'scopo' e 'intento'. Questo spostamento di attenzione mirava a depurare l'istituto dalle residue istanze soggettivistiche, focalizzandosi sull'aspetto oggettivo dell'accordo. L'obiettivo era circoscrivere la causa all'ambito strettamente oggettivo del programma contrattuale, depurandola da ogni accezione personale e unilaterale. L'adozione di una teoria precettiva, o meglio, il suo accoglimento da parte del legislatore del 1942, aveva aperto le porte a questa dicotomia: la causa non era più solo un requisito del consenso, ma un requisito fatto proprio dall'ordinamento. Autori come Mirabelli, Redenti, e Stolfi hanno contribuito a definire questa nuova prospettiva, cercando di distinguere tra causa oggettiva e soggettiva, e tra causa e motivi. Cariota Ferrara, ad esempio, rifiuta ogni implicazione soggettiva della causa, ricomprendendola nei motivi. Questa interpretazione oggettiva si basa su tre argomentazioni principali: l'irrilevanza dei motivi, l'eliminazione del concetto di 'causa falsa' e l'eliminazione della presunzione di causalità.
2. Causa in Astratto e Causa in Concreto La Dicotomia e il Ruolo degli Interessi delle Parti
L'affermazione della teoria precettiva portò a una dicotomia tra la causa di un singolo negozio e la causa del tipo di negozio. La generalità e l'astrattezza della causa, unite alla sua funzione di promozione dell'indirizzo di politica economica, portavano a riferire la causa al tipo giuridico-sociale negoziale. Questo ha generato un acceso dibattito dottrinale sulla distinzione tra una causa 'in astratto', espressa dal tipo contrattuale, e una causa 'in concreto', emergente dal singolo negozio o dalle dichiarazioni delle parti. Pugliatti ha contribuito a chiarire questa distinzione, sottolineando la necessità di verificare che il profilo statico del tipo sia rispettato dall'agire pratico delle parti. Autori come Santoro Passarelli hanno evidenziato la distinzione tra le due accezioni di 'causa del contratto', riferendosi sia al singolo contratto che al tipo sociale o ordinamentale. Barcellona attribuisce la sovrapposizione erronea tra causa e tipo al bisogno di riconvertire il negozio causale alle dinamiche del nudo patto. La comprensione di questa dicotomia è fondamentale per analizzare casi in cui l'interprete avverte un deficit funzionale, spesso manifestato da un solo lato del regolamento pattizio o in assenza di prestazioni corrispettive ma con interessi contrapposti.
3. L Influenza del Contesto Sociale e l Abbandono del Puro Concettualismo Dogmatico
La tensione teleologica nella rappresentazione dell'ordinamento giuridico durante il periodo fascista non trovò terreno fertile negli studi successivi alla caduta del regime. La dottrina post-fascista, pur mantenendo il concetto astratto di negozio giuridico, si allontanò progressivamente dal puro concettualismo dogmatico. Questo cambiamento di prospettiva fu influenzato dalle trasformazioni sociali post-belliche, in particolare dall'industrializzazione massiva, che portò a una 'continua disintegrazione e reintegrazione delle strutture sociali'. Alcuni autori abbandonarono l'approccio tecnico-dogmatico, modulato sulle tecniche della giurisprudenza dei concetti, per abbracciare prospettive più sociologiche. La valutazione economico-sociale degli interessi concreti, secondo Pugliatti, ha lasciato il posto a una configurazione giuridica di essi. Questo non implica che tutti i negozi abbiano una causa, ma che la causa astratta del tipo debba essere rispettata nella sua applicazione pratica. Betti, pur riconoscendo l'autonomia privata nel perseguimento di scopi individuali, sottolinea il ruolo dell'ordinamento giuridico nel valutare tali scopi secondo la loro rilevanza sociale.
III.Giurisprudenza e Interpretazione della Causa Casi Significativi
La sezione analizza sentenze della Corte di Cassazione che hanno interpretato la causa del contratto, evidenziando l'applicazione dei principi elaborati dalla dottrina. Si esaminano casi riguardanti la validità di contratti in presenza di sproporzioni tra le prestazioni, il collegamento negoziale tra diversi contratti (con particolare attenzione all'unità o pluralità degli interessi perseguiti), e l'ipotesi di presupposizioni contrattuali. L'analisi giurisprudenziale mostra come i giudici bilanciano l'autonomia privata con il controllo della meritevolezza di tutela degli interessi perseguiti, soprattutto in presenza di squilibri contrattuali tra parti con diverso potere contrattuale. Vengono citate sentenze significative del periodo 2005-2007.
1. Analisi di Sentenza Validità Contrattuale e Controllo Giudiziale
La sezione analizza sentenze della Corte di Cassazione che si sono occupate della validità di contratti, focalizzandosi sull'interpretazione della causa. Un esempio riguarda la validità di un acquisto immobiliare, dove la Corte si concentra sulla validità di uno degli acquisti nella 'catena' che ha portato l'immobile al patrimonio di una delle parti. Nonostante la compravendita (in questo caso preliminare) sembrasse regolare, il pagamento del prezzo tramite assegno scoperto e conto corrente estinto ha sollevato questioni di validità. Un'altra sentenza analizza i contratti di acquisto e rivendita di azioni e la loro influenza sul regime fiscale. La Corte ha ravvisato un'invalidità radicale, individuabile nella prospettazione stessa delle parti, rendendo superflua l'indagine su simulazione o interposizione. Si evidenzia l'esclusione di frode alla legge e di non meritevolezza del contratto ai sensi dell'art. 1322 c.c., trattandosi di contratti tipici. Queste sentenze mostrano l'approccio della Corte di Cassazione nel valutare la validità dei contratti, andando oltre l'aspetto formale per considerare la sostanza dell'accordo e la meritevolezza di tutela degli interessi.
2. Il Collegamento Negoziale Unità di Interessi e Intento Pratico
Un'altra parte significativa dell'analisi giurisprudenziale riguarda il concetto di collegamento negoziale. La Corte di Cassazione (Giur. It. 2005, II, p. 1825 ss.) chiarisce che il criterio distintivo tra contratto unico e contratto collegato risiede nell'unicità o pluralità degli interessi perseguiti, e non in elementi formali come l'unità o pluralità dei documenti contrattuali. Per configurare un collegamento negoziale in senso tecnico, sono necessari sia un requisito oggettivo (nesso teleologico tra i negozi) sia un requisito soggettivo (comune intento pratico delle parti). Quest'ultimo non si identifica con la mera coincidenza formale delle parti, ma con il comune intento di realizzare non solo l'effetto tipico dei singoli negozi, ma anche il loro coordinamento per un fine ulteriore. Un esempio concreto riguarda la risoluzione per inadempimento di una compravendita dove il pagamento del prezzo avveniva tramite un contratto di mutuo. In questo caso, il collegamento negoziale tra i due contratti comporta che, in caso di risoluzione della compravendita, il mutuante possa richiedere la restituzione della somma mutuata direttamente al venditore.
3. Equilibrio Contrattuale Lesione e Tutela del Contraente Debole
Il documento affronta il tema dell'equilibrio contrattuale e della tutela del contraente debole, analizzando la giurisprudenza in materia di azioni di rescissione per lesione. Luzzato, in 'La compravendita' (1961), inserisce l'azione di rescissione nel capitolo dedicato alla causa del contratto di compravendita, evidenziando il delicato equilibrio tra autonomia contrattuale e controllo giudiziale dell'equivalenza delle prestazioni. Si sottolinea che il controllo giudiziale sulla congruità dello scambio (bene-prezzo) è una scelta ideologica, di stampo liberale, che sindaca le scelte dell'autonomia privata per verificare il rispetto della sostanza della legge, soprattutto in presenza di squilibri contrattuali tra parti con diverso potere contrattuale (imprese di grandi dimensioni vs. piccole imprese e consumatori). L'analisi approfondisce le implicazioni di questa prospettiva, evidenziando la necessità di un controllo giudiziale sostanziale ed effettivo per contrastare gli abusi contrattuali. Si fa riferimento anche alla situazione precedente al Codice del 1865, dove i margini per l'esercizio dell'azione di rescissione erano più ristretti (Gorla, 'La compravendita', 1937).
IV.Il Contract nel Diritto Inglese Un Confronto con il Diritto Italiano
Il documento introduce un confronto tra il sistema italiano e quello inglese, focalizzandosi sul concetto di consideration nel common law e confrontandolo con la causa nel diritto civile. Si analizza l’evoluzione storica del contract inglese, partendo dalle forms of action e arrivando alla consideration come elemento essenziale del contratto. Vengono citati autori come Simpson, Beatson, Pluckett e Atiyah, e casi giudiziari significativi per illustrare la diversa evoluzione dei due sistemi. L’analisi evidenzia le differenze tra un approccio più formale e procedurale (common law) e un approccio più sistematico e dogmatico (civil law) nell'elaborazione della teoria contrattuale. Si analizza l’evoluzione del concetto di scambio e l’impatto della giurisprudenza, incluso il caso Carlill v Carbolic Smoke Ball Co.
1. Evoluzione Storica del Contract Inglese Dalle Forms of Action alla Consideration
Questa sezione del documento confronta il sistema contrattuale italiano con quello inglese, analizzando l'evoluzione del contract inglese. Si parte dalle forms of action, azioni nominate con formule specifiche in latino, che hanno profondamente influenzato l'elaborazione di nozioni e regole di diritto sostanziale. Mocc ia (voce Contract, Enc. giur. Treccani) evidenzia la stretta relazione tra la tutela perseguibile con un determinato tipo di writ, la procedura ad esso connessa e la situazione giuridica soggettiva che poteva essere fatta valere. Cavanna (op. cit., p. 481) sottolinea l'autonomia del diritto inglese, derivante dal ceppo anglo-normanno, e la sua influenza limitata dallo ius commune. La common law, come il diritto romano classico, si basa sulla decisione di casi concreti più che sul dettato legislativo, giungendo creativamente alla norma (non scritta) attraverso una prospettiva processuale. Si discute poi dell'evoluzione verso la consideration, notando che inizialmente l'obbligazione corrispettiva nella compravendita poteva essere azionata solo dopo l'esecuzione della prestazione (quid pro quo), e come gradualmente l'enfasi si sia spostata dal risultato finale degli atti delle parti all'inizio della vicenda contrattuale, alle promesse piuttosto che agli illeciti.
2. Consideration e Accordo Analisi Comparativa con la Causa Italiana
L'analisi approfondisce il concetto di consideration nel diritto inglese, confrontandolo implicitamente con la causa nel diritto italiano. Si evidenzia come, con l'affermarsi dell'action of assumpsit, questo tipo di rimedio dominasse la materia delle obbligazioni contrattuali. Mocc ia (op. cit., p. 19) sottolinea che la nozione di contract come agreement non si adattava alla categoria degli express contracts, dove né il debt né il covenant rispecchiavano il principio dell'accordo come fonte di obbligazione. Pluckett (op. cit., p. 643) spiega il rapporto tra accordo e consideration, evidenziando il passaggio da un'enfasi sul risultato finale degli atti delle parti a una focalizzazione sull'inizio della vicenda, sulle promesse piuttosto che sugli illeciti. Il documento cita il caso Carlill v Carbolic Smoke Ball Co., dove Lord Justice AL Smith interpreta l'annuncio pubblicitario come una promessa condizionata all'uso del prodotto, evidenziando la presenza di una consideration nell'acquisto e nell'uso del prodotto. L'analisi del caso nella House of Lords da parte di Lord Cairns evidenzia il principio di equità nell'applicazione dei diritti contrattuali.
3. Differenze Sistematiche tra Common Law e Civil Law Approcci alla Teoria Contrattuale
La sezione conclude evidenziando le differenze sistematiche tra il sistema di common law inglese e quello di civil law italiano nell'ambito della teoria contrattuale. Si mette a confronto l'approccio più formale e procedurale della common law, basato sulla giurisprudenza e sulla decisione dei casi concreti, con l'approccio più sistematico e dogmatico del civil law, fondato su codici e dottrina. L'analisi si concentra sulle diverse evoluzioni storiche e sulle diverse concezioni del contratto e dei suoi elementi essenziali (consideration vs. causa). Il documento cita diverse sentenze inglesi, mostrando come la consideration sia un elemento essenziale per la validità del contratto e come la sua evoluzione sia stata influenzata da diverse azioni giudiziarie e principi di equità. La sezione sottolinea come il diritto inglese, a differenza di quello italiano, non abbia mai abbracciato completamente una prospettiva sistematica e dogmatica come quella del corpus giustinianeo.
V.L Armonizzazione del Diritto Contrattuale in Europa Tendenze e Sfide
L'ultima sezione affronta le tendenze verso l'armonizzazione del diritto contrattuale a livello europeo, evidenziando l'importanza dei Principi di Diritto Europeo dei Contratti e del dibattito sull'opportunità e le modalità di una codificazione europea del contratto. Si citano autori e opere che contribuiscono a questo dibattito, come Marrella, Castronovo, Alpa, Cafaggi, Grasso e Ferri. Si accenna al ruolo delle organizzazioni internazionali e delle iniziative private nel promuovere la uniformità delle regole contrattuali. Si accenna, infine, alla possibile influenza del diritto comunitario sui profili funzionalistici del patto, seppur in modo non approfondito.
1. La Necessità di un Diritto Contrattuale Uniforme a Livello Internazionale
La sezione finale del documento affronta la tematica dell'armonizzazione del diritto contrattuale in ambito europeo e internazionale, sottolineando la crescente esigenza, da parte degli operatori economici internazionali, di un corpus di regole e principi uniformi. Si evidenzia che il diritto dei contratti rappresenta un terreno fertile per l'armonizzazione, poiché le peculiarità ordinamentali attengono a scelte tradizionali, in larga parte scevre da declinazioni assiologiche. Le esperienze di normazione comune si sono sviluppate sia tramite organizzazioni internazionali che attraverso istituzioni private. Il documento specifica che non tutti i prodotti di norme uniformi hanno dato origine a disposizioni vincolanti; le esperienze più interessanti dal punto di vista dogmatico sono costituite da set di disposizioni applicabili in via opzionale e volontaria. Vengono citati diversi autori e opere che si occupano di questo tema, tra cui Marrella, Castronovo, Alpa, Cafaggi, Grasso e Ferri, e si fa riferimento al Libro Verde della Commissione sulle opzioni possibili per un diritto europeo dei contratti.
2. L Influenza Limitata del Diritto Europeo Vigente e il Ruolo dei Principi di Diritto Europeo dei Contratti
Il documento analizza l'influenza del diritto europeo vigente sui profili funzionalistici del patto, evidenziando che la normativa comunitaria tende a evitare di disciplinare istituti generali del diritto dei contratti, anche quando opera con atti di portata generale (come la normativa consumieristica). Tuttavia, alcune disposizioni di portata generale potrebbero influenzare l'agire privato. L'autore accenna alla possibile influenza della sanzione pattizia sulla Costituzione Europea, ma questa questione esula dal presente lavoro. Per un approfondimento, si rimanda ad opere di Vettori, Castronovo e Ferri sul tema del contratto e della costituzione in Europa. Il documento fa riferimento ai Principi di diritto europeo dei contratti (e alle relative discussioni dottrinali e giurisprudenziali), evidenziando il ruolo di tali principi nell'armonizzazione del diritto contrattuale europeo, ma non approfondisce la questione nel dettaglio. Si accenna anche alla posizione di Gandolfi che esclude la causa dal novero dei requisiti del contratto, come riportato da Sicchiero.
