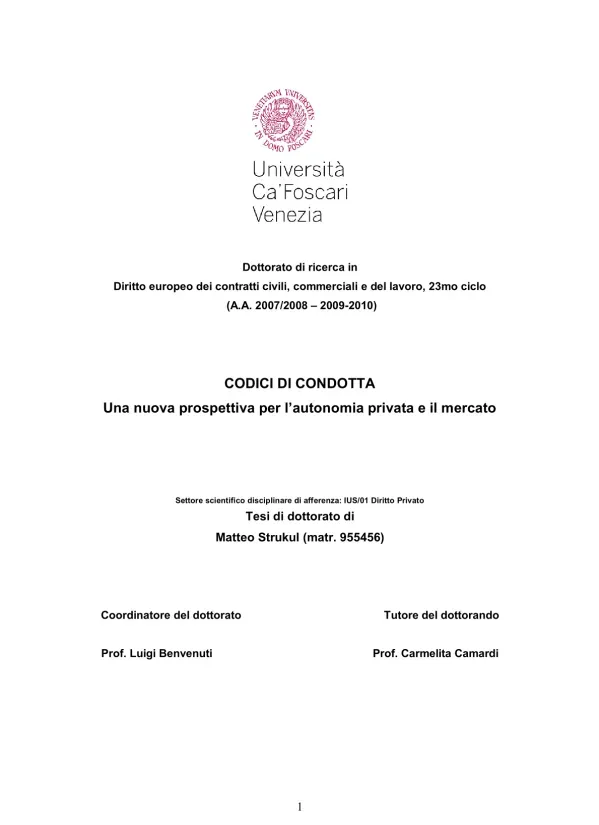
Codici di Condotta: Autonomia e Mercato
Informazioni sul documento
| Autore | Matteo Strukul |
| Scuola | University where the doctorate program was held (information not provided in the text) |
| Specialità | Diritto europeo dei contratti civili, commerciali e del lavoro |
| Anno di pubblicazione | 2007/2008 – 2009/2010 |
| Tipo di documento | Tesi di dottorato |
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 1.73 MB |
Riassunto
I.L efficacia del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria Natura Giuridica e Effetti
Questo studio analizza la natura giuridica del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria e la sua efficacia. Si discute se esso abbia un'efficacia erga omnes o solo inter partes, esplorando la possibilità di definirlo un contratto a favore di terzi o un uso normativo. L'analisi si concentra sulla clausola di adesione, sottolineando l'incertezza dottrinale sulla sua natura e i suoi effetti nei confronti di soggetti aderenti e non aderenti, inclusi i consumatori. Si esamina il ruolo del Giurì della Pubblicità e la sua interpretazione della clausola di adesione come norma contrattuale consuetudinaria ai sensi dell'art. 1374 c.c. L'indagine approfondisce l'applicazione del codice a casi specifici, come la decisione del Giurì del 2 dicembre 1987 (n. 124/87) analizzata da A. Calisse. Viene inoltre considerata la crescente autorevolezza del Codice e la sua interazione con la legislazione nazionale, in particolare con il Codice del consumo e le pratiche commerciali sleali.
II.Il Codice di Autodisciplina e la Normativa Comunitaria
Il documento esamina l'influenza della normativa comunitaria sul Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, in particolare riguardo al recepimento delle direttive in materia di pratiche commerciali sleali. Si evidenzia l'allineamento del Codice alle nuove disposizioni comunitarie, con particolare attenzione alla definizione di comunicazione commerciale, più ampia rispetto al termine pubblicità. L'analisi approfondisce il ruolo del Garante per la concorrenza e il mercato e l'introduzione del concetto di "consumatore medio". Si sottolinea l'urgenza di aggiornare il Codice per mantenerne l'efficacia alla luce della nuova disciplina comunitaria che sanziona comportamenti che alterano la capacità di giudizio del consumatore (sanzioni fino a 500.000 euro).
1. L Influenza della Normativa Comunitaria sul Codice di Autodisciplina
Questa sezione analizza l'impatto della legislazione comunitaria sul Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, focalizzandosi sull'introduzione di nuove norme in materia di pratiche commerciali sleali. Il documento evidenzia come il recepimento di queste direttive europee abbia reso necessario un aggiornamento del Codice, per evitare che diventasse inefficace di fronte al nuovo panorama normativo. Si sottolinea l'importanza dell'allineamento del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria alla nuova disciplina comunitaria, per garantire la sua efficacia e la tutela dei consumatori. La legge italiana, infatti, sanziona i comportamenti pubblicitari che alterano la capacità di giudizio del consumatore, con sanzioni che possono arrivare fino a 500.000 euro. Di fronte a questa evoluzione legislativa, l'Istituto per l'autodisciplina pubblicitaria ha dovuto adeguarsi, modificando il proprio codice per rimanere in linea con le nuove normative e per evitare di contrastare con le leggi dello Stato. Questo adeguamento ha portato a cambiamenti significativi, tra cui una ridefinizione del concetto stesso di pubblicità, che ora comprende una nozione più ampia di 'comunicazione commerciale'.
2. La Definizione di Comunicazione Commerciale e l Ampliamento dell Ambito di Applicazione
Un aspetto fondamentale dell'allineamento del Codice alla normativa comunitaria riguarda la definizione di "comunicazione commerciale". Il documento evidenzia la sostituzione del termine "pubblicità" con quello più ampio di "comunicazione commerciale", che include non solo l'advertising tradizionale, ma anche altre forme di comunicazione utilizzate dalle imprese per promuovere i propri prodotti e servizi. Questa modifica non è semplicemente una questione di nomenclatura, ma introduce una nozione più estesa, che comprende, ad esempio, promozioni, direct marketing e i nuovi media. L'allargamento dell'ambito di applicazione ha costretto l'autodisciplina ad affrontare nuove sfide, dovendo confrontarsi con operatori e strumenti di comunicazione meno facilmente misurabili e codificabili rispetto ai media tradizionali. Nonostante questa espansione, l'obiettivo principale rimane la tutela del consumatore e la promozione di una concorrenza leale. La nuova definizione di comunicazione commerciale, quindi, riflette l'adattamento del Codice alle trasformazioni del mercato e alle nuove forme di comunicazione, mantenendo comunque al centro la protezione dei consumatori e il rispetto delle regole della concorrenza.
3. Il Ruolo del Garante per la Concorrenza e del Mercato e l Introduzione del Consumatore Medio
La sezione analizza il ruolo del Garante per la concorrenza e il mercato nel contesto delle nuove normative comunitarie e la loro influenza sul Codice di Autodisciplina Pubblicitaria. L'intervento dello Stato, attraverso il Garante, introduce un sistema di sanzioni amministrative per le pratiche commerciali sleali, sottolineando la crescente importanza della tutela del consumatore. La capacità dello Stato di imporre sanzioni fino a 500.000 euro, evidenzia la gravità di tali violazioni e l'impegno a garantire una concorrenza leale e la protezione dei consumatori. Inoltre, il documento cita l'introduzione del concetto di "consumatore medio" all'art. 2 del Codice, un elemento chiave per valutare la correttezza di una comunicazione commerciale. Questo concetto, mutuato dalla legislazione comunitaria, offre un parametro di riferimento per determinare se una comunicazione commerciale possa indurre in errore un consumatore medio, influenzando la sua capacità di giudizio e le sue decisioni di acquisto. La presenza di questo concetto nel Codice di Autodisciplina Pubblicitaria indica una maggiore armonizzazione con le normative comunitarie e una maggiore attenzione alla tutela dei diritti dei consumatori.
III.Codice di Autodisciplina delle Società Quotate Best Practices e Self Regulation
Questo sezione si concentra sul Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, analizzandone la genesi (legata al recepimento delle Direttive Eurosim e al Testo Unico della Finanza - TUF nel 1998) e il ruolo nel garantire la corporate governance. L'applicazione del principio “comply or explain” viene discussa, evidenziando la flessibilità del sistema e il suo continuo aggiornamento attraverso emendamenti e revisioni (es. Italia e Olanda). Si analizza l'enforcement ex ante e ex post, il ruolo dell'assemblea dei soci, e l'importanza della trasparenza e della protezione degli stakeholders. Il documento esamina inoltre esempi specifici di best practices, come la regolamentazione della remunerazione del Management Board e la prevenzione dei conflitti di interesse, con riferimento a specifici articoli del codice (es. art. 13 CAP).
1. Genesi e Obiettivi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate
Questa sezione del documento introduce il Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, evidenziando la sua origine nelle riforme del mercato finanziario italiano del 1998, con il recepimento delle Direttive Eurosim e l'emanazione del Testo Unico della Finanza (TUF, d.lgs. 58/1998). L'obiettivo principale del Codice è quello di fornire una regolamentazione organica e omogenea per il mercato finanziario italiano, in rapida espansione a seguito delle privatizzazioni delle società statali. Il documento sottolinea l'importanza di un adeguato quadro legislativo per garantire la competitività con altri mercati internazionali più evoluti. La scelta di mantenere una struttura privata del mercato, pur garantendo un'efficace attività di controllo, mira a garantire la flessibilità necessaria per attrarre investitori. Questo duplice obiettivo, di flessibilità e controllo, è fondamentale per il successo del mercato, bilanciando i costi sostenuti da società e investitori con la presenza di efficaci strumenti di controllo dei comportamenti degli emittenti. Il Codice di Autodisciplina, quindi, diventa uno strumento chiave per valutare la conformità delle società ai principi di trasparenza e buon governo societario.
2. Il Principio Comply or Explain e la Flessibilità del Sistema
Il cuore di questo paragrafo è l'analisi del principio 'comply or explain' come elemento cardine del sistema di regolamentazione del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate. Questo principio consente di definire le regole del gioco per gli operatori del mercato azionario, richiedendo la conformità a determinate best practices, salvo giustificazione di eventuali deviazioni. Questa flessibilità, necessaria per adeguarsi all'evoluzione del mercato, è bilanciata dalla possibilità di enforcement in caso di mancata giustificazione delle deviazioni. Il documento cita l'esempio dei codici di Italia e Olanda, sottolineando come siano stati oggetto di numerosi emendamenti e revisioni negli ultimi dieci anni, a dimostrazione della dinamicità del sistema. L'applicazione del principio 'comply or explain' permette quindi una maggiore duttilità nel processo di revisione e ammodernamento del Codice, consentendo di mantenerlo aggiornato e attuale. L'inosservanza delle best practices, pur non costituendo una violazione di una regola vincolante, può portare a una revisione del Codice stesso, evidenziando il meccanismo di adattamento e perfezionamento continuo.
3. Best Practices e Enforcement Ex Ante e Ex Post
Questa parte approfondisce il tema delle best practices contenute nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, analizzando le modalità di enforcement sia ex ante che ex post. L'enforcement ex ante si riferisce al potere dell'assemblea di valutare le giustificazioni fornite dalle società in caso di mancata applicazione delle best practices, mentre l'enforcement ex post si riferisce alle conseguenze derivanti dalla mancata conformità. Si fa riferimento all’importanza della trasparenza, evidenziata, ad esempio, dalla necessità di fornire le ragioni in caso di concentrazione delle cariche di presidente e amministratore delegato. L'analisi si estende poi alle norme riguardanti gli amministratori indipendenti, sottolineando il principio di prevalenza della sostanza sulla forma nella valutazione dell'indipendenza, in conformità alla Raccomandazione CE del 15 febbraio 2006. Il ruolo del Collegio Sindacale nel controllo della corretta applicazione dei criteri di indipendenza è altrettanto importante. Infine, viene menzionata l'introduzione di riunioni dei soli consiglieri indipendenti, almeno una volta all'anno, per rafforzare la loro capacità di incidere sulla vita della società. L’analisi mette in luce il complesso sistema di controlli e meccanismi di adattamento del codice alle esigenze del mercato.
IV.Codice di Autodisciplina Confronto con altri Sistemi e Conclusioni
La parte conclusiva del documento confronta il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria italiano con sistemi di altri Paesi (Olanda, Stati Uniti, Spagna), evidenziando differenze e similitudini nell'approccio alla self-regulation. Si analizzano diversi modelli di codici di condotta, distinguendoli tra accordi, norme emanate da organismi governativi e codici con una forte componente di autodisciplina. Si sottolinea la complessità della Lex mercatoria e l'evoluzione dell'autodisciplina pubblicitaria verso un sistema sempre più strutturato e transnazionale (citando esempi come l'EASA e il Cross-border Complaints System). Il documento conclude ribadendo la distinzione tra codici di condotta e codici di autodisciplina, quest'ultimi caratterizzati da un apparato sanzionatorio e procedurale più robusto. Si ribadisce l’importanza del codice come sistema alternativo alla legge ordinaria, come sancito dall'art. 27 ter del Codice del consumo. Viene anche menzionata la possibilità di azioni legali per codici di condotta contra legem (art. 139 e 2601 c.c.).
1. Confronto tra Codici di Autodisciplina di Diversi Paesi
Questa sezione introduce un'analisi comparativa dei codici di autodisciplina in diversi paesi, evidenziando le differenze di approccio alla self-regulation. L'obiettivo è quello di arricchire la comprensione del fenomeno, confrontando il modello italiano con quello di altri stati, come Olanda, Stati Uniti e Spagna. Si mette in luce come la definizione stessa di codice di condotta o di autodisciplina vari a seconda del contesto nazionale. Il documento analizza diversi modelli: codici come accordi tra operatori di settore, codici emanati da organismi governativi e sottoposti a costante supervisione, e codici basati su un sistema di autodisciplina più autonomo. L'esempio del codice di corporate governance in Italia e Olanda viene utilizzato per evidenziare le diverse strutture e modalità di funzionamento, sottolineando la difficoltà di fornire una definizione univoca di codice di condotta a livello comunitario, a causa della varietà di approcci nazionali. Il testo suggerisce che una definizione troppo generica rischia di non cogliere le sfumature e le differenze sostanziali tra i vari modelli.
2. La Natura del Codice di Corporate Governance Olandese e il Ruolo della Corte Specializzata
Il documento si sofferma sul Codice di Corporate Governance olandese, evidenziando alcune analogie con il sistema del Delaware (USA). Si sottolinea la flessibilità del diritto societario olandese e l'esistenza di una corte specializzata in materia di diritto commerciale, una caratteristica unica al mondo. Questo paragone serve per illustrare ulteriormente la varietà di approcci alla regolamentazione della corporate governance a livello internazionale. L'esistenza di una corte specializzata, sia in Olanda che nel Delaware, evidenzia l'importanza di un sistema giudiziario specializzato per la risoluzione delle controversie in materia di corporate governance. Si elencano le tipologie di controversie di competenza della Chancery Court olandese: dubbi sulla corretta amministrazione di una società, contestazioni del rendiconto finanziario, incompatibilità delle decisioni amministrative con il Dutch Corporate Governance Code, conflitti relativi alla rimozione del Supervisory Board, e tentativi di esclusione di azionisti da parte di un azionista di maggioranza (con almeno il 95% del capitale). L’analisi evidenzia l’esistenza di un enforcement sia ex ante che ex post, con il potere dell’assemblea di valutare la giustificazione di eventuali deviazioni dalle best practices.
3. Conclusioni Codici di Condotta vs. Codici di Autodisciplina
La parte conclusiva del documento riassume le considerazioni svolte, distinguendo tra codici di condotta e codici di autodisciplina. Mentre un codice di autodisciplina è sempre un codice di condotta, il contrario non è necessariamente vero. La differenza risiede nella presenza, nei codici di autodisciplina, di un apparato procedurale, di controllo e di sanzioni, assenti nei codici di condotta più elementari. Il documento ribadisce la natura autopoietica dei codici di autodisciplina, che nascono dalla cristallizzazione delle buone prassi nel tempo, condivise da una comunità di operatori, e che prevedono conseguenze per la loro violazione, applicate da un soggetto designato tramite un iter procedurale. Si richiama l'articolo 27 ter del Codice del consumo, che riconosce la possibilità di un doppio binario di regolamentazione, con la possibilità per consumatori e concorrenti di adire l'organismo di controllo del codice di condotta per la risoluzione di controversie. Il documento evidenzia, in conclusione, le differenze di approccio e di efficacia tra codici di condotta e codici di autodisciplina, con quest’ultimi che godono di maggiore autorevolezza ed efficienza.
