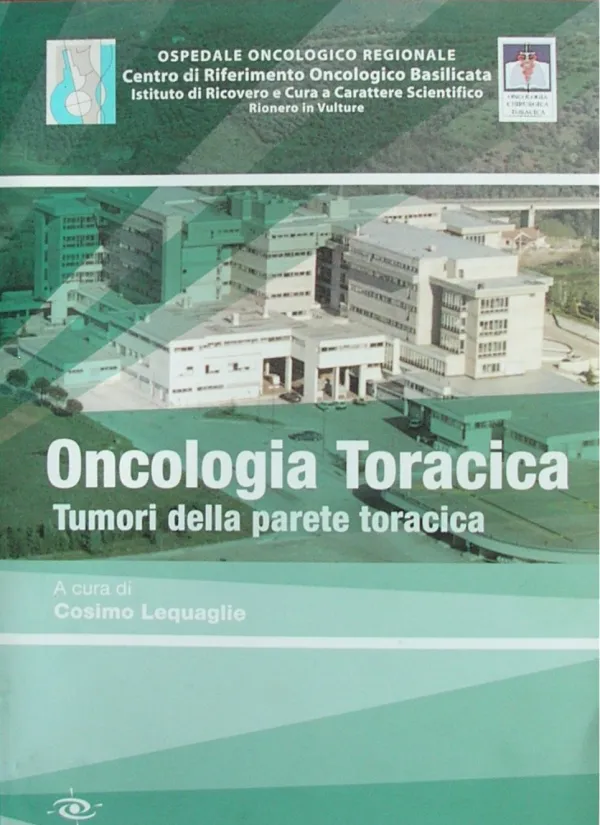
Oncologia Toracica: Tumori
Informazioni sul documento
| Autore | Cosimo Lequaglie |
| Specialità | Chirurgia Toracica, Oncologia Toracica |
| Tipo di documento | Libro |
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 2.62 MB |
Riassunto
I.Neoplasie della Parete Toracica Diagnosi e Classificazione
Il documento tratta principalmente le neoplasie della parete toracica, distinguendo tra tumori benigni e maligni. I tumori maligni, che rappresentano il 60%, includono frequentemente sarcomi (45% da tessuti molli, >50% da tessuto osseo/cartilagineo), condrosarcomi, osteosarcomi, e sarcoma di Ewing. La localizzazione più comune è sulle coste. La diagnosi si basa su imaging (RX torace, TC, RM, considerate il gold standard per l'infiltrazione della parete), agobiopsia percutanea (FNAB e core needle biopsy), e analisi citoistologica. L'immunoistochimica, la citogenetica, la PCR, la RT-PCR, la FISH, la CISH, e la CGH sono tecniche utilizzate per la diagnosi molecolare e la caratterizzazione dei tumori.
1. Classificazione dei Tumori della Parete Toracica
Il documento inizia classificando i tumori della parete toracica in benigni e maligni. Si sottolinea che i tumori maligni rappresentano la maggioranza (60%), con un'incidenza che aumenta dalla quarta decade di vita, sebbene alcuni tipi istologici siano caratteristici dell'infanzia (Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing). Tra i tumori maligni, i sarcomi sono i più comuni, suddivisi in quelli originanti dai tessuti molli (circa il 45%) e quelli con origine ossea o cartilaginea (più della metà). Specificamente, vengono menzionati il Condrosarcoma, l'Osteosarcoma e il Sarcoma di Ewing come le neoplasie più frequenti, seguiti da Fibrosarcoma, Tumore Desmoide indifferenziato e Rabdomiosarcoma. Le coste sono la sede più frequentemente colpita dai tumori primitivi, seguite dalle clavicole, mentre le neoplasie primitive di scapole e sterno sono più rare, ma nella maggior parte dei casi di natura maligna. La classificazione considera anche neoplasie primitive, neoplasie di organi vicini che invadono per contiguità e metastasi da organi distanti, sottolineando la sfida chirurgica rappresentata dai tumori primitivi, richiedendo radicalità nella fase demolitiva ed efficacia nella ricostruzione.
2. Metodi di Diagnosi
La diagnosi delle neoplasie della parete toracica si avvale di diverse metodiche. L'agobiopsia percutanea è menzionata come tecnica utile, utilizzabile sia a vista per lesioni clinicamente evidenti sia sotto guida ecografica o TC per lesioni più piccole o meno accessibili. L'impiego di aghi sottili (FNAB - Fine Needle Aspiration Biopsy) è preferito per piccole neoformazioni in pazienti con diagnosi pregressa di neoplasia maligna, per confermare o escludere la natura metastatica. La biopsia percutanea con ago tranciante (Core Biopsy) è un'altra opzione. L'importanza degli esami di imaging viene sottolineata: la risonanza magnetica nucleare (RMN) è definita come gold standard per la valutazione dell'infiltrazione della parete toracica, anche se l'individuazione precisa dell'infiltrazione può risultare difficile in alcuni casi, anche durante l'esplorazione chirurgica. La TC del torace è considerata l'esame più attendibile per valutare il grado di invasione tumorale nella parete toracica. Oltre alla TC e RM, vengono citate altre tecniche di indagine: la citogenetica, l'immunoistochimica, la PCR, la RT-PCR, la FISH, la CISH e la CGH per un'analisi più approfondita a livello molecolare.
II.Approccio Chirurgico ai Tumori della Parete Toracica Resezione e Ricostruzione
L'approccio chirurgico dipende dall'estensione e dall'istologia del tumore. Le resezioni en bloc sono essenziali per i tumori maligni, con ampiezza variabile secondo diversi autori (resezione della costa coinvolta, con coste adiacenti, o con 4-5cm di tessuto sano). Le resezioni possono essere radicali o pallative. La ricostruzione della parete toracica dopo resezione è fondamentale e prevede l'utilizzo di lembi muscolari (gran dorsale, grande pettorale, retto addominale), e protesi (Marlex, PTFE, metil-metacrilato), spesso combinate. La scelta del materiale protesico dipende dalle dimensioni del difetto, dalle condizioni del paziente e dall'esperienza del chirurgo.
1. Resezione Chirurgica Estensione e Approccio
L'approccio chirurgico ai tumori della parete toracica varia a seconda dell'estensione e dell'istologia del tumore. Per le lesioni benigne, sono generalmente indicate resezioni limitate con verifica istologica dei margini. Nel caso del condroma, per l'impossibilità di distinguerlo istologicamente dalla sua controparte maligna, si raccomanda sempre un'ampia resezione. Nei tumori maligni, l'exeresi radicale è essenziale per il successo terapeutico, sebbene l'estensione ottimale della resezione sia oggetto di dibattito tra gli autori. Alcuni propongono resezioni en-bloc delle coste coinvolte con le articolazioni cartilaginee in caso di infiltrazione midollare, mentre altri raccomandano una resezione più ampia, includendo le coste sopra e sotto quella patologica per garantire margini di sicurezza adeguati. Altri ancora suggeriscono la resezione della lesione con 4-5 cm di tessuto circostante macroscopicamente sano. L'approccio chirurgico varia anche a seconda della localizzazione del tumore: lesioni posteriori sotto il piano scapolare richiedono toracotomia con eventuale resezione dell'angolo della scapola, mentre le neoplasie paravertebrali necessitano di uno studio preoperatorio accurato per valutare i rapporti con le strutture centrali, potendo richiedere resezioni costali en bloc con il processo trasverso o l'emisoma vertebrale.
2. Ricostruzione della Parete Toracica
Le resezioni che comportano ampi difetti parietali, in particolare quelle che includono l'escissione en bloc dei tegumenti o riguardano lo sterno, richiedono una ricostruzione adeguata. Questa deve garantire la stabilità strutturale della gabbia toracica e la funzionalità respiratoria. La riparazione della breccia parietale può avvenire tramite chiusura primaria (avvicinando le coste indenni e sovrapponendo i muscoli) o secondaria (interponendo tessuti o materiali). Le ricostruzioni secondarie impiegano tessuti organici (lembi muscolari, omento) e/o materiali sintetici o misti. Il documento cita l'uso di protesi in rete di Marlex (considerata uno standard dal 1960), utilizzabile da sola o rinforzata con metil-metacrilato (cemento osseo), creando un “sandwich”. La scelta del materiale protesico (Marlex, PTFE, altri) dipende da diversi fattori: esperienza del chirurgo, condizioni del paziente (allergie, terapie immunosoppressive), sede e dimensioni del difetto, necessità di stabilizzazione della gabbia toracica, e disponibilità di lembi cutanei o miocutanei. Spesso vengono combinate diverse tecniche ricostruttive (tessuto osseo autologo, lembi omentali, flap cutanei, protesi in mersilene).
3. Esempi di Casistiche e Risultati
Il documento cita due studi importanti riguardanti la ricostruzione della parete toracica. Dechamps e Pairoleiro (Mayo Clinic, 1977-1992) hanno analizzato 197 pazienti trattati con materiale protesico (polipropilene e PTFE) per patologie tumorali (primitiva, metastatica, per contiguità). La mortalità post-operatoria è stata del 2.7%, con infezioni nell'1.3%. Le complicanze più frequenti sono state respiratorie (insufficienza respiratoria, polmoniti, atelettasie) e locali (deiscenze, ematomi, sepsi). Chapelier e Dartevelle (Hôpital Marie Lannelongue, Parigi, 1986-2002) hanno riportato 8 sternectomie totali e 23 parziali per tumori maligni dello sterno, con riparazione mediante protesi (Marlex, PTFE, vycril) e rinforzo con metil-metacrilato. La mortalità è stata bassa (1%), con 4 sepsi locali nel gruppo con rinforzo in metacrilato. La sopravvivenza a 5 anni è stata del 66%, con sopravvivenza libera da malattia del 59% a 5 anni e del 39% a 10 anni. Il grading dei sarcomi è risultato il principale fattore prognostico.
III.Gestione del Mesotelioma Pleurico Maligno
Il documento include una sezione specifica sulla gestione chirurgica del mesotelioma pleurico maligno. L'intervento prevede la pneumonectomia extrapleurica, con resezione del diaframma e linfoadenectomia. La ricostruzione toracica può essere necessaria dopo la resezione. Il testo cita una serie di 51 casi trattati tra il 1999 e il 2007.
1. Intervento Chirurgico e Tecniche
La sezione dedicata al mesotelioma pleurico maligno descrive un approccio chirurgico demolitivo con intento radicale. Sono stati considerati 55 pazienti nel periodo 1999-2007, di cui 51 sottoposti a pneumonectomia extrapleurica, con resezione diaframmatica. Il team chirurgico ha operato 34 di questi pazienti. Per 4 pazienti, l'intervento non è stato possibile a causa della progressione della malattia. Nei 30 pazienti operati con intento radicale, è stata eseguita una linfoadenectomia completa delle stazioni ilo-mediastiniche allargata; in alcuni casi, è stata associata una resezione costale o la resezione della vena cava superiore. La ricostruzione chirurgica delle strutture toraciche è stata effettuata in 51 casi dopo l'intervento demolitivo. In questa serie, il diaframma è stato ricostruito con Gore-Tex (2mm di spessore in 33 pazienti), e il pericardio (resezionato in 48 casi) con Gore-Tex più sottile (0.1mm). La parete toracica è stata ricostruita in 2 casi con reti di prolene. Le complicanze, tutte risolte, includevano una fistola del moncone bronchiale, trombosi della vena cava superiore, infarto del miocardio, erniazione toracica e rottura dello stomaco, empiema pleurico e chilotorace. Si è registrato un decesso a 30 giorni dall'intervento per ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome). La sopravvivenza a 5 anni, secondo il metodo di Kaplan-Meier, è stata del 73.8% nello stadio I e del 26.8% nello stadio III.
IV.Valutazione Preoperatoria e Gestione del Rischio
Una accurata valutazione preoperatoria è cruciale, includendo la storia clinica, l'esame obiettivo, studi di imaging (TC, RM), e la valutazione della funzionalità respiratoria. Si considera la storia di esposizione al fumo, inquinanti ambientali e malattie respiratorie preesistenti (BPCO, asma, ecc.). La presenza di patologie cardiache, renali o epatiche influenza il rischio post-operatorio. L'età da sola non è un fattore determinante, eccetto in combinazione con altre comorbidità.
1. Identificazione dei Pazienti ad Alto Rischio
L'identificazione dei pazienti ad alto rischio per complicanze post-operatorie è fondamentale nella valutazione preoperatoria. Questo processo si basa su una attenta analisi della storia clinica del paziente, includendo un esame obiettivo completo e la valutazione di tutti i risultati diagnostici radiologici e di laboratorio disponibili. Particolare attenzione viene dedicata alla valutazione di eventuali problemi respiratori, considerando fattori come la storia di esposizione al fumo di sigaretta, l'esposizione a inquinanti ambientali sul luogo di lavoro e la presenza di patologie respiratorie attuali o pregresse (BPCO, asma, pleuriti, polmoniti, interstiziopatie). È inoltre necessaria una precisa valutazione funzionale respiratoria per determinare la capacità polmonare del paziente. Infine, è importante considerare la presenza di fattori di rischio non direttamente legati all'apparato respiratorio ma che possono comunque influenzare negativamente il decorso post-operatorio, come patologie cardiache, renali o epatiche. L'età, invece, da sola non è considerata un fattore peggiorativo in un paziente altrimenti in buona salute.
V. Riabilitazione Respiratoria e Miglioramento della Qualità di Vita
Il documento fa riferimento all'importanza della riabilitazione respiratoria nel miglioramento della HRQOL (Health-Related Quality of Life) in pazienti con patologie polmonari, inclusi quelli sottoposti a chirurgia toracica. Si citano studi che dimostrano miglioramenti significativi nella dispnea, nell'affaticamento e nella capacità di esercizio dopo la riabilitazione. Si sottolinea l'efficacia della riabilitazione anche al di fuori dei centri specializzati.
1. Efficacia della Riabilitazione Respiratoria Evidenze dagli Studi
La sezione discute l'efficacia della riabilitazione respiratoria nel migliorare la qualità di vita (HRQOL) dei pazienti, focalizzandosi su studi che ne dimostrano i benefici. Uno studio ha evidenziato un miglioramento statisticamente e clinicamente significativo in termini di dispnea, affaticamento, emozioni e controllo della malattia, con miglioramenti nella capacità d'esercizio quasi clinicamente significativi. Una metanalisi di Cambach e colleghi ha identificato 18 articoli che dimostrano miglioramenti significativi nelle misure di esercizio (capacità massimale, tempo di resistenza, distanza percorsa) e nella HRQOL in tutte le dimensioni del CRDQ (dispnea, affaticamento, emozioni, padronanza). Questi miglioramenti si sono mantenuti fino a 9 mesi dopo la riabilitazione. Altri studi osservazionali multicentrici, sebbene non RCT, hanno fornito forti evidenze sull'efficacia della riabilitazione respiratoria, mostrando miglioramenti nella dispnea e nella HRQOL, anche se con un declino graduale dei benefici nel tempo (18 mesi). Un piccolo studio di White e colleghi ha riportato miglioramenti modesti, non sempre statisticamente o clinicamente significativi.
2. Utilizzo delle Risorse Sanitarie e Costo Efficacia
La riabilitazione respiratoria mostra anche un impatto positivo sull'utilizzo delle risorse sanitarie. Uno studio di Griffiths e colleghi ha dimostrato che, pur mantenendo un numero simile di ricoveri ospedalieri rispetto al gruppo di controllo, il numero di giorni di ricovero è stato significativamente inferiore nel gruppo sottoposto a riabilitazione (10.4 vs 21.0 giorni). Un'analisi economica costo-utilità ha indicato che la riabilitazione respiratoria è costo-efficace, con potenziali benefici economici per il sistema sanitario, misurati in anni di vita corretti per qualità. Altri studi osservazionali hanno confermato una riduzione significativa delle ospedalizzazioni e delle riacutizzazioni a lungo termine dopo la riabilitazione. Anche un programma di supporto telefonico post-riabilitazione ha mostrato risultati positivi, con un declino dei benefici nel gruppo di controllo (senza supporto) nei due anni di follow-up, sottolineando l'importanza del mantenimento dei risultati raggiunti.
VI.Stadiazione e Prognosi dei Tumori del Polmone con Invasione della Parete Toracica T3
La sezione analizza la stadiazione e la prognosi dei tumori del polmone (T3) con invasione della parete toracica. La TC è l'esame più attendibile per valutare l'invasione. La presenza di metastasi linfonodali (N1-N2) peggiora significativamente la prognosi. Si discute dell'utilità di trattamenti neo-adiuvanti (radioterapia e chemioterapia) e della necessità di una linfoadenectomia regionale completa. Si menzionano studi con dati di sopravvivenza a 5 anni correlati allo stadio della malattia.
1. Stadiazione dei Tumori Polmonari T3
La sezione si concentra sulla stadiazione e prognosi dei tumori polmonari che invadono la parete toracica (T3). La tomografia computerizzata (TC) del torace è indicata come l'esame più affidabile per valutare il grado di invasione tumorale nella parete toracica, permettendo, nella maggior parte dei casi, di definire l'indicazione preoperatoria di resezione costale. Nei casi borderline, dove non è chiara l'estensione dell'infiltrazione nei tessuti molli, si può considerare un trattamento neo-adiuvante con radioterapia e/o chemioterapia, soprattutto in presenza di malattia linfonodale, per ridurre la massa tumorale prima dell'intervento chirurgico. Per una stadiazione completa, finalizzata all'esclusione di metastasi a distanza, vengono menzionate la TC addome e encefalo con mezzo di contrasto e la scintigrafia ossea. Negli anni recenti, questi esami sono stati in parte sostituiti dalla PET total body, per una stadiazione più precisa. La valutazione cardiologica e della funzionalità respiratoria completa lo studio preoperatorio, prevedendo un trattamento fisiochinesiterapico postoperatorio.
2. Prognosi e Fattori Prognostici
La prognosi dei tumori polmonari T3 con infiltrazione della parete toracica dipende fortemente dall'estensione della malattia, in particolare dalla presenza o meno di metastasi linfonodali. L'infiltrazione della parete toracica per contiguità, pur rappresentando un'invasività loco-regionale significativa, è ancora considerata potenzialmente curabile con un approccio chirurgico radicale. Tuttavia, la presenza di metastasi linfonodali peggiora drasticamente la prognosi, con una sopravvivenza a distanza significativamente ridotta nei primi tre anni. Gli studi citati mostrano una sopravvivenza a distanza variabile tra 0% e 26% nei pazienti con interessamento linfonodale (N1-N2), sottolineando il valore predittivo dell'interessamento linfonodale e la natura sistemica di questo tipo di tumore. Lo studio accurato dei linfonodi, in particolare quelli mediastinici, è quindi fondamentale, e vengono menzionate diverse metodiche utilizzabili, come la TBNA (transbronchial needle aspiration), l'ultrasonografia endoscopica e la mediastinoscopia (gold standard).
