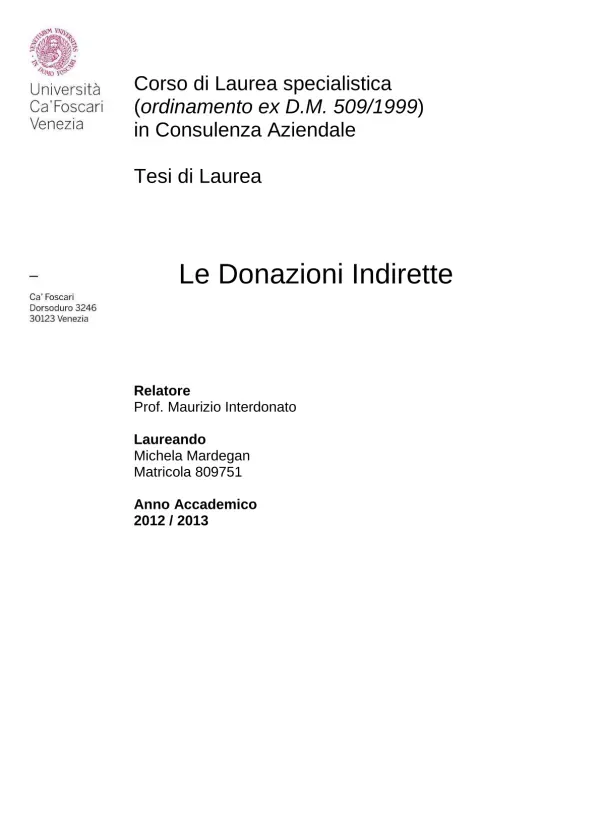
Donazioni Indirette: Tesi di Laurea
Informazioni sul documento
| Autore | A Chi Ha Creduto Nelle Mie Possibilità Fino Alla Fine… |
| instructor | Prof. Maurizio Interdonato |
| Specialità | Consulenza Aziendale |
| Tipo di documento | Tesi di Laurea |
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 1.03 MB |
Riassunto
I.La Donazione Indiretta nel Diritto Civile Italiano Definizione e Distinzione dalle Liberalità
Il documento analizza la complessa figura della donazione indiretta nel diritto civile italiano, distinguendola dalle liberalità dirette. Un elemento chiave è l'individuazione dell' animus donandi, l'intenzione di donare, che nella donazione indiretta si manifesta attraverso schemi negoziali diversi dalla donazione classica. Si evidenzia la necessità di valutare l'interesse effettivo che sottende l'operazione, considerando l'entità dell'attribuzione, la durata del rapporto e la qualità dei soggetti coinvolti. La Cassazione, con sentenze come quella del 8 maggio 2006 n. 10490, ha contribuito all'interpretazione di questa figura giuridica, spesso oggetto di dibattito dottrinale (Palazzo, Sassi; Mazzarèse, Palazzo; Tringali; Capozzi).
II.Tipi di Contratti Utilizzati nelle Donazioni Indirette
Il documento esplora diversi tipi di contratti utilizzati per realizzare una donazione indiretta: il comodato d'uso, spesso impiegato per eludere la forma solenne della donazione; il mutuo di scopo, dove la finalità dell'operazione è rilevante; la fideiussione, che può mascherare un intento liberale. Si evidenzia la necessità di analizzare caso per caso la presenza dell’animus donandi, considerando se l’operazione comporti un effettivo arricchimento del beneficiario e un depauperamento del patrimonio del disponente, anche indirettamente (es. risparmio di spesa per il comodatario).
III.Azioni di Riduzione e Collazione nelle Donazioni Indirette
Il documento affronta le azioni di riduzione e collazione applicabili alle donazioni indirette. Si discute l'oggetto di tali azioni, che può essere il denaro elargito oppure il bene acquistato con esso. La giurisprudenza (es. Cassazione civile, sez. II, 31 gennaio 1989 n. ...) e la dottrina (Iaccarino, Apicelia) offrono diverse interpretazioni, in particolare riguardo all'applicabilità dell'art. 563 c.c. e alla possibilità di recupero reale del bene. Si evidenzia la complessità dell'individuazione dell’oggetto, distinguendo tra ciò che è uscito dal patrimonio del donante e ciò che è entrato in quello del donatario.
IV.Il Negozio Indiretto e la Donazione Indiretta
Si analizza il rapporto tra donazione indiretta e negozio indiretto, sottolineando la divergenza tra lo scopo perseguito dalle parti e la funzione tipica del negozio utilizzato. Si discute se la donazione indiretta sia sempre riconducibile allo schema del negozio indiretto, considerando anche ipotesi al di fuori dell'ambito strettamente negoziale. Il documento cita diverse opinioni dottrinali a riguardo, evidenziando l’importanza della disfunzione tra intento e causa.
V.Il Trust e le Liberalità Indirette
Il documento esamina il trust come possibile strumento per realizzare liberalità indirette, discutendo le diverse teorie dottrinali (Iaccarino, Bonilini, Palazzo) che negano o affermano la sua configurabilità come donazione. Si analizza l’utilizzo del trust per agevolare la circolazione dei beni provenienti da donazioni, tutelando l’acquirente da eventuali azioni di riduzione e restituzione dei legittimari lesi. L’analisi si concentra sugli effetti della costituzione del trust e del trasferimento dei beni ai beneficiari, considerando le implicazioni fiscali e gli obblighi di registrazione.
VI.Il Patto di Famiglia e le Liberalità Indirette
Il documento analizza il patto di famiglia come strumento contenente spesso liberalità indirette, in relazione al suo ruolo di contratto a favore di terzo e alle conseguenze per i legittimari lesi. Si evidenzia l’importanza di mantenere un sostanziale equilibrio tra le reciproche prestazioni per evitare la configurabilità di una donazione indiretta e le relative conseguenze in sede di successione, richiamando l’art. 768 quarter del Codice Civile.
VII. Imposta di Successione e Donazione sulle Liberalità Indirette
Il documento approfondisce la tassazione delle liberalità indirette con riferimento all'imposta di successione e donazione. Si analizzano le difficoltà legate alla quantificazione economica e alla rilevazione del fenomeno, soprattutto in assenza di atti scritti soggetti a registrazione. Si esaminano le implicazioni dell’art. 56-bis del D.Lgs n. 346/90, le modifiche introdotte dalla legge 342/2000 e dalla legge 286/2006, e le diverse interpretazioni dottrinali riguardo alla compatibilità tra le norme. Si discute anche il problema della doppia imposizione fiscale in alcuni casi (rendite vitalizie).
VIII.Acquisto di Immobili con Denaro Altrui e Donazione Indiretta
Si analizza l’acquisto di immobili con denaro altrui come tipica fattispecie di donazione indiretta, illustrando diverse formule negoziali utilizzabili (pagamento diretto, contratto in nome e per conto, contratto per persona da nominare, contratto a favore di terzo). Si esamina l'applicazione dell'imposta di successione e donazione, con riferimento all'art. 1, comma 4-bis, del D.Lgs n. 346/90 e alla giurisprudenza (es. Commissione Tributaria di Savona, Sent. n. 24 e n. 25 del 19/02/2010), evidenziando la necessità di dimostrare l'assenza di un rapporto di prestito tra le parti per evitare l’accertamento della donazione indiretta.
IX.Rendita Vitalizia e Donazione Indiretta
Il documento approfondisce la rendita vitalizia come possibile strumento per realizzare liberalità indirette, analizzando il momento di perfezionamento dell’obbligazione tributaria e i potenziali problemi di doppia imposizione fiscale. Si fa riferimento all’art. 17 del D.Lgs n. 346/90 per la determinazione della base imponibile e alle norme sull’imposta sul reddito (D.P.R. n. 917/1986), evidenziando le difficoltà di coordinamento tra le due tipologie di tributo.
1. La Rendita Vitalizia come Strumento di Donazione Indiretta
La sezione analizza l'utilizzo della rendita vitalizia come potenziale strumento per realizzare donazioni indirette. L'attenzione si concentra sulla natura giuridica di questo strumento e sulle sue implicazioni fiscali, in particolare riguardo alla tassazione. Il testo sottolinea l'ambiguità del suo utilizzo, dato che può essere sia oneroso che gratuito, e quindi la difficoltà nel classificarlo inequivocabilmente come atto di liberalità indiretta. Viene evidenziato come, in determinate circostanze, una rendita vitalizia possa essere utilizzata per eludere la forma solenne della donazione diretta, risultando in un arricchimento del beneficiario (il terzo) senza il diretto passaggio del bene dal patrimonio del donante. Si discute anche la difficoltà nel definire il momento preciso in cui si perfeziona la liberalità indiretta, legandolo alla dichiarazione di adesione del beneficiario, e non all’effettiva esecuzione delle prestazioni periodiche. Questo perché, ai fini della determinazione della base imponibile (ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs n. 346/90), si considera il valore attualizzato della rendita e non il valore futuro delle singole rate. La complessità risiede nel bilanciamento tra la volontà delle parti e la definizione legale dello strumento utilizzato.
2. Problematiche di Doppia Imposizione Fiscale
Un'altra questione affrontata è il rischio di doppia imposizione fiscale in caso di rendite vitalizie configurate come donazioni indirette. Il documento evidenzia come l'art. 50, lett. h) del DPR n. 917/1986, sull'imposta sui redditi, assimi al reddito di lavoro dipendente le rendite vitalizie a tempo determinato costituite a titolo oneroso. Tuttavia, se la rendita è costituita a titolo gratuito (liberalità), il beneficiario potrebbe essere tassato sia per l'imposta di donazione (sulla costituzione della rendita) sia per l'imposta sul reddito (sulle rate percepite). Questo crea un problema di coordinamento tra le due tipologie di tributo, sottolineando la discordanza tra l’onerosità del negozio-mezzo (rilevante ai fini dell’imposta sul reddito) e la liberalità indiretta conseguita dal terzo (rilevante per l’imposta donativa). La situazione si complica ulteriormente nel caso di rendite perpetue, assimilate ai redditi di capitale dall'art. 44 del DPR n. 917/1986, che non fa distinzione tra rendite costituite a titolo oneroso o gratuito, aprendo così a potenziali sovrapposizioni fiscali. La sezione conclude evidenziando la necessità di un attento esame delle norme per evitare interpretazioni che possano portare a tassazioni inique o sovrapposte.
X.Delegazione Espromissione Fideiussione e Liberalità Indirette
Il documento conclude analizzando delegazione, espromissione e fideiussione come possibili strumenti per realizzare liberalità indirette, evidenziando come l’intento liberale possa emergere anche nella fase esecutiva di un negozio preesistente. Si cita la Circ. Agenzia Entrate n. 48/E del 06/08/2007 riguardo alle implicazioni fiscali del trust, con particolare attenzione al momento di applicazione dell’imposta di successione e donazione in relazione alle diverse fasi costitutive del trust.
1. Delegazione Espromissione Accollo e Fideiussione Meccanismi per Liberalità Indirette
Questa sezione del documento analizza come istituti giuridici come la delegazione, l'espromissione, l'accollo e la fideiussione possano essere utilizzati per realizzare liberalità indirette. A differenza di una donazione diretta, in questi casi l'atto liberale non deriva da un contratto apposito, ma dall'ingresso di un terzo soggetto in un rapporto obbligatorio preesistente. L'attenzione si concentra sul meccanismo attraverso cui il cambiamento del soggetto passivo dell'obbligazione, o l'assunzione di una responsabilità contrattuale da parte di un terzo, può mascherare un'intenzione donativa. Si evidenzia che la liberalità indiretta spesso emerge nella fase esecutiva di un negozio già esistente, senza la stipulazione di un atto specifico destinato a tale scopo. Un esempio citato è la delegazione, dove il delegante (chi intende donare) fa assumere al delegato (che diventa debitore) un'obbligazione nei confronti del delegatario (il beneficiario), senza uno scambio reciproco di prestazioni. In questo caso, l’arricchimento del donatario corrisponde al depauperamento del patrimonio del delegante, configurandosi così una donazione indiretta. La sezione sottolinea la flessibilità e la praticità di questi meccanismi nell'ambito delle liberalità indirette, spesso utilizzati nella prassi comune.
2. Il Ruolo della Fideiussione nella Configurazione di una Donazione Indiretta
La sezione approfondisce il ruolo specifico della fideiussione nella realizzazione di liberalità indirette. Il documento evidenzia la complessità del rapporto tra fideiussore e debitore principale, sottolineando l'assenza di un mandato formale del debitore principale al fideiussore. Si analizza la possibilità, in sede di contrattazione, di inserire clausole che chiariscano l'intento di donazione indiretta, come l'esclusione del diritto di regresso per il fideiussore. Questo elemento, insieme alla sproporzione tra le prestazioni, diventa un indicatore significativo per qualificare l’operazione come donazione indiretta. Si specifica che il creditore potrebbe non essere a conoscenza di tali accordi preliminari tra fideiussore e debitore principale, ma la presenza di clausole che limitano i diritti del fideiussore, o la sproporzione evidente tra il beneficio ricevuto e l'onere assunto, possono essere elementi decisivi nell’accertamento dell’animus donandi. Il documento evidenzia quindi come anche un contratto apparentemente oneroso, come una fideiussione, possa celare una liberalità indiretta, richiedendo un'analisi approfondita del contesto e delle volontà delle parti coinvolte, per distinguerla da una semplice fideiussione.
3. Implicazioni Fiscali e Circolare Agenzia Entrate n. 48 E del 06 08 2007 Trust
La sezione conclude focalizzandosi sulle implicazioni fiscali e citando la Circolare Agenzia Entrate n. 48/E del 06/08/2007, che analizza l’operazione del trust e la distingue in quattro fasi: l’atto istitutivo, l’atto dispositivo (con segregazione dei beni), gli eventuali trasferimenti durante la vigenza del trust e, infine, il trasferimento dei beni ai beneficiari. Ogni fase presenta diverse implicazioni fiscali, con l’imposta di donazione applicabile principalmente al passaggio dei beni dal trust al beneficiario finale, quando effettivamente si verifica l’incremento della capacità contributiva del beneficiario. L'applicazione di diverse aliquote dipende dall'identità e dal grado di parentela dei beneficiari con il disponente. La Circolare specifica anche le imposte ipotecarie e catastali dovute nei casi di conferimento di beni immobili nel trust. La sezione evidenzia, dunque, come l'analisi delle liberalità indirette debba tenere conto non solo del singolo atto, ma dell’intero contesto operativo, in una prospettiva che tenga conto delle diverse tipologie di imposizione fiscale a cui può essere soggetta l’operazione.
