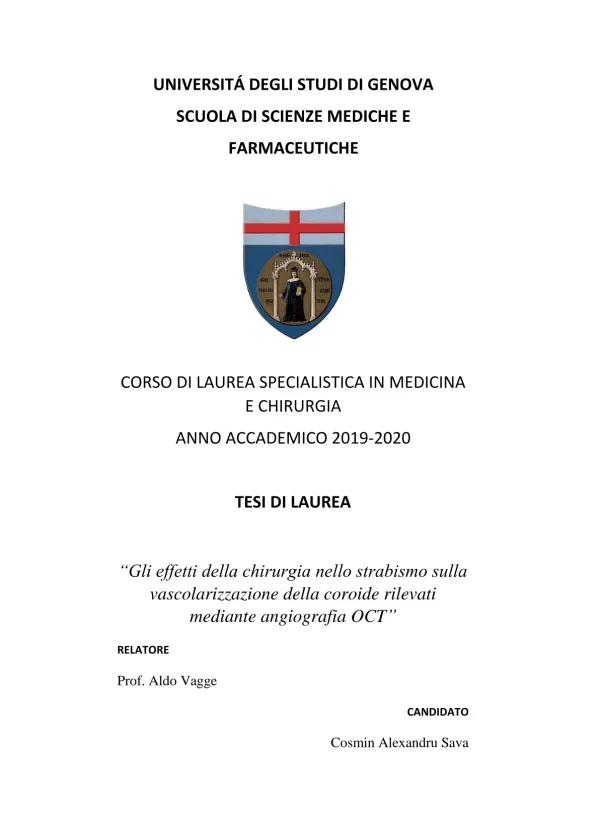
Angiografia OCT e Strabismo
Informazioni sul documento
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 1.68 MB |
Riassunto
I.Coroide Anatomia e Funzione
La coroide, uno strato vascolare di circa 300 µm di spessore, riveste i due terzi posteriori del bulbo oculare, estendendosi dall'ingresso del nervo ottico all'ora serrata. Ricca di vasi sanguigni, la coroide nutre la retina e, insieme all'epitelio pigmentato retinico (RPE), assorbe la luce in eccesso. La sua struttura, composta da tre strati nel polo posteriore (strato di Sattler, strato coriocapillare (CC), e membrana di Bruch), è fondamentale per l'omeostasi del complesso coroide/RPE/fotorecettori. La CC, in particolare, ha un ruolo chiave nel fornire ossigeno e nutrienti ai fotorecettori, rimuovendo i prodotti di scarto. Il diametro dei capillari della CC è relativamente ampio (15-30 µm).
1. Localizzazione e Struttura della Coroide
La coroide è una sottile lamina che riveste i due terzi posteriori del bulbo oculare, estendendosi dall'ingresso del nervo ottico fino all'ora serrata. Si continua poi gradualmente nel corpo ciliare, assumendo una forma a due terzi di sfera cava. Con uno spessore di circa 300 µm, il suo colore scuro è dovuto all'elevata densità di vasi sanguigni. Questi vasi sono fondamentali per nutrire gli strati esterni della retina e l'epitelio pigmentato retinico (RPE). In collaborazione con l'RPE, la coroide ha la funzione cruciale di assorbire i raggi luminosi che attraversano la retina, prevenendo riflessi interni che potrebbero compromettere la qualità visiva. Nel polo posteriore, la struttura della coroide si presenta in tre strati distinti: lo strato di Sattler (arteriole e venule), lo strato coriocapillare (CC), adiacente alla membrana di Bruch, e lo strato più profondo di vasi più grandi. La disposizione a tre strati è presente solo nella porzione posteriore della coroide, mentre nelle altre zone sono presenti solo la CC e uno strato più profondo di vasi più grandi. Il sistema vascolare della CC è unico, mostrando un pattern lobulare nella parte centrale e fenestrato solo nella porzione retinica dei vasi; i capillari hanno un diametro relativamente ampio, variando tra 15 e 30 µm.
2. Funzione della Coriocapillare CC e Relazione con RPE e Fotorecettori
La stretta associazione anatomica e funzionale tra la coriocapillare (CC) e l'epitelio pigmentato retinico (RPE) è essenziale per il corretto funzionamento della retina. I fotorecettori, cellule metabolicamente molto attive, dipendono dalla CC per il rifornimento di nutrienti e ossigeno, nonché per la rimozione dei prodotti di scarto derivanti dal loro continuo rinnovamento e dalla digestione delle membrane esterne nel RPE. La CC, quindi, svolge un ruolo fondamentale nel mantenere l'omeostasi dell'intero complesso coroide/RPE/fotorecettori, garantendo un ambiente ottimale per la funzione visiva. La presenza di fattori come il fattore di von Willebrand (vWF), una glicoproteina che media il legame delle piastrine in caso di danno vascolare, e il VEGFR-2, recettore coinvolto nella proliferazione delle cellule endoteliali durante l'angiogenesi, sottolinea ulteriormente la complessità e l'importanza del sistema vascolare coroideale per la salute dell'occhio.
II.Sviluppo della Coriocapillare
Lo sviluppo della coriocapillare (CC) inizia attorno all'11-12° settimana di gestazione (WG), con vasi più profondi che si sviluppano maggiormente nel polo posteriore. All'inizio, i vasi sono privi di fenestrature e lamina basale. Intorno alla 14° WG, iniziano ad apparire cellule simili a periciti, marcatori di maturazione vascolare (αSMA e NG2). Alla 21° WG, sono visibili tre strati vascolari nel polo posteriore, e l'immunoreattività per PV-1 aumenta, indicando la maturazione della CC. Alla 22° WG, la CC presenta una parete sottile con fenestrature, e la membrana di Bruch è più sviluppata.
1. Inizio dello Sviluppo Vascolare 11 12 WG
Intorno all'11-12° settimana di gestazione (WG), si osserva la comparsa di vasi più profondi nella coroide, con una maggiore densità nel polo posteriore rispetto alla regione equatoriale. Cellule endoteliali (EC), marcate con CD34 e Ki67, proliferano dalla parte sclerale della coriocapillare (CC), suggerendo un processo di angiogenesi nella formazione dei vasi intermedi. È interessante notare che, a questo stadio di sviluppo, i vasi sono negativi per PV-1 (plasmalemmal vesicle-associated protein), una glicoproteina di membrana presente nei diaframmi delle fenestrature nei capillari maturi. Inoltre, la lamina basale non è ancora presente. La struttura della CC a questo stadio è caratterizzata da aggregati di progenitori con lumi simili a fessure, con alcune cellule in posizione avventiziale rispetto alle cellule che formano il lume primitivo. Tutti i progenitori appaiono rigonfi, e si osservano alcune 'tight junctions' tra le cellule che delimitano il lume, indicando l'inizio dell'organizzazione strutturale dei vasi.
2. Maturazione Vascolare e Comparsa di Periciti 14 WG
Alla 14° WG, nella CC periferica, si osservano cellule in posizione abluminale simili a periciti che stabiliscono contatti specifici con le cellule endoteliali (EC), caratteristici della microvascolarizzazione dell'adulto. L'analisi della maturazione di queste cellule abluminali si basa su due marcatori: l'actina α del muscolo liscio (αSMA), presente nei periciti maturi, e NG-2, un glicosamminoglicano presente sulla loro superficie. A 14 WG, l'immunoreattività per αSMA è limitata, mentre quella per NG2 è molto marcata, indicando uno stadio di sviluppo ancora immaturo dei periciti. Questa osservazione suggerisce un processo graduale di maturazione vascolare, con la progressiva acquisizione delle caratteristiche strutturali e funzionali tipiche della microvascolatura adulta. La differenziazione dei periciti è un evento critico nello sviluppo della rete vascolare, contribuendo alla stabilità e alla regolazione del flusso sanguigno.
3. Formazione degli Strati Vascolari e Maturazione 21 22 WG
Alla 21° WG, si osserva per la prima volta la presenza di tre strati distinti di vasi sanguigni nel polo posteriore della coroide, come evidenziato dai marcatori delle cellule endoteliali (EC). Questo evento coincide con l'inizio della maturazione dei fotorecettori, sottolineando la stretta relazione tra lo sviluppo vascolare e la funzionalità retinica. L'immunoreattività per PV-1, la glicoproteina associata alle fenestrature capillari, è presente nella maggior parte della CC, ma risulta più intensa nel polo posteriore che nella periferia, indicando una maturazione più avanzata nella regione maculare. Nell'occhio adulto, la distribuzione di PV-1 è uniforme e più evidente nella porzione retinica del lume della CC, mentre gli altri marcatori delle EC sono distribuiti uniformemente intorno alla CC. Alla 22° WG, la CC ha una parete sottile, con vasi piatti e lumi aperti, aree con fenestrature e 'tight junctions' ben formate. La membrana di Bruch è più sviluppata, con collagene ed elastina disperse sotto la membrana basale del RPE. Fino a questo stadio, l'espressione di αSMA e NG-2 continua ad aumentare nei periciti, confermando il processo di maturazione della vascolarizzazione coroideale.
III.Vascolarizzazione della Coroide e Alterazioni in Patologie
Le arterie ciliari posteriori brevi, originando dalle arterie ciliari posteriori, irrorano la coroide, formando l'anello di Haller attorno al nervo ottico. Il drenaggio venoso avviene tramite le vene vorticose. Importanti cambiamenti nella vascolarizzazione coroideale si osservano in diverse patologie. Nel pre-menopausa, il flusso sanguigno coroideale è maggiore rispetto al post-menopausa e agli uomini della stessa età, evidenziando il ruolo degli ormoni femminili. Nella degenerazione maculare legata all'età (DMAE), si osserva una riduzione del flusso nella coriocapillare e del choroidal vascularity index (CVI), oltre ad un aumento della resistenza vascolare. Il diabete mellito di tipo 2 (DM2) causa una riduzione della componente vascolare coroideale, con perdita di vasi sanguigni che può essere diffusa o focale.
1. Sistema Arterioso e Venoso della Coroide
Il sistema arterioso della coroide origina dalle arterie ciliari posteriori, sia mediali che laterali, che danno luogo a rami brevi (arterie ciliari posteriori brevi, circa 20) e a un ramo lungo (arteria ciliare posteriore lunga). Le arterie ciliari posteriori brevi perforano la sclera intorno al nervo ottico, formando un cerchio arterioso (anello di Haller) da cui originano le arterie cilioretiniche dirette alla retina. Queste arterie si ramificano nello strato vascolare della coroide e terminano nel coriocapillare. Le arterie ciliari posteriori (mediali e laterali), dopo aver perforato la sclera, proseguono anteriormente. Il drenaggio venoso, invece, presenta differenze rispetto al sistema arterioso. La parte anteriore del corpo ciliare è drenata dalle vene ciliari anteriori, che ricevono anche l'umore acqueo dal seno venoso della sclera (canale di Schlemm) e sono tributarie della vena oftalmica. Il sangue dalla parte posteriore della sclera confluisce nelle vene ciliari posteriori (anch'esse tributarie della vena oftalmica), mentre il sangue proveniente dalla coroide, dal corpo ciliare e dall'iride è convogliato nelle quattro vene vorticose, che drenano in vena oftalmica. Questa organizzazione vascolare complessa è fondamentale per la nutrizione e l'ossigenazione della coroide e delle strutture ad essa associate.
2. Influenza Ormonale e Invecchiamento sul Flusso Sanguigno Coroideale
Il flusso sanguigno coroideale subisce modificazioni legate all'età e al sesso. In particolare, si osserva un flusso significativamente maggiore nella coroide delle donne in pre-menopausa rispetto agli uomini della stessa età e alle donne in post-menopausa. Questa differenza non persiste nel post-menopausa, dove il flusso sanguigno si equipara a quello maschile della stessa età. Negli uomini, invece, non si riscontra una significativa variazione del flusso sanguigno con l'età. Queste osservazioni dimostrano un ruolo importante degli ormoni femminili nella regolazione del flusso sanguigno coroideale. La comprensione di queste dinamiche è cruciale per la valutazione della salute vascolare oculare e per la comprensione delle alterazioni che possono insorgere in diverse fasi della vita.
3. Alterazioni della Vascolarizzazione Coroideale in Patologie
La vascolarizzazione coroideale è significativamente alterata in diverse patologie oculari. Nella degenerazione maculare senile (DMS), malattia comune nella popolazione anziana, si osserva una riduzione del flusso nella coriocapillare e del choroidal vascularity index (CVI), indice di vascolarizzazione coroideale, insieme ad un aumento della pulsatilità e una riduzione della velocità del flusso nelle arterie ciliari posteriori brevi, suggerendo un aumento della resistenza vascolare. Queste alterazioni contribuiscono alla fisiopatologia della DMS. Anche il diabete mellito di tipo 2 (DM2) provoca importanti alterazioni coroideali, con una riduzione della componente vascolare, che può manifestarsi in modo diffuso (perdita di segmenti capillari senza aree completamente prive di coriocapillare) o focale (aree di assenza completa di coriocapillare). Queste alterazioni vascolari, insieme ad altri fattori come la glicazione, le specie reattive dell'ossigeno, gli oncogeni e le citochine, possono contribuire alla progressione della malattia e alla possibile perdita della vista.
IV.Chirurgia dello Strabismo Tecniche e Complicazioni
La chirurgia dello strabismo mira a ristabilire la visione binoculare singola (BSV). Le principali tecniche chirurgiche includono la recessione (indebolimento muscolare) e la resezione (rafforzamento muscolare) dei muscoli estrinseci dell'occhio. L'intervento prevede l'isolamento del muscolo, la sua disinserzione e il riposizionamento in una nuova posizione sulla sclera. Le misurazioni dell'angolo di deviazione con prismi aiutano a pianificare l'intervento. Complicazioni postoperatorie possono includere infezioni, perforazione sclerale, e scivolamento del muscolo. L'OCT e l'OCT-A sono strumenti utili per la valutazione pre e postoperatoria, permettendo la misurazione dello spessore coroideale e della densità vascolare retinica.
1. Obiettivi della Chirurgia dello Strabismo
La chirurgia dello strabismo ha come obiettivo principale il ripristino o il miglioramento della visione binoculare singola (BSV), ovvero la capacità di fondere le immagini provenienti da entrambi gli occhi in una singola percezione. Questo permette una corretta percezione della profondità. Oltre alla funzione visiva, la chirurgia considera anche l'impatto estetico e sociale dello strabismo, cercando di migliorare l'aspetto cosmetico e di ridurre i disagi derivanti da un evidente disallineamento oculare. Prima di ricorrere alla chirurgia, è fondamentale correggere eventuali errori refrattivi significativi e trattare l'ambliopia (occhio pigro), massimizzando il potenziale visivo di ciascun occhio. La chirurgia è presa in considerazione solo quando altri trattamenti, come l'utilizzo di occhiali, non sono riusciti a correggere completamente la deviazione.
2. Tecniche Chirurgiche Principali Recessione e Resezione
Le principali tecniche chirurgiche utilizzate per correggere lo strabismo sono la recessione e la resezione dei muscoli estrinseci dell'occhio. La recessione consiste nell'indebolimento di un muscolo, diminuendo la sua forza d'azione effettiva, mentre la resezione comporta il rafforzamento di un muscolo, aumentando la sua forza. L'intervento chirurgico prevede diverse fasi: isolamento del muscolo, pulizia dell'inserzione muscolare, disinserzione dal bulbo oculare e riposizionamento in una nuova posizione sulla sclera. La quantità di recessione o resezione è determinata da misurazioni precise dell'angolo di deviazione, effettuate tramite prismi in diverse posizioni dello sguardo. Vengono utilizzati strumenti specifici come forbici di Westcott, forcipe di Castroviejo o Moody, e suture 6-0, spesso assorbibili. Tecniche come la sutura 'hang-back', alternativa alla recessione diretta, permettono un maggiore controllo del posizionamento del muscolo. La scelta tra recessione e resezione dipende dai muscoli coinvolti e dal tipo di deviazione.
3. Complicazioni Postoperatorie e Aspetti Intraoperatori
Sebbene la chirurgia dello strabismo sia generalmente sicura, esistono potenziali complicanze. Le infezioni, seppur rare grazie alle procedure di sterilizzazione, possono verificarsi nei giorni successivi all'intervento, manifestandosi con rossore, dolore, suppurazione e/o tumefazione palpebrale. In casi più gravi, l'infezione può diffondersi ai tessuti orbitali profondi, richiedendo un trattamento aggressivo. Un rischio intraoperatorio è la perforazione sclerale durante la sutura o l'escissione del muscolo, che può portare a cicatrici corioretiniche o, in casi più gravi, a endoftalmiti, emorragie del vitreo e distacchi retinici. La sclera è più sottile dietro l'inserzione muscolare, rendendo le recessioni più delicate. Un'altra possibile complicazione è lo scivolamento del muscolo, dovuto a una sutura superficiale o a un passaggio inadeguato nella sclera. In questo caso, è necessaria un'ulteriore esplorazione chirurgica per riposizionare il muscolo. La scelta dell'incisione congiuntivale (nel fornice o nel limbus) influenza sia l'aspetto estetico che la vascolarizzazione del segmento anteriore. Il follow-up postoperatorio prevede controlli clinici per monitorare la guarigione e apportare eventuali aggiustamenti.
