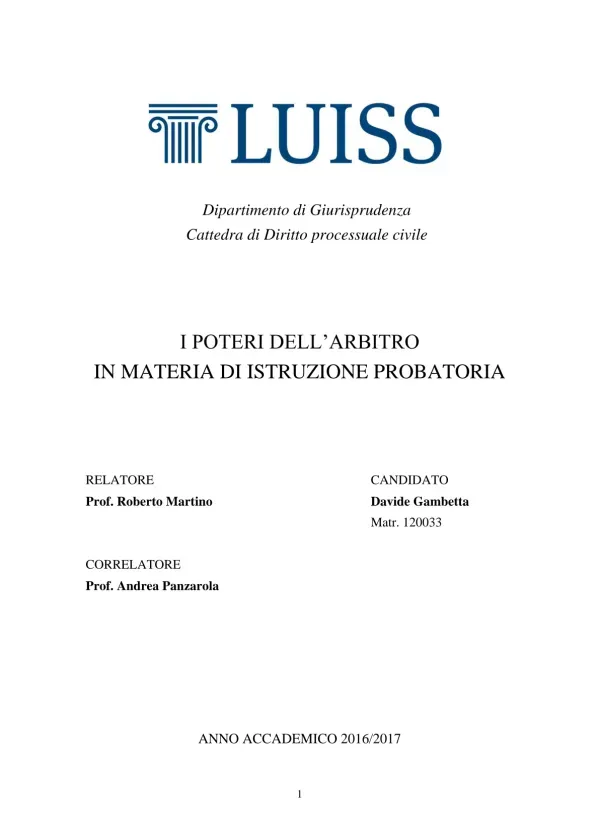
Poteri Arbitro: Istruzione Probatoria
Informazioni sul documento
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 1.43 MB |
Riassunto
I.La Disciplina Codicistica dell Arbitrato e le sue Riforme
Il documento analizza la disciplina codicistica dell’arbitrato in Italia, evidenziando le difficoltà di una normativa generale formulata con stile di “rinvio”. Le riforme del 1994 e del 2006 hanno ridisegnato alcuni profili del diritto dell’arbitrato, in particolare riguardo alla disponibilità dei diritti dedotti in controversia. La riforma del 2006 ha eliminato incertezze sull’ambito di estensibilità dell’arbitrato, subordinando la compromettibilità alla disponibilità del diritto. Opere importanti come quella di E.F. Ricci (1974) e studi più recenti di Capelli (2011), Punzi (2000), Motto e Bove (su www.judicium.it) contribuiscono al dibattito dottrinale.
1.1 Scarsa attenzione scientifica alla fase probatoria dell arbitrato
Il documento inizia osservando la relativa mancanza di studi approfonditi sulla fase di raccolta e valutazione delle prove nell'arbitrato, in contrasto con l'attenzione dedicata ad altri aspetti del procedimento. Si sottolinea come l'unica opera monografica di rilievo sull'argomento, quella di E.F. Ricci, risalga al 1974, evidenziando una lacuna nella letteratura specialistica. Questa carenza di analisi scientifica mette in luce la necessità di un approfondimento più sistematico delle dinamiche probatorie all'interno del processo arbitrale, soprattutto considerando l'importanza della fase di prova nella definizione della controversia. L'episodio citato, tratto dalla “Freshfield Lecture for 2002” del Professor W. W. Park, illustra come, già nel XVIII secolo, l'arbitrato fosse visto come un mezzo per evitare l'imposizione della legge e la spiacevole esperienza del giudizio davanti ad un magistrato. Questo aneddoto storico evidenzia la perenne attualità del ruolo dell'arbitrato come strumento alternativo alla giustizia ordinaria. La scelta codicistica di non disciplinare dettagliatamente l'arbitrato, pur nel suo indubbio pregio di lasciare spazio alla pratica, contribuisce a rendere ancora più complessa la comprensione e l'analisi del sistema probatorio.
1.2 Le riforme del diritto dell arbitrato e la disponibilità dei diritti
Le riforme del diritto dell’arbitrato, intervenute nel 1994 e nel 2006, hanno contribuito a ridisegnare alcuni profili cruciali del sistema. Particolare attenzione è dedicata al problema della ‘disponibilità dei diritti’, emerso con la riforma dell’arbitrato societario del 2003. Il legislatore aveva allora limitato la disciplina alle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, generando una certa complessità applicativa, soprattutto in contesti societari multiparti con numerosi soggetti e interessi potenzialmente conflittuali. Capelli (2011), nella sua opera “La disponibilità dei diritti nelle controversie societarie”, approfondisce questo tema. La successiva riforma del 2006 ha cercato di chiarire ulteriormente l'ambito di applicazione dell'arbitrato, eliminando norme puntuali ed esclusioni interpretative, subordinando la compromettibilità unicamente alla disponibilità del diritto in questione. Studi come quello di Punzi (2000), “Disegno sistematico dell’arbitrato”, e le analisi di Motto e Bove (www.judicium.it) offrono prospettive diverse sulla reale portata di questa riforma, evidenziando le diverse posizioni dottrinali e le sfumature interpretative che permangono nel dibattito accademico.
1.3 La natura privata dell arbitrato e il limite della compromettibilità
L'arbitrato, come fenomeno essenzialmente privato, mira principalmente alla composizione della lite, piuttosto che alla realizzazione di una giustizia etica in senso stretto. Questo aspetto, seppur interpretato diversamente in dottrina, influenza significativamente la disciplina del procedimento arbitrale. Il limite della compromettibilità, legato alla disponibilità del diritto dedotto, è un elemento fondamentale. Se il diritto in questione è indisponibile, la lite deve essere necessariamente devoluta alla giurisdizione statale. Al contrario, una controversia arbitrabile appartiene integralmente ai litiganti, i quali dovrebbero poter disporre liberamente anche sul piano procedimentale. La potestà normativa delle parti è, secondo alcuni, un riflesso processuale della compromettibilità sostanziale del diritto. La scelta legislativa di non disciplinare dettagliatamente l'arbitrato ha permesso una maggiore libertà delle parti e una deformalizzazione del procedimento, ma ha anche scoraggiato la sottoscrizione di convenzioni arbitrali a causa delle difficoltà interpretative. La difficoltà di ricostruire la prassi, dovuta alla scarsa reperibilità dei lodi arbitrali (a differenza delle sentenze), complica ulteriormente la comprensione e l'applicazione del diritto dell'arbitrato.
II.Il Potere Normativo di Parti e Arbitri nella Procedura Arbitrale
Un aspetto centrale è il potere normativo di parti e arbitri nella definizione delle regole procedurali. Il legislatore si limita a parametri generali, lasciando ampia discrezionalità. La dottrina dibatte sull’estensione di tale potere, con alcuni autori che ne limitano l’ambito a questioni procedurali contingenti (case by case), mentre altri riconoscono un potere più ampio, anche se sempre vincolato alla disponibilità del diritto e al principio del contraddittorio. La scarsa diffusione dei lodi arbitrali, a differenza delle sentenze, rende difficile ricostruire la prassi.
2.1 Il potere normativo delle parti e la sua natura riflessa
Il testo affronta il tema del potere normativo delle parti nel procedimento arbitrale, evidenziando la scarsità di indagini dottrinali approfondite sui suoi limiti. Il legislatore si è limitato a dettare parametri generali, suscitando talvolta reazioni negative. La scelta di una normativa laconica si spiega con la natura essenzialmente privata dell'arbitrato, il cui scopo principale è la composizione della lite, non la realizzazione di una giustizia etica. Questo aspetto è ulteriormente legato al limite della compromettibilità, vincolata alla disponibilità del diritto. La potestà normativa delle parti è vista come un riflesso processuale della compromettibilità sostanziale del diritto. La dottrina, pur non essendo unanime, tende a sostenere che il potere delle parti nella definizione delle regole procedurali è ampio, anche se non illimitato, e che tale potere è connesso alla disponibilità del diritto oggetto del contendere. Il legislatore ha preferito una disciplina essenziale per garantire la massima libertà delle parti e una deformalizzazione del processo. Tuttavia, questa scelta ha talvolta scoraggiato la sottoscrizione di convenzioni arbitrali, in quanto aumenta le difficoltà interpretative relative all'applicazione delle norme.
2.2 Il potere normativo degli arbitri un approccio case by case o una regolamentazione esauriente
La sezione analizza il potere degli arbitri di regolare la procedura, evidenziando la divergenza dottrinale sull'estensione di tale potere. Una parte della dottrina ritiene che il potere degli arbitri sia più ristretto rispetto a quello delle parti, limitandosi a risolvere le questioni procedurali che si presentano nel corso del procedimento (approccio case by case). Altri studiosi, invece, sostengono l'esistenza di un vero e proprio potere 'normativo' del collegio arbitrale, con diverse opinioni sulla sua estensione. Si discute se gli arbitri debbano definire un corpus normativo organico prima dell'inizio dell'arbitrato o se possano limitarsi a decidere caso per caso. Secondo alcuni, il silenzio delle parti e degli arbitri sulla disciplina procedimentale potrebbe portare a conseguenze estreme, come la nullità del lodo per violazione del contraddittorio. Altre voci dottrinali propongono un principio di conservazione dell'arbitrato, lasciando la procedura alla più ampia libertà delle forme in caso di silenzio delle parti. La questione del potere suppletorio degli arbitri, e dei suoi eventuali limiti temporali, viene anch'essa affrontata. Si ritiene che gli arbitri non siano vincolati a termini specifici, potendo esercitare il loro potere regolamentare durante tutto il corso del giudizio.
2.3 Il potere delle parti e degli arbitri in materia di forme processuali e sanzioni
L'analisi si concentra sul potere delle parti e degli arbitri di stabilire le forme processuali, in particolare quelle a pena di nullità. Il documento evidenzia come la normativa, all'articolo 829 numero 7, attribuisca alle parti il potere di stabilire forme a pena di nullità, mentre tale potere non è riconosciuto agli arbitri. Questa differenza sottolinea il maggiore controllo delle parti sulla struttura del processo arbitrale. Gli arbitri, pur potendo condurre il procedimento nel modo ritenuto più opportuno, non possono imporre sanzioni di nullità per violazioni formali. La ‘disponibilità’ delle forme processuali si riflette anche sul terreno dell’impugnazione, con le parti che possono influire sul principale mezzo di contestazione del lodo. La necessità di una previa eccezione in caso di violazione delle forme a pena di nullità viene analizzata, con interpretazioni diverse sull'estensione di tale requisito anche al caso di violazione del contraddittorio. Si approfondisce la distinzione tra vizi soggettivi (mancanza di citazione) e formali (violazione delle regole procedurali), ricollegando tale distinzione alla dicotomia tra contraddittorio ‘statico’ e ‘dinamico’. La dottrina evidenzia l'importanza del rispetto del contraddittorio nella formazione della prova, criticando le possibili deroghe tramite accordi tra le parti.
III.Nullità del Lodo e Violazione del Contraddittorio
Il documento approfondisce le cause di nullità del lodo, in particolare quelle relative alla violazione del contraddittorio. L'articolo 829 c.p.c. è analizzato nel dettaglio, distinguendo tra violazioni formali (a pena di nullità, determinate dalle parti) e violazioni del contraddittorio in senso dinamico (parità delle armi). Marinucci (2009) distingue tra contraddittorio “statico” (partecipazione al procedimento) e “dinamico” (parità di trattamento). L'articolo 829, comma 9, è chiave per le impugnazioni relative alla violazione del contraddittorio, ma richiede una attenta analisi interpretativa.
3.1 L articolo 829 c.p.c. e le cause di nullità del lodo
La sezione si concentra sulle cause di nullità del lodo arbitrale, analizzando in particolare l'articolo 829 del codice di procedura civile. L'articolo 829, in particolare il suo nono comma, è fondamentale per comprendere le possibili impugnazioni del lodo. Il testo evidenzia come la norma raggruppi diverse tipologie di nullità formali sotto una categoria astratta, sfumando le distinzioni basate sull'origine (nullità testuali per legge o per inidoneità allo scopo) e sulla rimediabilità (sanabilità/insanabilità). L'analisi si sofferma sull'importanza dell'interpretazione delle parole utilizzate dal legislatore: la nullità, per essere rilevante, deve essere posta dalle parti, non dagli arbitri. Questo significa che gli arbitri non hanno lo stesso potere delle parti di prescrivere obblighi formali a pena di nullità. Le parti, ad esempio, potrebbero concordare nell'accordo arbitrale che i testimoni siano escussi oralmente (escludendo l'affidavit), mentre gli arbitri, pur potendo condurre il procedimento nel modo ritenuto più opportuno, non possono imporre tale forma a pena di nullità. Questo speciale motivo di nullità sembra volto a rafforzare il dominio delle parti sulla struttura del processo arbitrale, fornendo loro uno strumento aggiuntivo per ‘blindare’ le proprie determinazioni.
3.2 Il contraddittorio interpretazione di Marinucci e distinzione tra contraddittorio statico e dinamico
Il documento introduce la distinzione, proposta da Marinucci (2009), tra contraddittorio ‘statico’ e ‘dinamico’. Il contraddittorio statico si verifica con la regolare notificazione della domanda e la partecipazione della controparte alla fase dibattimentale; la sua violazione è rappresentata dalla totale assenza di una parte, che comporta la chiusura in rito del procedimento. Il contraddittorio dinamico, invece, riguarda il modo in cui il processo arbitrale si svolge, garantendo la parità di trattamento delle parti e l’eguaglianza delle armi. La violazione del contraddittorio in senso dinamico è, dunque, molto più complessa e riguarda l'alterazione del principio di parità delle armi, come nel caso in cui una parte sia privata della possibilità di controbattere. Prima della riforma del 2006, mancava una norma specifica che applicasse una sanzione per la violazione dell’ordine pubblico processuale in generale. La dottrina aveva tentato di colmare questa lacuna interpretando le norme esistenti in modo non sempre coerente. La riforma del 2006 ha risolto il problema, inserendo un inciso nell’art. 829, che ora punisce la violazione della parità delle armi.
3.3 Violazione del contraddittorio e impugnazione del lodo la necessità della previa eccezione e la sent. 5498 2001
L'analisi prosegue sull’impugnazione del lodo in caso di violazione del contraddittorio. Si discute della necessità di una previa eccezione, estendendo interpretativamente il requisito previsto per le violazioni di forme a pena di nullità anche alla violazione del contraddittorio. Il testo sottolinea la mancanza di una certezza assoluta nel dato testuale. Si distinguono due categorie di vizi riconducibili alla violazione del contraddittorio: vizi soggettivi (mancata citazione) e vizi formali (violazione delle regole procedurali). Si ribadisce l’importanza del contraddittorio nella formazione della prova, soprattutto per le prove costituende. Si ricorda la sentenza 5498 del 12 aprile 2001, che afferma il diritto delle parti di svolgere le proprie difese conclusive in relazione all’istruttoria compiuta. Questo diritto di controvertere verbalmente (o per iscritto) sulle risultanze probatorie è considerato irrinunciabile. Si evidenzia che una istruttoria segreta, in assenza delle parti, è palesemente nulla (artt. 202-209 c.p.c.). Anche in arbitrato, quindi, il rispetto del contraddittorio è fondamentale e inderogabile, anche se in passato vi erano dubbi sulla possibilità di rinunciarvi.
IV.Il Principio di Disponibilità della Prova e i Poteri Istruttori dell Arbitro
Si analizza il principio di disponibilità della prova in arbitrato, confrontando l’approccio italiano con quello di altri ordinamenti (Francia, Germania, Inghilterra, Brasile). Il dibattito verte sui poteri istruttori dell’arbitro: alcuni autori sostengono ampi poteri officiosi, mentre altri li limitano, evidenziando il ruolo del contraddittorio e dell’onus probandi. L'articolo 816 ter c.p.c. è citato come esempio di possibile potere officioso (consulenza tecnica). La coercibilità dei provvedimenti arbitrali in materia di prova è limitata, soprattutto per quanto riguarda l’intervento del giudice statale, ma l’articolo analizza le diverse soluzioni adottate in diversi ordinamenti giuridici.
4.1 Il principio di disponibilità della prova e i poteri dell arbitro un confronto tra ordinamenti
La sezione analizza il principio di disponibilità della prova nell'arbitrato, confrontandolo con il sistema del processo civile ordinario e con quello di altri ordinamenti giuridici. Si evidenzia come la dottrina presenti opinioni divergenti sui poteri istruttori dell'arbitro: alcuni autori sostengono un ampio potere officioso, mentre altri lo limitano, facendo riferimento al principio di disponibilità della prova e al rispetto del contraddittorio. L'applicazione dell'articolo 115 c.p.c., che disciplina la disponibilità della prova nel processo civile, non è automatica in arbitrato, e questo elemento influenza l'estensione dei poteri officiosi dell'arbitro. Il confronto con sistemi di matrice anglosassone, caratterizzati dall'adversary system, evidenzia un'evoluzione verso un ruolo più attivo del giudice nella gestione della procedura, anche nell'ambito dell'arbitrato. Negli Stati Uniti, ad esempio, il nuovo paragrafo settimo del capitolo primo del titolo dedicato all'arbitrato nell'U.S. Code riconosce agli arbitri un potere di convocazione piuttosto ampio. L'ordinamento francese è caratterizzato dal combinato disposto tra il principio di disponibilità della prova e il criterio dell'onere della prova (actori incumbit probatio), che limita i casi in cui le prove sono evocabili d'ufficio. Anche l'ordinamento tedesco, pur avendo recepito la Legge Modello Uncitral, mantiene un'analoga attenzione al contraddittorio, ma senza specifici riferimenti sull'estensione dei poteri officiosi.
4.2 Il potere officioso dell arbitro esempi in ordinamenti stranieri e confronto con il sistema italiano
L'analisi prosegue esaminando il potere officioso dell'arbitro in diversi ordinamenti. In Spagna, l'articolo 32 della legge sull'arbitrato specifica espressamente che la consulenza tecnica può essere disposta anche d'ufficio, a differenza del sistema italiano, dove tale potere è oggetto di dibattito dottrinale. Il silenzio normativo italiano, seguito da una dottrina cauta, contrasta con l'ampio potere officioso riconosciuto ad esempio nel sistema francese. L'articolo 816 ter c.p.c. sembra riconoscere un potere officioso all'arbitro in alcuni casi specifici (consulenza tecnica, richiesta di informazioni alla P.A., testimonianza), ma l'Italia tende a privilegiare la linea tedesca e spagnola, lasciando alle parti il compito di determinare se e quali poteri concedere all'arbitro. La scelta di regolamenti arbitrali precostituiti spesso sopperisce alla mancanza di una disciplina specifica. Il documento evidenzia anche dubbi sull'estensione della delega dell'arbitro in merito all'ammissibilità delle prove, in particolare riguardo alla possibilità di delegare l'intera fase istruttoria ad un singolo arbitro, o solo singoli atti. La nuova formulazione dell'art. 816 bis ha chiarito l'estensione della delega, ma non ha completamente eliminato i dubbi sulla possibilità di una delega in toto. La possibilità di delegare alcune funzioni al Presidente del collegio arbitrale è infine analizzata.
4.3 Coercibilità dei provvedimenti arbitrali e assistenza giudiziaria il caso della testimonianza
La sezione affronta il problema della coercibilità dei provvedimenti arbitrali in materia di prova. Si osserva che, pur in presenza di un jus imperii limitato, in molti casi si raggiunge un livello probatorio soddisfacente in arbitrato, grazie alla collaborazione delle parti. Il problema principale si pone con i mezzi di prova che coinvolgono terzi. Anche nel processo ordinario non tutte le richieste ai terzi sono coercibili (es. ordine di ispezione). L'assistenza giudiziaria, quindi, è principalmente necessaria per ottenere la collaborazione di terzi recalcitranti. Il sistema italiano, che prevede l'assistenza giudiziaria solo per la testimonianza, viene confrontato con altri sistemi, ad esempio quello brasiliano, che presenta una modalità simile. Nel sistema brasiliano, l’assistenza giudiziaria può essere richiesta per costringere un testimone a comparire, previa convocazione da parte dell'arbitro. Si discute la possibilità di ricorrere all'assistenza giudiziaria anche in assenza di un precedente comportamento recalcitrante del testimone, con una tesi minoritaria che la considera sempre ammissibile. Le conseguenze di una mancata collaborazione del testimone sono diverse a seconda degli ordinamenti, e nel processo ordinario possono prevedere sanzioni più severe, come multe e accompagnamento coattivo. L'arbitro, in caso di mancata collaborazione, potrebbe utilizzare come elemento probatorio la mancata collaborazione della parte. Infine, viene escluso l’uso della rogatoria internazionale in arbitrato, a causa degli elevati costi e tempi che comporterebbe.
V.Onere della Prova Non Contestazione e Valutazione Giudiziale della Prova in Arbitrato
Il documento esamina il ruolo dell’onere della prova e della non contestazione nell’arbitrato. La riforma del 2009 ha chiarito l’efficacia della non contestazione come elemento rilevante per la decisione. Si discute se in arbitrato esista il concetto di “prova legale”, e si approfondisce la valutazione giudiziale della prova da parte dell’arbitro, sottolineando che l’impugnazione del lodo è limitata e difficilmente può riguardare errori di fatto (“errores in iudicando de facto”). Il documento confronta questo aspetto con il processo ordinario, dove l’appello permette un controllo più ampio.
5.1 L onere della prova e il suo ruolo nella decisione
Questa sezione analizza il principio dell’onere della prova (onus probandi) nel contesto dell’arbitrato, evidenziando il suo ruolo fondamentale nel momento decisionale. Dopo la valutazione delle prove acquisite, possono sussistere dubbi sull’esistenza di determinati fatti giuridici; in questi casi, il criterio dell’onus probandi interviene per stabilire quale parte ha l’onere di fornire le prove a sostegno delle proprie affermazioni. Chi propone una situazione giuridica deve provare i fatti costitutivi, mentre chi contesta la pretesa deve fornire controprove o prove di fatti estintivi o modificativi. L'articolo 1697 c.c. è citato come riferimento normativo per questo principio. Il problema principale nell’arbitrato riguarda la convivenza tra l’onus probandi e l’eventuale iniziativa officiosa dell’arbitro. Se si ammette un ampio potere officioso dell’arbitro nella ricerca e acquisizione delle prove, la convivenza con il principio dell’onere della prova potrebbe risultare difficile, poiché l’arbitro potrebbe intervenire ex officio per risolvere dubbi probatori, andando a sostituirsi, in parte, alle parti. Una prospettiva alternativa limita l’iniziativa officiosa dell’arbitro a fatti secondari o non direttamente connessi con la domanda, al fine di preservare il principio del contraddittorio e l’eguaglianza delle parti.
5.2 La non contestazione come elemento probatorio la riforma del 2009
La sezione discute il principio della “non contestazione” dei fatti, strettamente legato all’onere della prova. Prima della riforma del 2009, l’applicazione di questo principio era limitata a casi specifici (riconoscimento tacito della scrittura privata, ficta confessio). La riforma ha chiarito che il giudice deve basare la decisione sulle prove proposte dalle parti e sui fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. La non contestazione, pur non essendo una prova in senso stretto, può essere considerata un elemento rilevante ai fini della decisione, aiutando a sostenere il procedimento motivazionale della sentenza. La giurisprudenza specifica che il fatto non contestato, pur non essendo provato, non necessita di ulteriore prova. Si evidenzia che questo principio, presente nel Libro primo del Codice, potrebbe essere considerato parte dell’ordine pubblico processuale, e quindi applicabile anche in arbitrato. In questo contesto, il principio del contraddittorio richiede comunque agli arbitri di garantire elevati standard di garanzia del diritto di contraddire e controargomentare. Si discute quindi la possibilità di contestazione in qualsiasi momento, o in finestre temporali specifiche definite dagli arbitri, sottolineando che la tempestività della contestazione potrebbe dipendere dal rispetto del principio della parità delle armi e dall’obiettivo di snellire la procedura.
5.3 Valutazione giudiziale della prova in arbitrato e limiti all impugnazione
Il testo approfondisce la valutazione giudiziale delle prove da parte dell’arbitro, sottolineando la particolare attenzione rivolta a questo aspetto in arbitrato, dove l'azione di nullità è limitata ai casi specificamente previsti dall’articolo 829. L’arbitro, come il giudice statale, può valutare le prove con prudente apprezzamento, ma deve giustificare la sua decisione secondo criteri di razionalità e ragionevolezza. L’impugnazione del lodo raramente può riguardare errori di fatto nell’accertamento degli eventi, come afferma Luiso, limitandosi ad eventuali violazioni del contraddittorio. Questo limita il controllo sull’operato dell’arbitro in sede di impugnazione, differenziando radicalmente l’arbitrato dal giudizio di cognizione ordinario, che permette un controllo più ampio in appello. In arbitrato, quindi, il giudizio sul fatto è sostanzialmente in unico grado. Anche se la prova è stata acquisita nel contraddittorio, qualunque sia la valutazione dell'arbitro, le parti dovranno accettarla, salvo che il vizio possa essere fatto valere sotto un altro motivo di nullità previsto dall’articolo 829, come nel caso di disposizioni contraddittorie nel lodo. L'irrazionalità del ragionamento dell'arbitro, senza una specifica violazione del contraddittorio, non dà luogo ad una diretta conseguenza impugnatoria.
VI.Testimonianza della Parte e Consulenza Tecnica
Il documento tocca brevemente il tema della testimonianza della parte, rimandando ad approfondimenti successivi. L’obbligo di disporre la consulenza tecnica in arbitrato viene analizzato, con la dottrina prevalente che lo considera facoltativo e discrezionale per gli arbitri, in base ad una valutazione caso per caso. Il confronto con il processo ordinario, dove l’articolo 61 c.p.c. regola la consulenza tecnica, viene utilizzato per comprendere meglio la natura discrezionale di tale potere in ambito arbitrale.
6.1 L interrogatorio libero delle parti e gli argomenti di prova
La sezione inizia con una breve analisi dell'interrogatorio libero delle parti nel processo ordinario (art. 117 c.p.c.), evidenziando che questo istituto, pur non producendo prove in senso stretto, permette di ricavare 'argomenti di prova' dal contegno complessivo delle parti in risposta alle domande del giudice. L'interrogatorio, quindi, è considerato un mezzo istruttorio in senso lato. Il documento non approfondisce l’applicazione di questo istituto in arbitrato, ma pone le basi per una successiva analisi comparativa tra processo ordinario e arbitrato. L'articolo evidenzia la necessità di un'analisi approfondita della possibilità, o meno, per gli arbitri di disporre l'interrogatorio libero delle parti nel contesto del procedimento arbitrale, considerando le differenze tra il processo ordinario e la flessibilità propria dell'arbitrato. La trattazione è propedeutica ad un'analisi più dettagliata sui mezzi di prova e sull'estensione dei poteri dell'arbitro.
6.2 L obbligo o la facoltà di disporre la consulenza tecnica
La sezione si concentra sulla consulenza tecnica in arbitrato, analizzando se esista un obbligo per gli arbitri di disporla. Una parte della dottrina ritiene che il ricorso alla consulenza tecnica sia una facoltà discrezionale dell’arbitro, dipendente dalla necessità di integrare il proprio patrimonio di conoscenze per poter decidere serenamente. Questa posizione si basa sul dato normativo: l’articolo 61 c.p.c. (per il processo civile) e l’articolo 816 ter (per l’arbitrato) utilizzano una terminologia permissiva (“quando è necessario, il giudice può farsi assistere”). La dottrina sottolinea che, se il collegio arbitrale ritiene di poter decidere senza l’ausilio di un esperto, la consulenza tecnica non è obbligatoria. L'analisi si concentra sul bilanciamento tra l'esigenza di una decisione fondata su conoscenze specialistiche e la necessità di contenere i costi e i tempi del procedimento arbitrale. La decisione di ricorrere o meno a una consulenza tecnica è, quindi, presentata come un atto discrezionale dell'arbitro, strettamente connesso alla complessità della controversia e alle competenze del collegio.
VII.Confessione e Istruzione Probatoria nell Arbitrato
L'efficacia probatoria della confessione in arbitrato è discussa, con opinioni divergenti sulla sua libera valutabilità. Il documento conclude sottolineando la possibilità per le parti di ridisegnare l’istruzione probatoria, e il rischio di mutuare eccessivamente la struttura del processo ordinario nell’arbitrato, perdendo la sua flessibilità. La coercibilità dei provvedimenti arbitrali in materia di prova è infine valutata, evidenziando le limitazioni ma anche la spesso sufficiente collaborazione delle parti e dei terzi.
Riferimento del documento
- Querela di falso: la Cassazione conferma l’assoluta autonomia del procedimento (Chito’)
