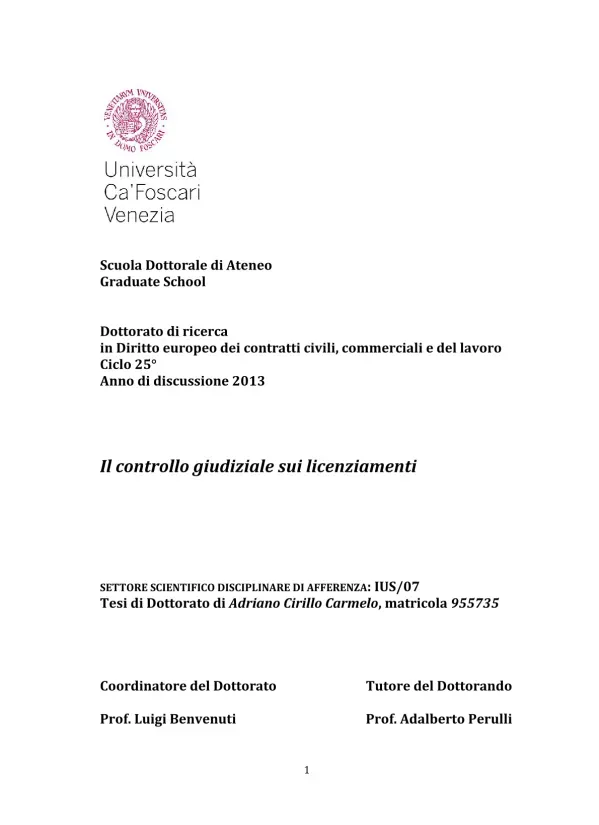
Controllo Giudiziale Licenziamenti
Informazioni sul documento
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 2.80 MB |
Riassunto
I.Il Licenziamento nel Diritto Italiano Giusta Causa e Giustificato Motivo
Questo documento analizza il complesso tema del licenziamento nel diritto del lavoro italiano, focalizzandosi sui requisiti di giusta causa e giustificato motivo (sia soggettivo che oggettivo). Si evidenzia l'ampia discrezionalità del giudice nell'interpretazione delle norme, influenzata da fattori sociali ed economici, e il ruolo della giurisprudenza nella definizione di questi concetti. L'analisi considera l'impatto della Riforma Fornero sull'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, introducendo nuove sanzioni e modificando le procedure. Si esamina il rapporto tra ius e lex, e l'influenza di principi costituzionali, come la responsabilità sociale d'impresa, nella valutazione dei licenziamenti. La Corte di Cassazione e le sue decisioni in materia sono costantemente richiamate.
1. La Discrezionalità del Giudice nei Licenziamenti
Il testo introduce il tema della discrezionalità giudiziaria nei casi di licenziamento, sottolineando come questa sia forse maggiore rispetto ad altri ambiti del diritto civile o del diritto del lavoro. Il giudice, nel valutare la giusta causa o il giustificato motivo (sia soggettivo che oggettivo), deve soppesare le ragioni a favore e contro il licenziamento, prendendo una decisione che può essere influenzata da diversi fattori. Questi vanno dall'orientamento generale della sezione del giudice ai suoi giudizi di valore personali, fino alla situazione economica del mercato del lavoro. L'ampiezza del testo normativo concede un ampio margine interpretativo al magistrato, riflettendo la sua formazione culturale nella individuazione della regola applicabile. Si cita a titolo esemplificativo la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, del 10 gennaio 2006, n. 141, a conferma della complessità delle valutazioni giudiziali in materia di licenziamento. La discrezionalità del giudice è un elemento chiave nell’analisi, con la sua formazione culturale che incide significativamente sull'applicazione delle norme.
2. Il Dualismo del Diritto Ius e Lex
Questa sezione introduce il dualismo tra ius e lex, come concetti chiave per comprendere la complessità del diritto applicato ai licenziamenti. Zagrebelsky, citato nel documento, evidenzia la difficoltà, per la generazione di giuristi formata nel positivismo giuridico, di cogliere questa distinzione fondamentale, tra diritto come sostanza (ius) e diritto come forma (lex). Si fa riferimento alla celebre opera di Sofocle, Antigone, per illustrare il conflitto tra una legge scritta (lex), rappresentata da Creonte, e un diritto non scritto, basato su principi morali e consuetudini (ius), incarnato da Antigone. La distinzione tra lex (legge come comando sovrano) e ius (diritto come sostanza radicata nell'esperienza) è ulteriormente approfondita citando Jean Bodin, precursore del monismo della legge, evidenziando come entrambe le forme di diritto siano vincolanti, ma con diversa origine e fondamento. Il dualismo ius/lex rappresenta quindi un elemento fondamentale per interpretare le decisioni giudiziarie in materia di licenziamento, mostrando come il diritto non si riduca alla sola legge scritta ma includa principi e valori che trascendono la lex.
3. La Discrezionalità del Giudice e la Creazione Giurisprudenziale
Il documento approfondisce la questione della discrezionalità del giudice, analizzando la tesi di Kelsen e Hart, secondo cui il giudice, nell'ambito del positivismo critico, esercita una discrezionalità nella creazione di nuove norme giuridiche, nello spazio lasciato vuoto dalle leggi positive. Questa prospettiva si contrappone alla dottrina dei principi, che afferma l'esistenza di un diritto non solo positivo ma anche basato su principi giuridici preesistenti alle norme del legislatore. Questi principi, secondo questa prospettiva, guidano e circoscrivono le decisioni giudiziarie, limitando la discrezionalità del giudice. L'analisi evidenzia il ruolo creativo della giurisprudenza, dipendente dal linguaggio utilizzato, e il modo in cui il giudice, anche in assenza di norme specifiche, deve decidere secondo un apprezzamento personale del caso concreto e delle conseguenze sociali della decisione, nel rispetto dei valori costituzionali. Si delinea la tensione tra la soluzione del caso concreto da parte del giudice e la legislazione generale ed astratta.
4. Responsabilità Sociale d Impresa e Tutela del Lavoratore
Questa sezione introduce il tema della responsabilità sociale d'impresa e il suo impatto sulla tutela dei lavoratori nel contesto dei licenziamenti. Il documento cita l'articolo 41 della Costituzione italiana, che limita l'attività d'impresa all'utilità sociale, e altri articoli che riconoscono diritti dei lavoratori alla collaborazione nella gestione aziendale e al principio di sussidiarietà. Si discute la possibilità di integrare la soft law dei codici etici con l'hard law del contratto a favore di terzi (art. 1372 c.c.) per rafforzare la responsabilità sociale delle imprese e la tutela dei lavoratori in caso di licenziamento. Si evidenzia la necessità di un cambio di paradigma, dove il profitto non sia l'unico obiettivo aziendale, ma si tenga conto delle persone e dell'ambiente. L’analisi si concentra sulla possibilità che principi di responsabilità sociale, presenti nella Costituzione e nel diritto europeo, possano essere utilizzati dai giudici per risolvere problematiche in tema di tutela dei lavoratori in caso di licenziamento.
II.La Legge 604 1966 e l Introduzione del Principio di Giustificazione
La Legge n. 604 del 1966 ha introdotto il principio fondamentale della giustificazione oggettiva del potere di recesso del datore di lavoro, dichiarando illegittimi i licenziamenti privi di giusta causa o giustificato motivo. La legge definisce le due tipologie di giustificato motivo e rinvia all'articolo 2119 del Codice Civile per la definizione di giusta causa. Questo ha segnato un passaggio fondamentale nel diritto del lavoro, limitando la precedente insindacabilità del licenziamento prevista dal Codice Civile.
1. La Legge n. 604 1966 Un Caposaldo del Diritto del Lavoro
La sezione si concentra sulla Legge n. 604 del 15 luglio 1966, un punto di svolta nella regolamentazione dei licenziamenti individuali in Italia. Prima di questa legge, il Codice Civile lasciava sostanzialmente insindacabile il potere di recesso del datore di lavoro, svincolato da oneri causali. La Legge 604/66, invece, ha introdotto il principio cardine della giustificazione oggettiva del licenziamento, dichiarando illegittimo ogni recesso non sorretto da 'giusta causa' o 'giustificato motivo'. Questo ha rappresentato un significativo cambiamento, introducendo un controllo giuridico sul potere datoriale precedentemente pressoché illimitato. L'articolo 2119 del Codice Civile è stato richiamato per definire la 'giusta causa', mentre la legge stessa ha introdotto le definizioni di 'giustificato motivo', sia soggettivo che oggettivo. La legge ha dunque spostato l'asse del giudizio sul licenziamento dalla mera concessione del preavviso (o della relativa indennità sostitutiva) all'accertamento della legittimità o meno del licenziamento stesso, in base alla presenza o assenza di giusta causa o giustificato motivo. La resistenza iniziale da parte delle organizzazioni datoriali e della CISL, contrarie a interventi legislativi in ambiti ritenuti di competenza dell'autonomia collettiva, evidenzia l'importanza e il carattere innovativo di questa legislazione.
2. Giusta Causa e Giustificato Motivo Definizioni e Interpretazioni
La sezione prosegue analizzando le definizioni di 'giusta causa' e 'giustificato motivo', come introdotte dalla Legge 604/66 e interpretate dalla giurisprudenza. Il documento evidenzia la complessità di questi concetti e la necessità di una valutazione caso per caso, andando oltre una semplice valutazione astratta. Per la sussistenza della giusta causa, non basta una valutazione in astratto, ma occorre considerare la natura del rapporto, la posizione delle parti, le mansioni, il grado di fiducia e l’intensità dell’elemento intenzionale e colposo. Si applica un criterio di sussidiarietà: il recesso per giusta causa è legittimato solo se il licenziamento per giustificato motivo soggettivo o sanzioni disciplinari minori risultano inadeguate. La valutazione della gravità delle infrazioni è quindi fondamentale. Inoltre, si discute la rilevanza di comportamenti del lavoratore estranei alla sfera strettamente contrattuale, sottolineando che questi assumono rilevanza solo se incidono sulla probabilità di un esatto adempimento futuro delle obbligazioni lavorative, senza ledere la sfera personale del lavoratore, come previsto dall'art. 8 dello Statuto dei Lavoratori. L'interpretazione delle norme sulla giusta causa e il giustificato motivo, quindi, richiede una valutazione complessiva e concreta delle singole situazioni.
III.La Riforma Fornero e le sue Conseguenze sui Requisiti Procedurali
La riforma Fornero ha modificato l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, introducendo nuovi obblighi procedurali per i licenziamenti nelle imprese con più di 15 dipendenti. Tra le novità, l'obbligo di motivazione contestuale del licenziamento e l'abbreviazione dei termini per il ricorso giudiziario. La riforma si concentra principalmente sulle sanzioni applicabili in caso di licenziamento illegittimo, lasciando inalterato il principio di giustificazione ma modificando i rimedi. L'interpretazione del comma 6 dell'articolo 18, in relazione alla violazione di clausole dei contratti collettivi, rimane oggetto di dibattito.
1. La Riforma Fornero e l articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori
La sezione analizza gli effetti della riforma Fornero sull'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, focalizzandosi sulle modifiche ai requisiti procedurali dei licenziamenti. La riforma introduce l'obbligo di motivazione contestuale del licenziamento, specificando i motivi nella comunicazione stessa, a differenza del precedente meccanismo della Legge 604/66 che consentiva la presentazione dei motivi in un secondo momento. Un'altra modifica significativa è la riduzione dei termini per il deposito del ricorso al giudice dopo l'impugnazione stragiudiziale, da 270 a 180 giorni. L'intervento della riforma, tuttavia, si concentra principalmente sulle conseguenze sanzionatorie in caso di licenziamento illegittimo, limitandosi alle imprese con più di 15 dipendenti in una singola unità produttiva o nello stesso comune, o comunque complessivamente più di 60 dipendenti a livello nazionale. Si evidenzia il cambiamento nell'intestazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, a sottolineare la portata della riforma. L'analisi si concentra quindi sulle modifiche procedurali e sulle loro implicazioni per il lavoratore e il datore di lavoro.
2. Licenziamento Disciplinare e Contratti Collettivi Interpretazione del Comma 6 dell articolo 18
Un punto cruciale dell'analisi riguarda l'interpretazione del nuovo comma 6 dell'articolo 18 in relazione al licenziamento disciplinare intimato dopo la scadenza del termine previsto dal contratto collettivo. La norma prevede una sanzione specifica per licenziamenti inefficaci a causa di violazioni della procedura dell'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori. Tuttavia, non considera espressamente la violazione di disposizioni contrattuali collettive, che possono prevedere termini specifici per l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Si pone quindi il problema di un'eventuale interpretazione estensiva o analogica della norma, o dell'inquadramento della fattispecie tra le 'altre ipotesi' menzionate nel comma 6. L'ambiguità della norma genera incertezza interpretativa e solleva il quesito se sia più grave violare una disposizione del contratto collettivo o una norma di legge, aprendo la strada a diversi possibili approcci interpretativi da parte dei giudici.
3. Il Ruolo del Giudice e le Sanzioni per Licenziamento Illegittimo
La sezione descrive le conseguenze sanzionatorie previste in caso di accertamento di licenziamento illegittimo. Si evidenzia che la riforma Fornero concentra l'intervento sulle conseguenze sanzionatorie. Se il giudice rileva l'illegittimità del licenziamento per mancanza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dichiara risolto il rapporto con effetto alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva (tra 12 e 24 mensilità), tenendo conto dell'anzianità del lavoratore e delle condizioni delle parti. Il rapporto di lavoro non viene ricostituito, a differenza di quanto accadeva in alcune situazioni precedenti. L’indennità risarcitoria è definita “omnicomprensiva” a copertura di tutti i danni subiti dal lavoratore, escludendo ulteriori pretese risarcitorie. La determinazione dell’indennità tiene conto anche del comportamento e delle condizioni delle parti, evidenziando quindi la valutazione discrezionale del giudice anche nella quantificazione del risarcimento.
IV.Il Ruolo dei Contratti Collettivi e l Interpretazione Giudiziale
Il documento analizza il peso dei contratti collettivi nella definizione di giusta causa e giustificato motivo. Si sottolinea come, nonostante la rilevanza delle tipizzazioni contenute nei contratti collettivi, la valutazione finale spetti sempre al giudice, il quale deve verificare la veridicità e la gravità dei fatti contestati, tenendo conto dei principi generali del diritto del lavoro e della coscienza sociale. La legge 183/2010 ha rafforzato questo ruolo del giudice, ma anche limitato l’insindacabilità delle scelte imprenditoriali, creando comunque un ambito di discrezionalità giudiziale.
1. Contratti Collettivi e Definizione di Giusta Causa e Giustificato Motivo
La sezione analizza il ruolo dei contratti collettivi nel definire la giusta causa e il giustificato motivo per il licenziamento. Si evidenzia che, mentre i contratti collettivi possono specificare ipotesi di giusta causa e giustificato motivo, l'orientamento giurisprudenziale più recente afferma che essi non possono sostituirsi alla legge, in quanto le fattispecie legali già assolvono alla funzione di preventiva pubblicità. Si critica l'utilizzo di formule vaghe come "regole fondamentali del vivere civile" o "doveri fondamentali", sottolineando come queste creino incertezza e non siano coerenti con lo sforzo contrattualistico della dottrina giuslavoristica. Il potere disciplinare, infatti, deve sanzionare il mancato rispetto degli obblighi contrattuali e non la violazione di doveri extracontrattuali, che non dovrebbero essere riformulati nel codice disciplinare. Nonostante l'esistenza di tipizzazioni nei contratti collettivi, la valutazione finale spetta al giudice, che deve verificare la reale entità e gravità della mancanza, anche in presenza di clausole contrattuali che definiscono a priori una determinata condotta come giusta causa. Il giudice quindi mantiene la sovranità nella valutazione, pur tenendo conto degli accordi collettivi.
2. Il Controllo Giudiziale e gli Standard Valutativi
Il documento approfondisce il ruolo del giudice nel controllare la legittimità di un licenziamento, anche in relazione alle disposizioni dei contratti collettivi. Si afferma che il giudice di merito, pur dovendo considerare le tipizzazioni contrattuali, non è vincolato da esse se queste contrastano con la nozione legale di giusta causa o giustificato motivo. Il giudice deve attenersi ad ulteriori standard valutativi, rinvenibili nella specifica disciplina del rapporto di lavoro (anche di fonte negoziale), nei principi giuridici puntualizzati dalla giurisprudenza di legittimità e nella coscienza sociale. Un accordo che prevede solo sanzioni conservative o il licenziamento solo in presenza di circostanze specifiche vincola il giudice solo se coerente con la nozione legale di giusta causa o giustificato motivo. Si evidenzia come il legislatore deleghi al giudice una scelta assiologica, con giudizi di valore in sede applicativa, confermando il ruolo fondamentale del magistrato nell'interpretazione e applicazione delle norme, anche in presenza di accordi collettivi.
3. Legge 183 2010 e Tipizzazioni di Giusta Causa e Giustificato Motivo
La sezione discute l'impatto della legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 30, III comma), che ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui il giudice, nel valutare le motivazioni del licenziamento, deve tenere conto delle tipizzazioni di giusta causa e giustificato motivo presenti nei contratti collettivi stipulati dai sindacati più rappresentativi. Questa norma, pur consolidando un orientamento giurisprudenziale preesistente, non ha portato innovazioni sostanziali, mantenendo un approccio meramente orientativo e non vincolante per il giudice. Si evidenzia la critica di Tiraboschi, secondo cui il giudice dovrebbe poter considerare anche i patti individuali tra le parti. L'articolo 30, comma III, della legge 183/2010, pur prevedendo il controllo sulla veridicità delle ragioni addotte dal datore di lavoro, esclude la valutazione della 'bonitas' delle scelte imprenditoriali, rimesse al titolare del potere di impresa. Si sottolinea come la determinazione a priori di ipotesi di giusta causa da parte delle parti possa prevenire lunghi contenziosi.
V.Il Giustificato Motivo Oggettivo e il Controllo Giudiziale
Il giustificato motivo oggettivo, relativo all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, è analizzato in relazione al bilanciamento tra l'interesse del lavoratore alla stabilità dell'impiego e quello dell'impresa. Si evidenzia come non tutte le ragioni economiche siano valide per giustificare un licenziamento, e come il giudice applichi criteri di razionalità e proporzionalità nella valutazione. Il principio di insindacabilità delle scelte imprenditoriali, garantito dall'articolo 41 della Costituzione italiana, viene esaminato nel suo rapporto con il controllo giudiziale.
1. Il Giustificato Motivo Oggettivo Definizione e Principio di Razionalità Proporzionalità
La sezione si concentra sul giustificato motivo oggettivo di licenziamento, come previsto dall'articolo 3 della Legge n. 604/66. Questo giustificato motivo oggettivo include le ragioni relative all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento. L'analisi evidenzia come queste nozioni, di per sé neutre, prendano corpo e senso sotto l'azione del principio di razionalità/proporzionalità. Il licenziamento viene vagliato non solo in base all'adeguatezza dei mezzi rispetto ai fini (razionalità strumentale), ma anche in base alla necessità e alla ponderazione degli interessi in gioco (razionalità assiologica). Il giudice, quindi, seleziona le ragioni economiche ammissibili a far retrocedere il diritto alla stabilità dell'impiego, riconoscendo che non tutte le ragioni economiche sono valide per giustificare un licenziamento. Per esempio, in Italia e in Francia, i giudici ritengono che un mero risparmio di costi non sia sufficiente a giustificare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il principio di razionalità/proporzionalità è quindi fondamentale per il controllo giudiziale del licenziamento economico.
2. Il Controllo Giudiziale in Francia Cause Réelle et Sérieuse
Il testo introduce il sistema francese per il controllo del licenziamento economico, confrontandolo con quello italiano. In Francia, la magistratura verifica non solo la sussistenza della causa tipizzata dal legislatore, ma anche il suo carattere reale (oggettivo, esistente ed esatto) e serio (sufficientemente importante). Questo controllo, definito 'cause réelle et sérieuse', sottopone il motivo economico a un vaglio penetrante, selezionando le cause in base al principio di proporzionalità. L'analisi del carattere 'réelle et sérieuse' si biforca: verifica la realtà materiale della causa (ad esempio, escludendo l'utilizzo sistematico di contratti a termine per coprire il posto del lavoratore licenziato) e la realtà dell'elemento causale (difficoltà economiche o minaccia alla competitività). Il criterio della serietà della ragione, ovvero la sua gravità e importanza, permette di negare la legittimità del licenziamento anche se la causa è reale, se non è considerata sufficientemente seria da rendere il licenziamento necessario. Il confronto con il sistema italiano evidenzia le diverse sfumature nel controllo giudiziale del licenziamento economico.
3. Insindacabilità delle Scelte Imprenditoriali e Limiti al Controllo Giudiziale
La sezione discute il principio di insindacabilità delle scelte organizzativo-imprenditoriali (art. 41 Cost., I comma) e il suo impatto sul controllo giudiziale del giustificato motivo oggettivo. Alcune decisioni della Corte di Cassazione sembrano tendere verso una lettura dell'art. 3 della Legge n. 604/66 più aderente a questo principio di insindacabilità. Tuttavia, l'applicazione rigorosa di questo principio renderebbe irrilevante la valutazione dell'entità del costo-opportunità per l'impresa: basterebbe una lieve perdita per rendere legittimo il licenziamento. Questa prospettiva è contrastata da alcuni, come M.T. Carinci, che considera qualsiasi scelta imprenditoriale genuinamente riferita all'organizzazione aziendale idonea a giustificare il licenziamento, giudicando l'intervento giudiziale eccessivamente invadente. La sezione evidenzia quindi il delicato equilibrio tra la tutela del lavoratore e la libertà d'impresa, con il ruolo del giudice chiamato a bilanciare questi interessi contrapposti.
VI.Diritto Europeo e Licenziamenti Limiti e Tutele
Il documento accenna all'influenza del diritto europeo sulla disciplina nazionale dei licenziamenti, evidenziando i limiti imposti da alcune direttive in materia di discriminazione, trasformazione del rapporto di lavoro e trasferimenti di azienda. Si cita l'articolo 30 della Carta di Nizza come riferimento importante, pur riconoscendone la mancanza di effetto diretto sugli ordinamenti nazionali in assenza di una specifica direttiva. Nonostante ciò, si evidenzia come la giurisprudenza interna di molti Stati, inclusa l'Italia (con riferimento a sentenze della Corte di Cassazione), utilizzi la Carta di Nizza come strumento interpretativo per rafforzare la tutela dei lavoratori.
1. Influenza del Diritto Europeo sui Licenziamenti Individuali
La sezione delinea l'influenza del diritto europeo sui licenziamenti individuali, pur in assenza di una direttiva specifica in materia. Si evidenzia come il diritto europeo incida su alcuni profili delle discipline nazionali tramite disposizioni contenute in altre direttive. Ad esempio, vengono citati limiti alla possibilità di licenziare un lavoratore che rifiuta la trasformazione del suo rapporto da tempo pieno a part-time (o viceversa), salvo altre ragioni legate al funzionamento dello stabilimento (art. 5.2 direttiva 97/81). Analogamente, la direttiva 2001/23 (art. 4.1) esclude che il trasferimento aziendale costituisca valido motivo di licenziamento, se non sussistono altre ragioni economiche, tecniche o organizzative. Il diritto antidiscriminatorio, fondato sugli artt. 18 e 19 del TFUE e sulle direttive in materia di discriminazioni di genere (2006/54) o di altre ragioni (2000/43 e 2000/78), ha un impatto significativo, portando al superamento di trattamenti differenziati tra lavoratori, soprattutto per età. La direttiva 98/59 sui licenziamenti collettivi completa il quadro. L'influenza europea si manifesta quindi attraverso direttive specifiche che impongono limiti e tutele ai licenziamenti, incidendo sulle normative nazionali.
2. La Carta di Nizza e la Tutela del Lavoratore
La sezione analizza il ruolo dell'articolo 30 della Carta di Nizza, un riferimento obbligato per il legislatore europeo e la Corte di Giustizia. Tuttavia, la sua rilevanza è condizionata dall'ambito di applicazione del diritto dell'UE, essendo applicabile agli Stati membri solo nell'attuazione del diritto dell'Unione (art. 51, co. 1, Carta). Questo significa che la norma non ha effetto diretto negli ordinamenti nazionali in assenza di direttive specifiche. Una Corte nazionale non può, quindi, dichiarare illegittimo un licenziamento solo per violazione dell'art. 30 della Carta di Nizza. Nonostante questo limite, si osserva un crescente utilizzo dell'articolo 30 come strumento interpretativo del diritto interno in diversi paesi europei (Portogallo, Spagna, Francia, Irlanda, Belgio), per rafforzare le tutele esistenti o colmare lacune legislative. Anche in Italia si riscontrano sentenze che richiamano la Carta di Nizza a sostegno di decisioni favorevoli al lavoratore licenziato, come la sentenza della Cassazione n. 21967/2010, che utilizza l'art. 30 per bilanciare libertà di iniziativa economica e tutela del posto di lavoro.
