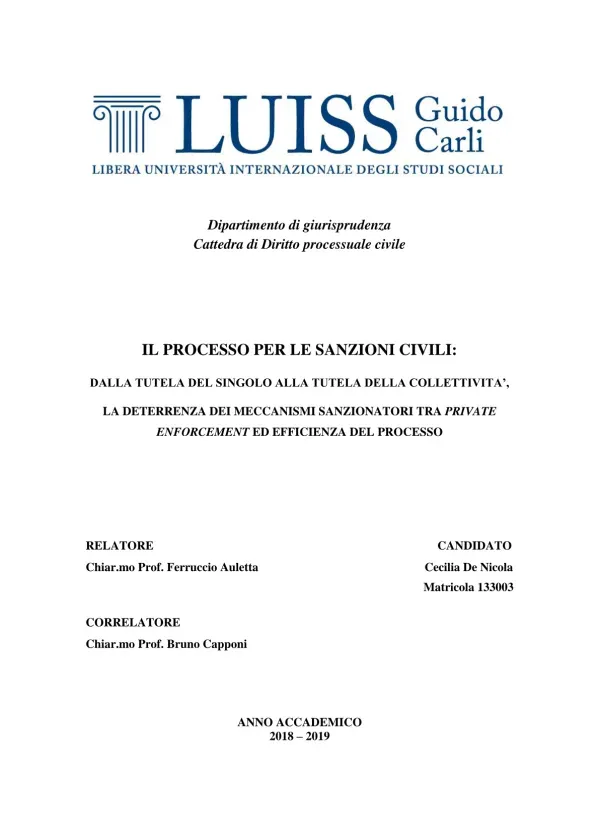
Sanzioni Civili: Processo e Deterrenza
Informazioni sul documento
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 1.68 MB |
Riassunto
I.lgs
Il documento analizza la depenalizzazione in Italia, focalizzandosi sulla trasformazione di reati penali in illeciti civili e la conseguente introduzione di sanzioni civili pecuniarie con il D.lgs. n. 7 del 2016. Vengono esaminati i principi ispiratori di questa riforma legislativa, confrontando il nuovo sistema civile con quelli penale e amministrativo. L'obiettivo principale è comprendere la struttura e l'applicazione pratica delle nuove sanzioni pecuniarie civili, tenendo conto della loro funzione sia compensativa che general-preventiva.
1. Definizione e Ratio della Depenalizzazione
Questa sezione introduce il concetto di depenalizzazione, spiegandone i tratti generali, la ragione sottesa e i principi ispiratori. Si evidenzia come il legislatore, con l'introduzione di un originale sistema di sanzioni civili, costruisce una nuova fisionomia e procedura per l'irrogazione delle pene. Viene sottolineato il passaggio da illeciti penali a illeciti amministrativi, già adottato nel 2016, come preludio all'introduzione delle nuove sanzioni civili pecuniarie previste dal D.lgs. n. 7 del 2016. Il testo si concentra sulla necessità di una risposta punitiva più proporzionata e adeguata, in base ai diversi interessi tutelati dalla norma. Si illustra la scelta del legislatore tra sanzioni penali, amministrative o civili in base alla gravità del fatto, arrivando all'eventuale abrogazione della fattispecie incriminatrice se il disvalore del comportamento è minimo o irrilevante. Si mette in luce che la scelta del risarcimento del danno è preferibile alle sanzioni pubblicistiche quando l'interesse della vittima è essenzialmente risarcitorio-compensativo e mancano esigenze di tutela di interessi sopraindividuali.
2. Analisi del D.lgs. n. 7 del 2016 Nuove Sanzioni Civili Pecuniarie
Questa parte analizza dettagliatamente la disciplina dei nuovi illeciti e delle sanzioni pecuniarie civili introdotte dal D.lgs. n. 7 del 2016, confrontando il nuovo sistema civile con quello penale e amministrativo. Vengono chiariti gli elementi costitutivi e le norme disciplinanti che costituiscono la disciplina generale del nuovo strumento civile. Si ipotizza la sua applicabilità a future fattispecie, a condizione che l'istituto risulti efficace nella pratica giudiziaria. L’analisi evidenzia l’incoerenza di voler risolvere il sovraccarico della giurisdizione penale gravando quella civile, già sovraccarica. Si discute l’effetto potenzialmente deflattivo dovuto all’onerosità del processo civile, ma anche il rischio di violare il diritto di agire in giudizio per i meno abbienti, a causa dei costi della giustizia. Si analizzano le peculiarità rispetto ai vecchi reati, la mancanza di circostanze aggravanti o attenuanti, e l'obbligo per il giudice di graduare la sanzione sulla base dei criteri di commisurazione ex art. 5. Si esaminano le eccezioni, come la ritorsione e la provocazione, e l'assenza dell'exceptio veritatis per l'attribuzione di un fatto determinato. L'applicabilità delle scriminanti comuni (esercizio di un diritto, adempimento di un dovere, legittima difesa, ecc.) è discussa, sottolineando la subordinazione al rispetto dei principi generali del diritto civile e l'impossibilità di giustificare l'abuso del diritto. La destinazione del provento della sanzione alla Cassa delle ammende è giustificata dalla funzione ultra-compensativa e general-preventiva, evitando un ingiustificato arricchimento del privato.
3. Le Deleghe Parlamentari e la Riforma del Sistema Penale
Si descrive il contesto della riforma del sistema penale che ha portato all'introduzione delle nuove sanzioni civili. Si fa riferimento all'introduzione della sospensione del processo con messa alla prova e all'emanazione di quattro deleghe legislative. Si analizzano le deleghe, focalizzandosi su quella che ha previsto l'introduzione della nuova causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.), esempio di depenalizzazione in concreto, e quelle che hanno previsto le forme di depenalizzazione in astratto, amministrativa e civile. Gli illeciti divenuti amministrativi sono quelli che ledono interessi collettivi o superindividuali, mentre quelli civili ledono prevalentemente interessi privati. Si evidenzia l'intento, per certi versi incoerente, del legislatore di risolvere il sovraccarico giurisdizionale penale gravando la giurisdizione civile. Si sottolinea che l’obiettivo deflattivo potrebbe essere realizzato dalla maggiore onerosità del processo civile, ma ciò potrebbe limitare l’accesso alla giustizia per i meno abbienti, creando un contrasto con il diritto di agire in giudizio ex art. 24 Cost.
II.Elementi Costitutivi degli Illeciti Civili e Applicazione delle Sanzioni
Si approfondiscono gli elementi costitutivi degli illeciti civili, con particolare attenzione all'elemento oggettivo e al danno causato. Il documento discute l'applicazione delle sanzioni, evidenziando l'irrogazione d'ufficio da parte del giudice in caso di accoglimento della domanda risarcitoria. Viene analizzata la competenza giurisdizionale e il rispetto delle garanzie processuali costituzionali, inclusi il diritto di difesa e il contraddittorio nel processo civile. La questione del grado di prova richiesto per l'irrogazione della sanzione civile è dibattuta, confrontando le tesi che propongono uno standard probatorio civile o penale.
1. Elementi Costitutivi degli Illeciti Civili
Questa sezione delinea gli elementi costitutivi degli illeciti civili, ponendo particolare enfasi sull'elemento oggettivo e sul danno causato. Si sottolinea come la definizione degli illeciti civili e la conseguente applicazione delle sanzioni mirino a prevenire discriminazioni irragionevoli derivanti da un trattamento uguale di situazioni differenti. L'analisi si concentra sulla necessità di garantire la funzione punitiva delle sanzioni, preservando un giusto equilibrio tra la gravità del fatto e la misura della pena. Viene analizzato il caso specifico dell’ingiuria, notando la conservazione di alcune aggravanti (attribuzione di un fatto determinato e commissione in presenza di una pluralità di persone) e cause speciali di non sanzionabilità (ritorsione e provocazione), mentre viene meno l’exceptio veritatis prevista dal vecchio art. 596 c.p. Si discute l'applicabilità delle scriminanti comuni (legittima difesa, stato di necessità, ecc.), sottolineando che esse, pur non essendo esplicitamente menzionate, sono applicabili in quanto principi generali dell'ordinamento giuridico. Tuttavia, la loro operatività è subordinata al rispetto dei principi del diritto civile, escludendo l'abuso del diritto, come ad esempio nel caso del diritto di critica politica, che deve comunque rispettare i requisiti di veridicità, rilevanza per l'interesse pubblico e continenza.
2. Irrogazione delle Sanzioni e Garanzie Processuali
Questa parte approfondisce l'irrogazione delle sanzioni civili pecuniarie, evidenziando la sua natura d'ufficio da parte del giudice, subordinata all'accoglimento della domanda risarcitoria. La finalità general-preventiva della sanzione e la destinazione del suo provento alla Cassa delle ammende giustificano questa applicazione ex officio. Si evidenzia l'assenza di un interesse diretto del privato nell'irrogazione della sanzione, che è volta a prevenire una privatizzazione eccessiva della pretesa sanzionatoria. L'analisi si sofferma sul rispetto delle garanzie processuali costituzionali, come il diritto di difesa, il contraddittorio, l'imparzialità del giudice, e la ragionevole durata del processo. Si discute una potenziale violazione dell'art. 6, c. 3, lett. d della CEDU riguardo al diritto di difesa, in relazione alla mancata regolamentazione specifica nel decreto. Si propongono diverse soluzioni interpretative, tra cui l'addossamento dell'onere della ricerca della prova al giudice o all'attore, al fine di ristabilire la parità nel contraddittorio. Si esamina anche il caso del concorso di persone, stabilendo che ciascuna persona soggiace alla sanzione, abbandonando la responsabilità solidale tipicamente civilistica.
3. Il Registro Informatizzato e la Reiterazione
La sezione descrive l'istituzione di un registro informatizzato (art. 11) che memorizza i provvedimenti sanzionatori, fondamentale per l'operatività dell'istituto della reiterazione. Questo registro aumenta l'efficacia repressiva e garantisce all'autore dell'illecito la certezza della sanzione e delle tutele connesse alla sua pubblicità. Si evidenzia che, a differenza delle sanzioni penali, non c'è l'esigenza di cancellare le tracce della commissione di un illecito, pur rimanendo necessaria la tutela della privacy dell’interessato. Si analizza la questione dell’onere della prova in relazione all’irrogazione delle sanzioni. Viene confrontata la posizione maggioritaria, che si allinea al modello del processo civile, con quella minoritaria, che ritiene prevalente il principio inquisitorio per la parte di processo che riguarda la pretesa punitiva statale, con conseguente onere probatorio a carico del giudice e applicazione del principio di presunzione di innocenza. Si discute la necessità di un intervento legislativo che regoli in modo più chiaro il ruolo del giudice e l’onere probatorio, garantendo nel contempo l’effettività e la legittimità costituzionale del processo.
III.Compatibilità con i Diversi Riti Processuali Civili
Il documento esamina la compatibilità delle nuove sanzioni civili pecuniarie con diversi riti processuali civili, tra cui il rito ordinario, il rito sommario di cognizione, il rito del lavoro e quello delle locazioni. Si analizzano le procedure, le tempistiche e le preclusioni previste per ciascuna tipologia di procedimento, evidenziando le implicazioni per l'effettività e la tempestività dell'applicazione delle sanzioni. Viene inoltre discussa l'incompatibilità con riti specifici come quelli per la convalida di sfratto o le azioni di danno temuto.
1. Compatibilità con il Rito Ordinario e il Rito Sommario di Cognizione
Questa sezione analizza la compatibilità delle sanzioni civili con il rito ordinario e il rito sommario di cognizione. Si afferma che, per cause di competenza del tribunale in composizione monocratica, è compatibile la proposizione della domanda tramite ricorso introduttivo del procedimento sommario di cognizione (artt. 702 bis ss. c.p.c.) o il trasferimento della causa dal rito ordinario al rito sommario su iniziativa del giudice (art. 183 bis c.p.c.). Tuttavia, il rito sommario è precluso per gli illeciti di falsità in atti che presuppongono la querela di falso (art. 221, c. 3 c.p.c.), in quanto in tal caso è obbligatorio l'intervento del PM, che porta alla competenza del giudice in composizione collegiale (art. 50 bis), escludendo il rito sommario. Il ricorso deve contenere tutti gli elementi della citazione, ad eccezione della data dell'udienza, fissata con decreto del giudice. La comparsa di risposta del convenuto deve avere un contenuto analogo a quello del rito a cognizione piena (art. 167 c.p.c.), con ammissibilità di difese successive, a differenza delle domande riconvenzionali ed eccezioni in senso stretto, che sono soggette a decadenza. La sezione tocca anche la chiamata del terzo garante, ipotizzando l'applicabilità anche di altre forme di chiamata in causa, nonostante non siano specificate nel testo normativo.
2. Incompatibilità con Altri Riti Speciali e Procedimenti
Questa parte evidenzia l'incompatibilità del processo per le sanzioni civili con alcuni riti speciali. In particolare, si sottolinea l'incompatibilità con il procedimento per convalida di licenza o sfratto (artt. 657 ss c.p.c.), che prevede la restituzione del bene con ordinanza e il pagamento dei canoni scaduti con decreto ingiuntivo, ma non il risarcimento del danno. Il risarcimento del danno, elemento necessario per l'irrogazione della sanzione civile, deve essere richiesto con il rito delle locazioni (a cognizione piena ed esauriente), che consente anche l'applicazione della sanzione pecuniaria civile. Analogamente, si evidenzia l’incompatibilità con le azioni possessorie, che presentano una struttura bifasica (cognizione sommaria per provvedimenti urgenti e cognizione piena per il merito). Se si richiede il risarcimento del danno nell'ambito di un'azione possessoria, è necessario richiedere la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito entro i termini previsti dall'art. 703, c. 4 c.p.c., oppure proporre un autonomo giudizio a cognizione piena. Infine, si evidenzia l’incompatibilità con le azioni di denuncia di nuova opera e di danno temuto (artt. 1171 e 1172 c.c.), che permettono solo provvedimenti inibitori e non risarcitori.
3. Procedimenti Speciali e Probabilità di Applicazione delle Sanzioni
Questa sezione confronta le probabilità di applicazione delle sanzioni civili in diversi riti processuali, evidenziando una maggiore probabilità nei riti speciali del lavoro e delle locazioni rispetto al rito ordinario. Si sottolinea che, nel rito ordinario, il giudice, avendo maggiori poteri istruttori, potrebbe facilitare il raggiungimento dello standard probatorio necessario per l'irrogazione della sanzione. Si discute quindi l'opportunità di estendere gli stessi poteri officiosi del giudice anche ad altri processi, evitando discriminazioni irragionevoli tra i convenuti in riti speciali e quelli nel rito ordinario. Si analizza il procedimento sommario di cognizione (art. 702 ter, c. 5 c.p.c.), caratterizzato da una semplicità e deformalizzazione che garantiscono una conclusione più rapida, pur prevedendo l’ammissibilità di tutti gli atti istruttori rilevanti. Si evidenzia che l’ordinamento giuridico presenta una maggior probabilità di incassare la sanzione pecuniaria civile all’esito di un processo speciale che segua il rito del lavoro o delle locazioni rispetto alle probabilità sussistenti nel rito ordinario. Si discute la possibilità di un potere istruttorio ufficioso del giudice, avvicinabile al potere di richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c.. Si conclude evidenziando che la mancata estensione di questi poteri ad altri riti potrebbe costituire una discriminazione.
IV.Onere Probatorio e Ruolo del Giudice
Si discute il delicato tema dell'onere probatorio nel processo per l'irrogazione delle sanzioni civili. Il testo confronta le diverse interpretazioni dottrinali, tra cui quella che assegna al giudice un ruolo più inquisitorio, e quella che preferisce un approccio più aderente al modello del processo civile, con un contraddittorio paritario tra le parti. Vengono analizzati gli strumenti probatori applicabili a diversi illeciti, come la prova testimoniale e la querela di falso, con particolare attenzione alle peculiarità dell'ingiuria.
1. Standard Probatorio Modello Civile vs. Modello Penale
La sezione affronta la questione cruciale dello standard probatorio richiesto per l'irrogazione delle sanzioni civili. Si evidenzia la contrapposizione tra due principali interpretazioni dottrinali. La tesi maggioritaria, condivisa dall'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, propone un allineamento al modello del processo civile, considerando la scelta di perseguire tali illeciti nel processo civile e la centralità degli interessi privati. Questa interpretazione privilegia la coerenza e la funzionalità pratico-applicativa, sottolineando che l’adozione del criterio probatorio civile non lede alcun diritto costituzionale, rispettando la clausola di compatibilità con le disposizioni del codice di rito. Si argomenta che, pur avendo una natura sanzionatoria, punitiva e afflittiva, le sanzioni civili non presentano la stessa gravità di quelle penali. Al contrario, la tesi minoritaria sostiene la prevalenza del principio inquisitorio sul dispositivo, assegnando al giudice l'onere della prova degli elementi costitutivi dell'illecito e della graduazione della sanzione, in quanto organo pubblico che esercita una pretesa punitiva. Questa interpretazione si basa sulla presunzione di innocenza (art. 27 Cost.) ed estesa dalla Corte EDU alle sanzioni rientranti nella “materia penale”. Il giudice, in questa prospettiva, avrebbe poteri officiosi maggiori rispetto al modello ordinario di processo, mentre il convenuto dovrebbe provare solo elementi impeditivi, estintivi e modificativi.
2. Il Ruolo del Giudice e la Discrezionalità nell Irrogazione della Sanzione
Questa parte analizza il ruolo del giudice nell'irrogazione della sanzione civile, focalizzandosi sulla sua discrezionalità. Si evidenzia che la formulazione della legge, usando il verbo “decidere” anziché “applicare”, sembra suggerire un margine di valutazione discrezionale da parte del giudice, che potrebbe scegliere di non irrogare la sanzione sulla base di considerazioni di opportunità. Questa interpretazione, pur rispettando l’intento deflattivo del legislatore, solleva diverse problematiche. Si analizzano le diverse situazioni possibili: il giudice che consapevolmente decide di non applicare la sanzione, motivando la sua scelta; il giudice che omette qualsiasi menzione della sanzione; il giudice che afferma erroneamente l'insussistenza di un elemento costitutivo o la sussistenza di una scriminante; il giudice che irroga una sanzione troppo bassa. Si discute la possibilità di impugnative in questi casi, evidenziando la difficoltà di individuare il soggetto legittimato ad agire. Viene menzionata una proposta alternativa, quella della Commissione Palazzo, di convertire la sanzione penale in sanzione civile, ma questa soluzione presenta dei limiti, in quanto priva il giudice di una valutazione aggiornata della situazione.
3. Prove Specifiche per Diversi Illeciti Il Caso dell Ingiuria e dei Falsi
La sezione approfondisce l'applicazione di specifici mezzi di prova a diversi illeciti civili. Si analizza il caso dell'ingiuria, che richiede normalmente la prova testimoniale (art. 244 c.p.c.), con l'indicazione del fatto da provare in un capitolo specifico e determinato. Si discute la nullità della deposizione de relato actoris e l'ammissibilità di quella de relato in genere, secondo l'art. 257 c.p.c. La forza probatoria delle deposizioni de relato è attenuata dalla natura indiretta, assumendo rilevanza solo se corroborata da altri elementi concordanti. Si menziona anche la prova testimoniale scritta (art. 257 bis c.p.c.), ammessa con l'accordo delle parti. Per quanto riguarda gli illeciti di falso, si evidenzia che la querela di falso (artt. 2702 c.c. e 221 c.p.c.) è compatibile con il giudizio, così come gli artt. 221-227 c.p.c. e l'art. 313 c.p.c. (sospensione del procedimento dinanzi al giudice di pace). Si sottolinea, invece, l'incompatibilità con il disconoscimento (art. 214 c.p.c.), in quanto questo presuppone la mancata produzione del danno. Si conclude con l’analisi della prova testimoniale come strumento principale per l'accertamento dell’ingiuria, con riferimento all’art. 244 c.p.c. e all’attenuazione della forza probatoria delle deposizioni indirette.
V.La Fase Decisoria e Potere Discrezionale del Giudice
L'analisi si concentra sulla fase decisoria del processo, focalizzandosi sul potere discrezionale del giudice nell'irrogare la sanzione civile. Il documento esplora le possibili conseguenze di una mancata irrogazione o di un'irrogazione ritenuta insufficiente, discutendo le implicazioni per l'effettività del nuovo sistema sanzionatorio. Vengono inoltre considerate le criticità applicative e le potenziali impugnative delle decisioni giudiziali in merito alle sanzioni civili pecuniarie.
1. Onere della Prova e Ruolo del Giudice Diversi Approcci Interpretativi
Questa sezione analizza il dibattito dottrinale sull'onere della prova e il ruolo del giudice nell'irrogazione delle sanzioni civili. Si confrontano due posizioni principali: una che assegna al giudice un ruolo più vicino al modello del processo civile, con un contraddittorio paritario tra le parti e l’onere della prova principalmente a carico delle parti, e una che assegna al giudice un ruolo più inquisitorio, carico dell’onere della prova degli elementi costitutivi dell’illecito e della graduazione della sanzione, giustificato dalla pretesa punitiva statale. La tesi maggioritaria, sostenuta anche dall’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, privilegia il modello civile per ragioni di coerenza e funzionalità applicativa, sottolineando la centralità degli interessi privati nel processo civile e la compatibilità con le garanzie costituzionali. La tesi minoritaria, invece, evidenzia la natura pubblicistica delle sanzioni e la necessità di un approccio più vicino al processo penale per garantire l'effettività delle sanzioni e il rispetto del principio di presunzione di innocenza. Si discutono anche soluzioni intermedie che prevedono una diversificazione dello standard probatorio a seconda del tipo di illecito o del rito applicato, ma queste soluzioni sono considerate fonte di incertezze e possibili discriminazioni.
2. Il Potere Discrezionale del Giudice nella Fase Decisoria
Questa parte si concentra sul potere discrezionale del giudice nella fase decisoria. Si analizza l'uso del verbo “decidere” nella legge, interpretato come indicativo di una discrezionalità nella scelta di irrogare o meno la sanzione, in base a considerazioni di opportunità. Questa interpretazione, se da un lato rispetta l'intento deflattivo del legislatore, dall'altro genera incertezze e problematiche applicative. Vengono esaminate diverse ipotesi problematiche: il giudice che decide consapevolmente di non irrogare la sanzione, motivando la sua decisione; il giudice che omette qualsiasi menzione della sanzione; il giudice che commette errori nell’accertamento dei fatti; il giudice che irroga una sanzione troppo bassa. Si evidenziano le difficoltà di impugnazione in queste situazioni, mettendo in luce la mancanza di chiarezza riguardo al soggetto legittimato a presentare l'impugnazione. Si conclude ribadendo l’importanza di una maggiore chiarezza legislativa per garantire l’effettività e la prevedibilità dell’applicazione delle sanzioni civili.
3. Mezzi di Prova Specifici Ingiuria e Falsi in Atti
La sezione approfondisce i mezzi di prova applicabili a specifici illeciti. Nel caso dell'ingiuria, si sottolinea il ricorso prevalente alla prova testimoniale, con riferimento all'art. 244 c.p.c. che impone di dedurre il fatto da provare in un capitolo specifico e determinato, e all’art. 257 c.p.c. sulla deposizione de relato. Si discute la nullità della deposizione de relato actoris e la rilevanza delle deposizioni indirette solo in presenza di altri elementi oggettivi e concordanti. L'ammissibilità della prova testimoniale scritta (art. 257 bis c.p.c.) è menzionata, così come la compatibilità del procedimento per querela di falso (artt. 221-227 c.p.c. e art. 313 c.p.c.) nel caso di illeciti di falso, escludendo invece il disconoscimento (art. 214 c.p.c.) in quanto non presuppone la produzione di un danno. La sezione evidenzia quindi come la scelta del mezzo di prova debba essere funzionale all'accertamento dei fatti specifici di ogni illecito, sottolineando il ruolo del giudice nel valutare la concludenza delle prove e garantire un giusto processo.
VI.Azioni Collettive e Tutela degli Interessi Collettivi
Il documento affronta la questione della tutela degli interessi collettivi, in relazione alle nuove sanzioni civili. Si analizzano le possibili forme di azione collettiva, come la class action, e si discutono le problematiche legate alla legittimazione ad agire e alla rappresentanza degli interessi diffusi. Viene esaminato il ruolo potenziale dell’azione popolare e le sue limitazioni in relazione ai principi costituzionali, esplorando le differenze tra diritti soggettivi e interessi collettivi.
1. La Tutela degli Interessi Collettivi Limiti dell Azione Popolare e della Class Action
Questa sezione affronta la problematica della tutela degli interessi collettivi nel contesto delle nuove sanzioni civili, analizzando i limiti dell’azione popolare e della class action. Si discute il mancato utilizzo dell’azione popolare, a causa del suo apparente contrasto con gli artt. 24 e 103 Cost., che richiedono la titolarità di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo da parte dell'attore. Si evidenzia la funzione primaria dell’azione popolare nella difesa dei beni comuni e la sua diversa accezione nel mondo romano, dove ogni cittadino aveva la legittimazione ad esperirla. Si ipotizza una possibile analogia con le sanzioni civili, considerando la sicurezza dei cittadini come oggetto di un diritto individuale e superindividuale, che permetterebbe a ciascun cittadino di agire in giudizio per la sua protezione. Per quanto riguarda la class action, il documento evidenzia come il legislatore ne abbia limitato l'applicazione alla sola tutela dei consumatori, impedendone l’estensione analogica al settore degli illeciti civili a causa della mancanza di requisiti di somiglianza tra le fattispecie e identità di ratio. Si sottolinea che la class action è legata alla tutela di diritti soggettivi e interessi legittimi, e non si presta alla tutela degli interessi di tutti i consociati.
2. Diverse Interpretazioni della Legittimazione ad Agire per la Tutela di Interessi Collettivi
La sezione presenta diverse interpretazioni dottrinali sulla legittimazione ad agire per la tutela di interessi collettivi. Alcune teorie considerano l'azione come un esempio di sostituzione processuale (art. 81 c.p.c.), mentre altre la vedono come esercizio privato di funzioni pubbliche, definendo l'attore popolare una longa manus dello Stato, un pubblico ministero privato con un semplice interesse riflesso. Altre interpretazioni ancora considerano l'attore come un rappresentante giudiziale sui generis dello Stato o di enti pubblici, o come titolare di un interesse adespota, che solo in caso di collettività organizzata può essere tutelato. Si analizzano le basi normative della legittimazione ad agire per la tutela degli interessi diffusi (art. 9 l. n. 241 del 1990 e art. 13 l. n. 349 del 1986), evidenziando le critiche alla non equiparabilità tra partecipazione al procedimento amministrativo e partecipazione/iniziativa al processo. Si mette in luce la necessità di un’espressa attribuzione ex lege per la tutela di interessi diffusi (indivisibili) rispetto a quelli collettivi (divisibili). Si conclude sottolineando la critica all'azione popolare, che ne ha impedito l'adozione a causa del suo apparente contrasto con gli artt. 24 e 103 Cost., che presuppongono la titolarità di un diritto soggettivo o interesse legittimo in capo all'attore.
3. L Azione di Classe e la Tutela Giurisdizionale degli Interessi Superindividuali
Questa sezione analizza l'azione di classe e la sua evoluzione normativa, evidenziando la sua nuova collocazione nel codice di procedura civile (artt. 840 bis ss.) e la sua estensione come istituto generale del diritto civile. Si sottolinea che le situazioni giuridiche soggettive tutelabili sono i diritti individuali omogenei dei membri di una classe, includendo anche le imprese come potenziali attori, a differenza della precedente limitazione ai consumatori. L'azione è volta all'accertamento della responsabilità e alla condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Si discute l’assenza di strumenti di tutela collettiva nel nostro ordinamento, come la class action, che limitano la possibilità di ottenere effetti di portata meta-individuale dei risultati processuali. Si accenna all’estensione di funzioni di tutela dei diritti a autorità indipendenti e al conseguente spostamento della soluzione delle controversie verso la giustizia amministrativa, motivato dalla necessità di garantire il corretto funzionamento del mercato e il godimento dei beni comuni. La sezione conclude evidenziando l’evoluzione dell’azione di classe, che nel testo del 2018 rispetto a quello del 2015 ha mantenuto sostanzialmente invariate le sue caratteristiche principali.
