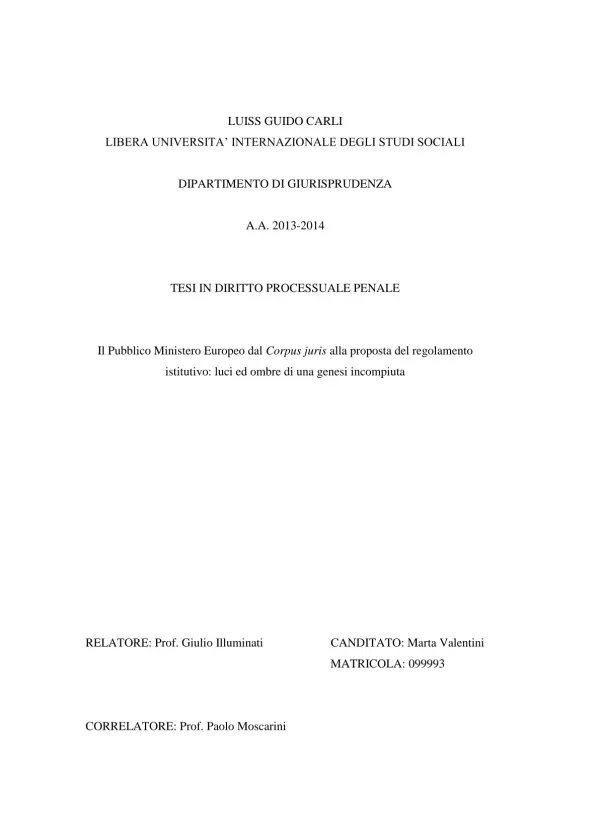
Procura Europea: Genesi e Prospettive
Informazioni sul documento
| Autore | Marta Valentini |
| instructor | Prof. Giulio Illuminati |
| Scuola | Luiss Guido Carli, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali |
| Specialità | Diritto Processuale Penale |
| Tipo di documento | Tesi di Laurea |
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 2.23 MB |
Riassunto
I.Il Principio di Leale Collaborazione e l Esecuzione del Trattato UE
Il documento analizza il principio di leale collaborazione tra gli Stati membri dell'UE, sancito dall'articolo 4, paragrafo terzo, del Trattato sull'Unione Europea (TUE), e derivante dall'articolo 5 del Trattato istitutivo della Comunità europea (TCE). Questo principio, inizialmente considerato una disposizione di supporto, è diventato una fonte autonoma di un generale dovere di cooperazione e di un obbligo di risultato, come confermato dalla giurisprudenza comunitaria. L'articolo evidenzia l'obbligo degli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato.
1. Evoluzione del Principio di Leale Collaborazione
Il documento traccia l'evoluzione del principio di leale collaborazione all'interno del quadro giuridico dell'Unione Europea. Inizialmente formulato nell'articolo 5 del Trattato istitutivo della Comunità europea (TCE), questo principio è stato poi rinumerato come articolo 10 nel Trattato di Amsterdam del 1997, e infine integrato all'articolo 4, paragrafo terzo, del Trattato sull'Unione Europea (TUE). L'articolo 10 TCE stabiliva l'obbligo per gli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie, di carattere generale e particolare, per assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato e dagli atti delle istituzioni comunitarie. Si evidenzia come il principio, inizialmente concepito come disposizione di supporto, sia diventato, grazie all'interpretazione della giurisprudenza comunitaria, una fonte autonoma di un generale dovere di leale collaborazione e di un obbligo di risultato. Questo sviluppo sottolinea l'importanza crescente di una collaborazione effettiva tra gli Stati membri per il buon funzionamento dell'Unione Europea. L'opera di giurisprudenza comunitaria ha quindi elevato il principio da semplice strumento di supporto a norma autonoma con efficacia vincolante per gli stati membri nel garantire il raggiungimento degli obiettivi del Trattato. Le opere citate di Sicurella e Zuleeg, forniscono ulteriore approfondimento su questo punto.
2. Il Ruolo della Giurisprudenza Comunitaria
Un aspetto cruciale dell'analisi è il ruolo svolto dalla giurisprudenza comunitaria nell'affermazione del principio di leale collaborazione come fonte autonoma di obblighi. L'interpretazione giurisprudenziale ha trasformato una disposizione inizialmente considerata di mero supporto in un elemento fondamentale del diritto dell'Unione Europea. La Corte di Giustizia, attraverso le sue sentenze, ha contribuito a definire la portata e l'efficacia di questo principio, rafforzando l'obbligo di risultato e la responsabilità degli Stati membri nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Trattato. Questo processo di evoluzione giuridica sottolinea la natura dinamica del diritto europeo e il ruolo centrale della Corte di Giustizia nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme. L'evoluzione del principio di leale collaborazione, da disposizione ausiliaria a norma autonoma con obbligo di risultato, è un esempio chiaro dell'influenza della giurisprudenza comunitaria nella costruzione del diritto europeo. Si sottolinea la progressiva affermazione di tale principio a fonte indipendente di obblighi, andando oltre la semplice funzione ausiliaria inizialmente prevista.
II.L Accordo di Schengen e l Integrazione nell Unione Europea
Il documento descrive l'integrazione dell'Accordo di Schengen nel diritto dell'UE. Gli accordi di Schengen, inizialmente conclusi al di fuori del quadro comunitario, hanno abolito i controlli alle frontiere interne tra gli Stati firmatari, creando uno Spazio Schengen di libera circolazione delle persone. L'integrazione di questi accordi nell'acquis communautaire è stata complessa, richiedendo una cooperazione rafforzata a causa dell'opposizione di Regno Unito e Irlanda. L'integrazione ha incluso misure compensative, in particolare nel campo della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, come il Sistema d'informazione Schengen (SIS).
1. Gli Accordi di Schengen Origine e Funzionamento
Il testo descrive gli accordi di Schengen come un processo di cooperazione intergovernativa, sviluppato al di fuori del quadro istituzionale comunitario. Si specifica la composizione degli accordi, che comprendono l'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (entrato in vigore il 2 marzo 1986), finalizzato all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere, e la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990 (CAAS), entrata in vigore il 26 marzo 1995. Quest'ultima convenzione, in particolare, ha abolito i controlli interni tra gli Stati firmatari, creando uno spazio di libera circolazione delle persone con un'unica frontiera esterna. La creazione di questo spazio comune di libera circolazione ha richiesto, come nel progetto comunitario per la creazione di un mercato comune, l'adozione di misure compensative, concentrandosi in modo particolare sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale per contrastare la criminalità transfrontaliera. Un esempio di queste misure compensative è lo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen (SIS), successivamente sostituito dal SIS II, un archivio di dati che facilita lo scambio di informazioni tra le autorità competenti. L'implementazione degli accordi di Schengen avveniva tramite stretta cooperazione intergovernativa, a differenza del processo decisionale comunitario.
2. L Integrazione di Schengen nell Acquis Communautaire
La sezione approfondisce il processo di integrazione degli accordi di Schengen nel diritto dell'Unione Europea, evidenziando le ragioni e le difficoltà incontrate. L'obiettivo comune perseguito sia dagli accordi di Schengen che dall'Unione Europea, la vastità dell'area Schengen (che comprendeva 13 dei 15 Stati membri all'epoca, escluso Regno Unito e Irlanda, con la Danimarca che aderì nel 1996), e la necessità di coinvolgere gli Stati candidati all'adesione, hanno spinto verso questa integrazione. Tuttavia, il rifiuto del Regno Unito e dell'Irlanda ha richiesto il ricorso ad una specifica cooperazione rafforzata, prevista dall'articolo 1 del Protocollo n. 8, con una clausola di 'opt-in' per i due Stati, subordinata al consenso unanime del Consiglio degli Stati firmatari. Questo processo ha evidenziato la necessità di trovare un equilibrio tra le esigenze di integrazione europea e il rispetto delle prerogative nazionali, illustrando le complessità della costruzione di uno spazio giuridico comune in ambito di sicurezza e libertà. L'integrazione degli accordi di Schengen nell'acquis communautaire ha richiesto una cooperazione rafforzata di tipo predeterminato a causa del diniego di Regno Unito e Irlanda, evidenziando la tensione tra le esigenze di unificazione e il rispetto della sovranità nazionale.
III.La Tutela degli Interessi Finanziari dell UE e il Ruolo del Terzo Pilastro
Si discute la tutela degli interessi finanziari dell'UE, tradizionalmente affrontata con strumenti del Terzo pilastro (convenzioni) e del Primo pilastro (regolamenti e direttive). La Convenzione PIF del 1995, con i suoi protocolli addizionali, e il Regolamento (CE) 2988/1995, sono esempi di questa duplice strategia del “doppio testo”. L'obiettivo è proteggere il bilancio comunitario da condotte di rilevanza penale, armonizzando le legislazioni nazionali e promuovendo la cooperazione tra le autorità. Prima del Trattato di Lisbona, la materia della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale era disciplinata attraverso posizioni comuni, decisioni quadro, decisioni e convenzioni.
1. La Tutela del Bilancio Comunitario Un Approccio Bifronte
La protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea è un tema centrale del documento. Si evidenzia come la tutela del bilancio comunitario sia sempre stata un obiettivo primario dell'Unione, affrontato con strumenti amministrativi (Primo pilastro) ma anche con strumenti penali, data la possibilità che le irregolarità degenerino in reati. La protezione di questi interessi finanziari è considerata un settore a sé stante del diritto penale europeo, che tradizionalmente si estende sia al Primo che al Terzo pilastro. Prima del Trattato di Lisbona, la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, rientrando nel Terzo pilastro, era disciplinata con strumenti diversi dai regolamenti o direttive del Primo pilastro, come posizioni comuni, decisioni quadro, decisioni e convenzioni. Il documento sottolinea la tecnica del “doppio testo”, dove strumenti del Terzo pilastro (come convenzioni) vengono utilizzati per armonizzare le disposizioni penali necessarie all'effettiva attuazione di discipline del Primo pilastro. La Convenzione per gli interessi finanziari dell’Unione europea (Convenzione PIF) del 1995, e il Regolamento (CE) 2988/1995, ne sono un esempio concreto, mostrando come la tutela del bilancio richieda un approccio che integri sia strumenti amministrativi che penali, a livello comunitario e nazionale.
2. La Convenzione PIF e il Regolamento CE 2988 1995
La Convenzione PIF del 1995 e i suoi protocolli addizionali rappresentano un pilastro fondamentale nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea. Il documento evidenzia l'obbligo per gli Stati membri di considerare come illeciti penali diverse condotte, tra cui la presentazione o l'utilizzo di documenti falsi, inesatti o incompleti; la mancata comunicazione di informazioni in violazione di un obbligo giuridico con conseguente danno al bilancio comunitario; e la distrazione di fondi comunitari per fini diversi da quelli previsti. L'importanza del Regolamento (CE) 2988/1995 è sottolineata, in quanto permette una tutela, anche se minima, contro le frodi agli interessi comunitari, indipendentemente dalla ratifica della Convenzione PIF da parte di tutti gli Stati membri. Questo evidenzia la stretta interconnessione tra strumenti del Primo e del Terzo pilastro, secondo la logica del “doppio testo”, dove il Terzo pilastro interviene per armonizzare le disposizioni penali necessarie all'attuazione delle politiche del Primo pilastro. La Convenzione PIF definisce anche la semplice redazione o il rilascio intenzionale di documenti falsi come condotta rilevante, anche in assenza di frode, mostrando la volontà di una tutela ampia degli interessi finanziari comunitari.
3. Criticità e Sfide nell Applicazione delle Sanzioni
Nonostante gli sforzi di armonizzazione, il documento riconosce le criticità nell'applicazione delle sanzioni penali per la protezione degli interessi finanziari dell'UE. L'affidamento dell'applicazione delle sanzioni alle autorità nazionali comporta una potenziale disomogeneità applicativa nei vari Stati membri, a causa delle diverse regole procedurali presenti nei vari ordinamenti nazionali. Si evidenzia la mancanza di una chiara coscienza degli interessi comunitari da parte di alcune autorità nazionali, che potrebbero dare la precedenza agli interessi nazionali, o addirittura essere coinvolte nelle irregolarità. In alcuni Stati, la concessione di sovvenzioni comunitarie potrebbe essere condizionata da interessi politici, compromettendo la corretta gestione dei fondi e la repressione degli illeciti. Queste criticità sottolineano la necessità di una maggiore armonizzazione e di una maggiore consapevolezza a livello nazionale dell'importanza della protezione degli interessi finanziari dell'UE. La disomogeneità nell’applicazione delle sanzioni e la prevalenza degli interessi nazionali rispetto a quelli comunitari sono citate come punti critici nell’attuale sistema di tutela.
IV.Europol e Eurojust Organi di Cooperazione Giudiziaria e di Polizia
Il documento presenta Europol ed Eurojust, due organismi chiave nella cooperazione giudiziaria e di polizia. Europol, inizialmente un organismo intergovernativo, è diventato un'agenzia dell'UE, supportando le autorità di polizia nazionali nella lotta contro la criminalità transnazionale. Eurojust facilita il coordinamento tra le autorità nazionali responsabili dell'azione penale, soprattutto nei casi di criminalità organizzata. Entrambi gli organismi si avvalgono di banche dati (Sistema d'informazione Europol e altre) per facilitare lo scambio di informazioni.
1. Europol Evoluzione da Organismo Intergovernativo ad Agenzia dell UE
Il documento descrive l'evoluzione di Europol, inizialmente un organismo di cooperazione di polizia di natura intergovernativa, istituito con la Convenzione di Cannes del 26 luglio 1995 (Convenzione Europol), basandosi sull'articolo K.3 TUE. Il suo scopo principale era promuovere il coordinamento e l'effettuazione di operazioni investigative specifiche da parte delle autorità competenti degli Stati membri, nonché il coordinamento tra organi inquirenti (giudiziari e di polizia) specializzati nel contrasto alla criminalità transfrontaliera. Con la decisione del Consiglio 2009/371/GAI del 6 aprile 2009, Europol è stata trasformata in un'Agenzia dell'Unione europea, finanziata da un contributo comunitario iscritto al bilancio dell'Unione. Questo cambiamento ha portato ad un maggiore controllo da parte del Parlamento europeo, anche a livello finanziario, migliorando la sua dimensione operativa. Il passaggio da organismo intergovernativo ad agenzia dell'UE ha risolto il problema della lentezza decisionale, derivante dal principio di unanimità in un contesto di 27 Stati membri. Attualmente, Europol è strutturata con un Consiglio d'amministrazione e un direttore, ed opera su un ampio ventaglio di reati, ma senza poteri autoritativi diretti nei confronti delle autorità nazionali. Il suo ruolo principale rimane quello di supporto e potenziamento dell'azione delle autorità di polizia nazionali, come previsto dall'articolo 88 TFUE.
2. Eurojust Coordinamento dell Azione Penale Nazionale
Il documento presenta Eurojust come un organismo giudiziario, istituito per agevolare il coordinamento tra le autorità nazionali responsabili dell'azione penale. A differenza di Europol, Eurojust si concentra sulla cooperazione giudiziaria, assistendo le indagini relative a casi di criminalità organizzata, basandosi anche sulle analisi di Europol, e cooperando con la Rete Giudiziaria Europea (RGE) per semplificare l'esecuzione delle rogatorie. Eurojust è composto da pubblici ministeri, magistrati o funzionari di polizia di pari competenza, distaccati da ogni Stato membro. Il documento evidenzia la natura collaborativa di Eurojust, che non ha poteri autoritativi diretti sulle autorità nazionali. Queste ultime hanno il compito di esaminare le sollecitazioni di Eurojust e di comunicarne la decisione finale, motivando eventuali rifiuti di collaborare alle indagini. Eurojust agisce quindi come un facilitatore del coordinamento tra le diverse autorità nazionali, piuttosto che come un organo con poteri investigativi o repressivi propri. La riunione di Tampere del 1999, pur non avendo istituito una Procura Europea (PME), ha sottolineato l'importanza del principio di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie come base per una maggiore cooperazione giudiziaria.
V.La Proposta di una Procura Europea e il Libro Verde
Si analizza la proposta di istituire una Procura europea (PME, poi EPPO), per contrastare efficacemente le frodi a danno degli interessi finanziari dell'UE. Il Libro Verde del 2001 e il Corpus Juris del 2000 hanno anticipato questa proposta, suggerendo diverse modalità organizzative e procedurali. L'obiettivo è quello di creare uno spazio penale europeo più efficiente, garantendo l'applicazione uniforme della legge e superando le difficoltà derivanti dal frazionamento del sistema giudiziario europeo. La proposta del Libro verde enfatizza l’armonizzazione specifica per i reati lesivi degli interessi finanziari e il rimando al diritto nazionale per le norme di carattere generale, in contrasto con l’approccio del Corpus Juris che prevedeva una maggiore unificazione.
1. La Necessità di una Procura Europea Analisi delle Carenze
La sezione introduce la proposta di creazione di una Procura Europea (PME, poi EPPO), motivandola con le inadeguatezze dei sistemi esistenti. Il documento evidenzia come il frazionamento dello spazio penale europeo e l'inadeguatezza dei metodi classici di cooperazione giudiziaria e di polizia rendessero inefficaci gli sforzi contro le frodi transnazionali. Si sottolinea la necessità di una tutela particolarmente elevata e uniforme degli interessi finanziari comunitari. Nonostante l'efficacia del coordinamento amministrativo offerto dall'Ufficio europeo per la lotta contro le frodi (OLAF), l'azione penale rimaneva incerta in assenza di un organo specifico di azione penale a livello comunitario. La Commissione, quindi, raccomandava di integrare le disposizioni di diritto primario per permettere la creazione di una Procura europea, la cui organizzazione e funzionamento sarebbero stati definiti successivamente con atti di diritto derivato. L’obiettivo era superare gli ostacoli all'azione delle forze di polizia e dei giudici, derivanti dalla frammentazione del sistema, offrendo un vantaggio ai criminali. Il documento evidenzia come, nonostante il coordinamento dell'OLAF, la mancanza di un organo comunitario di azione penale rendeva incerta l’azione penale contro le frodi transnazionali.
2. Il Libro Verde del 2001 e il Corpus Juris del 2000 Proposte Precedenti
Il documento analizza le proposte formulate nel Libro Verde del 2001 e nel Corpus Juris del 2000, che hanno anticipato la proposta di una Procura Europea. Queste proposte hanno esplorato diverse modalità organizzative e procedurali per la nuova struttura. Il Libro Verde, in particolare, proponeva un approccio che conciliasse l'armonizzazione delle norme penali con il rimando al diritto nazionale, evitando una codificazione generale del diritto penale tra gli Stati membri. Questa strategia si focalizzava sull’armonizzazione specifica dei reati lesivi degli interessi finanziari della Comunità, lasciando spazio al diritto nazionale per le norme di carattere generale. Il Corpus Juris, invece, proponeva un’unificazione più ampia, anche delle norme di carattere generale. Si evidenzia come la scelta del Libro Verde si basasse su una “dinamica evolutiva” di processi di armonizzazione specifici per la tutela degli interessi finanziari, auspicando un’ulteriore evoluzione generale del contesto giuridico basata sul principio del reciproco riconoscimento. La differenza di approccio tra Libro Verde e Corpus Juris evidenzia il dibattito sulla migliore strategia per la creazione di uno spazio penale europeo efficace.
3. Aspetti Organizzativi e Procedurali della Proposta
La sezione si concentra sugli aspetti organizzativi e procedurali della proposta di Procura Europea, evidenziando le diverse proposte e le relative criticità. Sia il Libro Verde che il Corpus Juris prevedevano una struttura con un Procuratore Generale Europeo (PGE) e Procuratori Delegati Europei (PDE), con un'organizzazione decentrata che integrava l'operato della Procura negli ordinamenti nazionali. La nomina dei membri della Procura, affidata al Parlamento europeo, ha suscitato perplessità riguardo all'indipendenza del PME da influenze politiche. La preoccupazione per l'indipendenza del pubblico ministero europeo è stata un tema ricorrente nel dibattito. Il documento accenna anche alla questione della “prova europea” e alla difficoltà di armonizzare le diverse regole probatorie nazionali, sottolineando il rischio di una disomogeneità nell'ammissione delle prove provenienti dalla Procura Europea. Il documento analizza la proposta di regolamento per l’EPPO, evidenziando la scelta di evitare una codificazione generale del diritto penale europeo, optando per una soluzione basata sul reciproco riconoscimento dei provvedimenti coercitivi nazionali e sull'ammissibilità delle prove legalmente acquisite secondo la lex loci.
VI.La Rete Giudiziaria Europea e il Mutuo Riconoscimento
Il documento tratta della Rete Giudiziaria Europea (RGE), creata per facilitare il coordinamento nella cooperazione giudiziaria. La RGE, attraverso i punti di contatto nazionali, promuove lo scambio di informazioni e l'organizzazione di riunioni. La decisione 2008/976/GAI ha riformato la RGE, in linea con il Trattato di Lisbona e l'allargamento dell'UE. Il documento collega la RGE al principio di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie, un pilastro fondamentale della cooperazione giudiziaria in ambito penale, e al mandato di arresto europeo (MAE).
1. La Rete Giudiziaria Europea Struttura e Funzionamento
Il documento descrive la Rete Giudiziaria Europea (European Judicial Network), istituita con l'azione comune 98/428GAI del 29 giugno 1998, per migliorare il coordinamento nella cooperazione giudiziaria. A differenza del semplice scambio di magistrati di collegamento, la RGE è una struttura istituzionale con autorità centrali e punti di contatto in ogni Stato membro, definiti come “intermediari attivi”. Questi punti di contatto facilitano la cooperazione tramite lo scambio di informazioni e l'organizzazione di riunioni periodiche. Il documento evidenzia una successiva riforma della RGE con la decisione 2008/976/GAI del 16 dicembre 2008, che ha ridefinito la struttura e il funzionamento della rete. Questa riforma, influenzata dal Trattato di Lisbona e dall'allargamento dell'Unione, tiene conto dell'esperienza delle prime applicazioni del principio di mutuo riconoscimento (per il mandato d'arresto europeo, il congelamento e sequestro di beni, e il mandato europeo di ricerca delle prove). La riforma ha introdotto nuove figure, come il corrispondente nazionale e il corrispondente incaricato degli aspetti tecnici, per migliorare il coordinamento interno e la gestione delle informazioni.
2. Il Principio di Mutuo Riconoscimento e la Rete Giudiziaria
La sezione collega la Rete Giudiziaria Europea al principio di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie, un elemento chiave della cooperazione giudiziaria in materia penale. Il documento sottolinea che il mutuo riconoscimento, inizialmente concepito per rassicurare gli Stati membri sulla preservazione della loro identità nazionale, ha contribuito allo sviluppo della cooperazione giudiziaria, pur in presenza di un certo grado di incertezza normativa. L'istituzione della RGE ha contribuito a facilitare l'applicazione pratica del principio di mutuo riconoscimento, migliorando lo scambio di informazioni e il coordinamento tra le autorità giudiziarie dei diversi Stati membri. L'evoluzione della RGE, con l'introduzione di nuove figure e di regole che disciplinano la collaborazione con Eurojust, riflette la necessità di adattare gli strumenti di cooperazione giudiziaria alle nuove realtà dell'Unione Europea allargata e al rafforzamento del principio di mutuo riconoscimento. Si evidenzia come il mutuo riconoscimento, pur non implicando un'unificazione degli ordinamenti, facilita l'armonizzazione tra le diverse legislazioni nazionali, nel contesto di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
VII.La Prescrizione nei Reati di Corruzione
Il documento evidenzia il problema dei termini di prescrizione nei reati di corruzione in Italia, sottolineando come la lunghezza dei processi e le regole sulla prescrizione portino all'estinzione di molti procedimenti. Si confrontano i dati italiani con quelli di altri Stati membri dell'UE, evidenziando un tasso di prescrizione significativamente più elevato in Italia. Questo problema è stato segnalato dal GRECO e dall'OCSE.
1. Il Problema della Prescrizione nei Reati di Corruzione in Italia
La sezione del documento si concentra sul problema della prescrizione nei reati di corruzione in Italia, evidenziando come questo fenomeno comprometta l'efficacia delle indagini e dell'accertamento dei fatti. La normativa italiana sulla prescrizione, caratterizzata da termini lunghi, regole complesse di calcolo e mancanza di flessibilità nella sospensione o interruzione dei termini, determina l'estinzione di un numero significativo di procedimenti. Questo problema è stato segnalato come un fattore critico nel rafforzamento del quadro giuridico di contrasto alla corruzione, incluso nelle raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Italia dal Consiglio a luglio 2013 nel quadro del semestre europeo. Uno studio di Transparency International del 2010 ha evidenziato che, tra il 2005 e il 2010, circa un procedimento su dieci per reati di corruzione si è estinto per prescrizione nell'Unione Europea, con l'Italia che presenta un tasso di estinzione significativamente più alto (circa l'11,14% nel 2007 e il 10,16% nel 2008) rispetto alla media degli altri Stati membri (tra 0,1% e 2%). Secondo i dati OCSE, dal 2011 si sono estinti per prescrizione oltre il 62% dei procedimenti per corruzione transnazionale (30 su 47).
2. Confronto con gli Altri Stati Membri e Raccomandazioni
Il testo evidenzia un netto divario tra il tasso di prescrizione nei reati di corruzione in Italia e la media degli altri Stati membri dell'UE. Mentre in Italia la percentuale di procedimenti estinti per prescrizione è significativamente elevata (intorno al 10-11% nel periodo 2007-2008, e oltre il 62% per la corruzione transnazionale dal 2011), negli altri paesi analizzati si registra un tasso molto inferiore (tra lo 0,1% e il 2%). Questa differenza significativa mette in luce una criticità del sistema giudiziario italiano nel contrastare efficacemente i reati di corruzione. Le preoccupazioni espresse dal GRECO e dall'OCSE tra il 2009 e il 2013, riguardo alla situazione italiana, sottolineano la necessità di una riforma della normativa sulla prescrizione. La revisione della normativa sulla prescrizione è stata inclusa nelle raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Italia dal Consiglio a luglio 2013, evidenziando l’importanza di questa riforma per rafforzare il quadro giuridico di contrasto alla corruzione. Il documento evidenzia, dunque, l’urgenza di una riforma legislativa per colmare questo divario con gli altri Stati membri e migliorare l’efficacia della lotta alla corruzione.
VIII.Competenza della Procura Europea e Garanzie Fondamentali
Si analizza la competenza della Procura europea (EPPO) riguardo ai reati lesivi degli interessi finanziari dell'UE. Il documento esamina l'articolo 86 TFUE, che prevede la possibilità di creare una Procura europea, e la sua competenza potenziale anche per altri reati gravi a dimensione transnazionale. Viene sottolineata l'importanza della compatibilità dell’azione dell'EPPO con le garanzie fondamentali, in particolare con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la CEDU, e la questione del principio di ne bis in idem.
1. Competenza della Procura Europea Definizione e Ambito
La sezione affronta la competenza della Procura Europea (EPPO), prevista dall'articolo 86 TFUE. Il documento evidenzia che l'EPPO non è istituita direttamente dal Trattato, ma la sua creazione è prevista come regolamento dell'Unione adottato con procedura legislativa speciale (delibera all'unanimità del Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo). Inizialmente focalizzata sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la sua competenza potrebbe estendersi al contrasto di criminalità grave a dimensione transnazionale, secondo il paragrafo 4 dell'articolo 86 TFUE. Questo ampliamento non è limitato ai reati specificati nell'articolo 83, paragrafo 1, ma include reati con ripercussioni in più Stati membri. L'articolo 86 TFUE, collocando la base giuridica nel capo IV del titolo V TFUE, giustifica la potenziale competenza dell’EPPO anche al di là dei reati specificatamente legati agli interessi finanziari. La vaghezza della disposizione sull’estensione delle competenze dell’EPPO, lascia spazio ad interpretazioni diverse e solleva perplessità sulla legittimazione democratica del processo decisionale, soprattutto per l’adozione del regolamento all’unanimità del Consiglio.
2. Garanzie Fondamentali e Rapporto con Diritto Nazionale e Internazionale
Il documento analizza il rapporto tra la competenza della Procura Europea e le garanzie fondamentali, facendo riferimento alla Carta di Nizza e alla CEDU. L'articolo 52, paragrafo 1, della Carta di Nizza prevede una riserva di legge per le limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà, in ossequio al principio di proporzionalità e solo in caso di necessità per tutelare interessi generali o diritti altrui. Gli articoli 53 e 54 della Carta di Nizza pongono dei divieti relativi alle tutele interne ed esterne alla Carta stessa, evitando la distruzione o la limitazione eccessiva dei diritti e delle libertà riconosciuti. L'articolo 53, in particolare, sottolinea il coordinamento tra la Carta di Nizza e altre fonti di tutela dei diritti fondamentali (diritto dell'Unione, diritto internazionale, CEDU e Costituzioni nazionali). La giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamando la sentenza Costa/ENEL, afferma il primato del diritto comunitario, anche in contrasto con norme nazionali di rango costituzionale, a garanzia del funzionamento dell'Unione Europea. L’interpretazione dell’articolo 53 della Carta, secondo la Corte, non può ledere il primato del diritto dell’Unione nell’attuazione del diritto comunitario, ridimensionando la possibilità di applicare standard nazionali superiori a quelli della Carta stessa.
3. Competenza Concorrente e Ne bis in idem
La sezione affronta la questione della competenza concorrente della Procura Europea con le autorità nazionali, in particolare in relazione al principio del ne bis in idem. L'articolo 13 della proposta di regolamento prevede che l'EPPO possa indagare anche su reati diversi, ma strettamente collegati a quelli lesivi degli interessi finanziari comunitari, a condizione che questi ultimi siano prevalenti, basati sugli stessi fatti e che l'investigazione congiunta sia funzionale ad una buona amministrazione della giustizia. In caso contrario, la competenza spetta alle autorità nazionali. Questa disposizione, potenzialmente problematica in sede applicativa, lascia ai giudici nazionali la decisione finale sulla competenza, decisione insuscettibile di impugnazione in sede superiore europea. Il principio del ne bis in idem, fondamentale per evitare la doppia punizione per lo stesso fatto, viene menzionato in relazione alla possibilità di una persecuzione congiunta da parte della Procura Europea e delle autorità nazionali, che potrebbe portare a risparmi di tempo e costi, ma anche a complicazioni procedurali in caso di conflitti di competenza.
