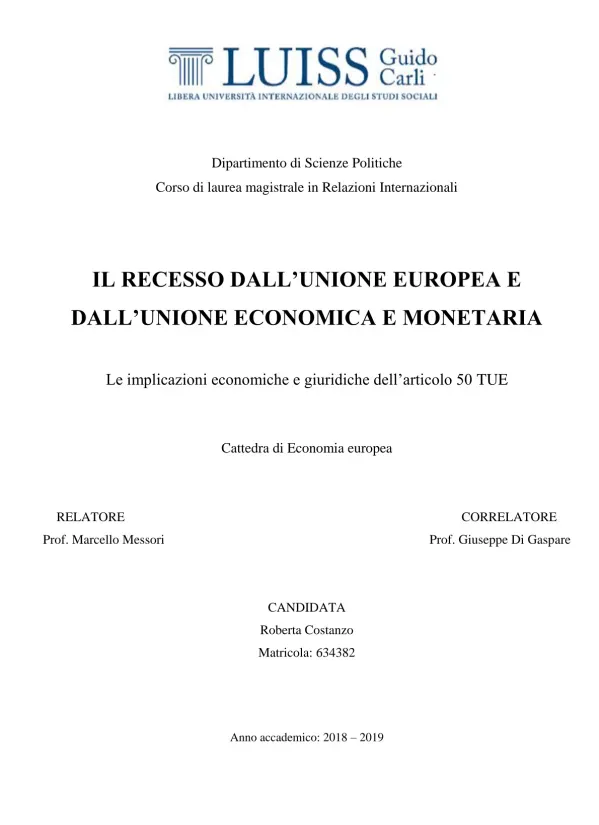
Recesso UE: Art. 50 TUE e Brexit
Informazioni sul documento
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 1.31 MB |
Riassunto
I.Il Quadro Giuridico dell Unione Europea e dell UEM Articolo 50 TUE e la Clausola di Recesso
Questo capitolo analizza il quadro giuridico dell'Unione Europea (UE) e dell'Unione Economica e Monetaria (UEM), focalizzandosi sul meccanismo di adesione (articolo 49 TUE e criteri di Copenaghen) e, soprattutto, sul recesso. Prima del Trattato di Lisbona (2009), l'ipotesi di uscita dall'UE non era contemplata; l'introduzione dell'articolo 50 TUE, con la sua clausola di recesso, ha colmato questa lacuna, pur lasciando aperte diverse problematiche, soprattutto per quanto riguarda l'uscita dall'area Eurozona. La Brexit, con l'attivazione dell'articolo 50 da parte del Regno Unito il 29 marzo 2017, ha messo in luce queste ambiguità, in particolare l'assenza di riferimenti all'abbandono dell'unione monetaria.
1. L introduzione dell articolo 50 TUE e le sue implicazioni
L'articolo 50 del Trattato sull'Unione Europea (TUE) ha introdotto, per la prima volta, una clausola di recesso dall'Unione Europea, colmando un vuoto giuridico precedente. Prima del 2009, infatti, i Trattati non contemplavano l'ipotesi di uscita, rendendola possibile solo attraverso una forma negoziata. L'articolo 50 ha preparato istituzionalmente l'Unione ad affrontare l'eventuale volontà di uscita di uno dei suoi membri. Tuttavia, la sua applicazione ha rivelato numerose problematiche, emerse in modo evidente con l'attivazione della clausola da parte del Regno Unito nel marzo 2017. Una delle principali lacune è l'assenza di riferimenti all'uscita dall'unione monetaria, lasciando incerto se uno Stato possa abbandonare l'euro e a quali condizioni. Questa incertezza è alimentata dalla crescente sfiducia nell'euro in alcuni Stati membri, rendendo l'abbandono della moneta unica un tema di propaganda politica.
2. Meccanismi di adesione e recesso un confronto
Il capitolo analizza i meccanismi di adesione all'UE (articolo 49 TUE e criteri di Copenaghen) e all'Eurozona (articolo 140 TFUE e parametri di Maastricht), evidenziando come l'accesso e il recesso non siano speculari. La previsione di una clausola di recesso è relativamente recente, introdotta solo con il Trattato di Lisbona del 2009. Il capitolo utilizza il 2009 come spartiacque per descrivere i meccanismi di recesso: prima del 2009, l'uscita era possibile solo in forma negoziata (es. Groenlandia), mentre dopo l'entrata in vigore dell'articolo 50 TUE, il recesso è diventato possibile anche unilateralmente. L'analisi approfondisce la lettera dell'articolo 50 e il dibattito giuridico sull'assenza di riferimenti specifici all'uscita dall'area monetaria. Il processo di allargamento dell'UE, con i suoi sette round che hanno portato il numero degli Stati membri da 6 a 28, viene brevemente riassunto, così come lo status degli Stati membri dell'UE che non fanno parte dell'Eurozona.
3. L evoluzione dell integrazione monetaria europea
La sezione ripercorre le tappe fondamentali dell'integrazione monetaria europea, partendo dal Serpente Monetario Europeo (1972), istituito in risposta alla crisi di Bretton Woods. Si prosegue con la descrizione delle tre fasi dell'Unione Monetaria Europea (UEM), sottolineando le innovazioni istituzionali introdotte dal Trattato di Maastricht, l'istituzione dell'Istituto Monetario Europeo (IME) e del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC). Si evidenzia il ruolo cruciale del 1998, anno in cui il Consiglio europeo decise l'adozione dell'euro da parte di undici Stati membri che soddisfacevano i parametri di Maastricht, e la fissazione dei tassi di conversione irrevocabili. Si descrive la prima fase (1990-1993), focalizzandosi sulla crisi dello SME del 1992, con l'uscita della lira italiana e della sterlina inglese, e l'allargamento della banda di oscillazione dell'ERM. Viene inoltre evidenziato il valore strumentale dell'UEM nel rafforzare l'integrazione tra gli Stati membri, completare il mercato unico e ridurre i costi di transazione.
II.La Brexit Un Caso Studio sull Applicazione dell Articolo 50 TUE
Questo capitolo esamina la Brexit come caso studio dell'applicazione dell'articolo 50 TUE. Si analizzano le difficoltà incontrate nel processo di recesso del Regno Unito, a partire dai ritardi nella notifica dell'intenzione di uscita (29 marzo 2017) fino alle controversie sulle strategie negoziali tra Londra e Bruxelles. L'accordo di recesso, pur raggiunto, è stato ostacolato da ripetuti rifiuti del Parlamento britannico, soprattutto a causa del problema del confine irlandese (backstop). Le figure chiave includono David Cameron (Primo Ministro durante il referendum), Theresa May e Boris Johnson (Primi Ministri durante le fasi negoziali della Brexit). Si sottolinea l'impatto economico della Brexit, con particolare attenzione alle conseguenze sul commercio e sugli investimenti diretti esteri (IDE).
1. Il Referendum e le sue immediate conseguenze
Il capitolo inizia descrivendo il contesto della Brexit, partendo dal referendum del 23 giugno 2016, che ha visto la vittoria del Leave. L'analisi evidenzia la mancanza di una discussione approfondita sulle modalità di recesso durante la campagna referendaria, creando incertezza sul percorso da seguire dopo il voto. Si sottolinea il ruolo di David Cameron, Primo Ministro all'epoca del referendum, che si è dimesso in seguito al risultato. La sua successione da parte di Theresa May, e la conseguente istituzione di due nuovi dipartimenti governativi (per l'uscita dall'UE e per il commercio internazionale), guidati rispettivamente da David Davis e Liam Fox, sono descritti come primi passi per affrontare la complessa situazione. Il ritardo nell'attivazione formale dell'articolo 50, avvenuta solo il 29 marzo 2017, è attribuito alla mancanza di chiarezza iniziale sulle procedure di recesso e alla necessità di un'autorizzazione parlamentare, confermata dalla Corte Suprema britannica nel gennaio 2017.
2. Incompatibilità delle strategie negoziali UK vs. UE
La sezione approfondisce le divergenze tra le strategie negoziali del Regno Unito e dell'Unione Europea durante il processo di Brexit. Il Libro Bianco del Regno Unito (“The United Kingdom’s exit from and new partnership with the European Union”), pubblicato nel febbraio 2017, proponeva la conclusione di tre accordi (libero scambio, doganale e sui diritti dei cittadini) prima del completamento del recesso. Questa strategia, mirante a una rapida definizione delle future relazioni, si scontrava con l'approccio graduale dell'UE, che prevedeva la conclusione dell'accordo di recesso prima di negoziare accordi sulle future relazioni. La lettera inviata da Theresa May a Donald Tusk, Presidente del Consiglio Europeo, che esprimeva il desiderio di concordare sui termini della partnership futura “accanto” a quelli del recesso, evidenzia questa incompatibilità. L'UE, sin dagli orientamenti del 29 aprile 2017, ha ribadito la sua intenzione di procedere per fasi, dedicando ogni round negoziale a una specifica questione.
3. Il Protocollo sull Irlanda e il Backstop
Un'attenzione particolare è dedicata al protocollo su Irlanda e Irlanda del Nord, incluso nell'accordo di recesso. Questo protocollo mirava ad evitare la ricostituzione di un confine fisico tra la Repubblica d'Irlanda (UE) e l'Irlanda del Nord (Regno Unito), per ragioni sia economiche (grandi flussi di merci e persone) che politiche (mantenimento dell'accordo del Venerdì Santo). La questione del confine irlandese è stata uno dei principali punti di attrito nei negoziati, rappresentando un ostacolo all'approvazione dell'accordo da parte del Parlamento britannico. L'accordo prevedeva la creazione di un 'single custom territory', un'area doganale comune tra Irlanda e Irlanda del Nord, con quest'ultima di fatto rimasta nel mercato unico dell'UE. Il meccanismo del 'backstop', ovvero una rete di protezione che avrebbe mantenuto questo stato di cose in assenza di un accordo sulle future relazioni, ha generato notevoli controversie.
4. L Impasse Politica e le Conseguenze Economiche
La sezione evidenzia le dimissioni di Theresa May nel giugno 2019 e la successiva ascesa di Boris Johnson, che ha cercato di rinegoziare l'accordo di recesso, dichiarandolo 'inaccettabile'. L'UE ha ribadito l'irrinunciabilità dell'accordo, rendendo plausibile uno scenario di 'no deal'. Il rifiuto del Parlamento britannico al pacchetto negoziato da Theresa May è attribuito a divergenze interne al Regno Unito. Il capitolo accenna alle gravi conseguenze economiche di uno scenario di 'no deal', con l'applicazione delle regole dell'OMC e l'aumento delle barriere tariffarie e non tariffarie, soprattutto per il commercio di servizi. L'incertezza sulle future relazioni commerciali tra Londra e Bruxelles, secondo uno studio della LSE, potrebbe portare a un drastico calo degli investimenti diretti esteri nel Regno Unito, a causa dell'uscita dal mercato unico e dall'unione doganale, della maggiore complessità nella gestione delle catene di fornitura e della mancanza di certezze per gli investitori.
III.L Uscita dall Eurozona Scenari e Conseguenze
Questo capitolo affronta l'ipotesi, sempre più dibattuta, dell'uscita di uno Stato membro dall'Eurozona. Si distinguono due scenari: l'uscita dall'UE e dall'UEM (come nel caso di un'ipotetica Grexit o Italexit) e l'uscita dall'UEM rimanendo nell'UE. Si analizzano le implicazioni economiche di entrambi gli scenari, evidenziando le difficoltà legate alla ridenominazione del debito, alla gestione del settore bancario e alla possibile svalutazione della nuova valuta. La crisi economica greca (Grexit), con i suoi piani di salvataggio e le politiche di austerità, viene esaminata come esempio dei potenziali rischi. Si analizza anche la situazione dell'Italia e il dibattito sul possibile abbandono dell'euro, con riferimento ai parametri di Maastricht e alla relazione Commissione Europea-Italia del 2019.
1. Uscita permanente o temporanea dall Eurozona due scenari
Il capitolo inizia analizzando l'ipotesi di uscita dall'Eurozona, distinguendo tra un'uscita permanente e una temporanea. Un'uscita permanente, se accompagnata da un'uscita dall'UE, sarebbe meno complessa dal punto di vista procedurale, potendo attivare l'articolo 50 TUE e negoziare un accordo di recesso. Un esperto di diritto UE, Peadar o Broin, indica cinque elementi cruciali per un accordo di recesso: gradualità, controlli sui capitali, limiti alla fluttuazione del tasso di cambio, riallocazione delle attività di riserva e ridenominazione del debito. Un'uscita dall'Eurozona rimanendo nell'UE, invece, presenta maggiori complicazioni, in quanto non sono chiare le modalità giuridiche e le conseguenze economiche. La crisi finanziaria del 2007-2009 ha alimentato lo scetticismo sull'euro in molti Stati membri, rendendo l'abbandono della moneta unica un tema di dibattito politico rilevante.
2. La crisi greca e l ipotesi di una Grexit
La crisi del debito sovrano greco del 2009-2018 è analizzata come un caso emblematico. La Grecia, entrata nell'Eurozona nel 2001, ha beneficiato di tassi di interesse bassi, ma una cattiva gestione delle finanze pubbliche e la falsificazione dei conti hanno portato a una grave crisi. L'Europa ha risposto con quattro programmi di aiuto (2010-2018), combinando salvataggi e misure di austerità. Nel 2015, si è discussa l'ipotesi di una Grexit (uscita dalla moneta unica), scongiurata poi da un accordo tra Grecia e creditori. Nonostante lo scongiuramento, l'ipotesi ha avuto un doppio merito: ha rotto il tabù dell'irreversibilità dell'adesione all'euro e ha suggerito l'idea che un'uscita temporanea potrebbe consentire la svalutazione della valuta, il rilancio dell'economia tramite le esportazioni e una ristrutturazione del debito. Tuttavia, gli effetti economici di un'uscita temporanea sono complessi e richiedono un'analisi più dettagliata.
3. L Italia e il rischio di Italexit
La sezione approfondisce la situazione italiana, caratterizzata da un elevato rapporto debito pubblico/PIL e da una crisi del settore bancario legata alla crisi del debito sovrano. L'Italia è entrata nell'Eurozona nel 1999 con un debito pubblico superiore al 100% del PIL, pur non rispettando pienamente i parametri di Maastricht. Tra il 2011 e il 2012, la speculazione sui mercati ha fatto emergere il rischio di Italexit, scongiurato dalla promessa di Mario Draghi (allora governatore della BCE) di fare 'tutto il necessario per salvare l'euro'. La crisi ha avuto un impatto devastante sull'economia italiana, con una forte contrazione della crescita, dei consumi e degli investimenti, un aumento del debito pubblico e della disoccupazione. La sezione evidenzia la divisione dell'opinione pubblica e politica italiana sui vantaggi e gli svantaggi dell'euro, con alcuni che considerano l'euro una fonte di stabilità e altri che ne vedono la causa principale delle difficoltà economiche del paese. La relazione della Commissione Europea del 2019, che ha innescato una procedura di infrazione per debito eccessivo, viene menzionata brevemente.
4. Conseguenze economiche di un uscita temporanea dall euro es. l Italia
Questa parte si concentra sulle conseguenze economiche di un'uscita temporanea dall'euro, considerata più realistica e vantaggiosa rispetto a un'uscita permanente. Un'uscita temporanea consentirebbe, in linea di principio, di riappropriarsi della politica monetaria e di svalutare la nuova valuta (ad esempio, una 'euro-lira' per l'Italia) per rilanciare l'economia attraverso le esportazioni. Tuttavia, la svalutazione, nell'era della globalizzazione e delle global value chains, avrebbe un impatto ambiguo: aumenterebbe le esportazioni di prodotti finiti, ma anche il prezzo degli input importati, generando inflazione e diseguaglianze. La gestione del debito pubblico pregresso in euro diventerebbe estremamente difficile, con il rischio di insolvenza e di perdita di fiducia dei mercati. Il settore bancario si troverebbe in gravi difficoltà, con la possibilità di una crisi di liquidità e un credit crunch. Questi elementi suggeriscono che neanche l'uscita temporanea rappresenta un'opzione economicamente credibile.
5. Possibilità di una Deroga Forzata dall Eurozona
L'ultima parte del capitolo affronta la questione controversa della possibilità per l'Europa di imporre una sorta di 'deroga' o 'sospensione' temporanea della partecipazione di uno Stato membro all'Eurozona in caso di mancato rispetto dei parametri di Maastricht. Questo tema è emerso concretamente nel 2015 con la proposta del ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schäuble alla Grecia. La proposta, poi ritirata, ha comunque avuto il merito di rompere il tabù dell'irreversibilità dell'adesione all'euro e di sollevare la questione della possibilità di svalutazione temporanea per rilanciare l'economia. L'analisi evidenzia tre principali ragioni per cui un'uscita, anche temporanea, dall'euro non è un'opzione economicamente credibile: l'impatto ambiguo della svalutazione in un contesto di globalizzazione, la difficoltà di gestire il debito pregresso e la conseguente crisi bancaria.
