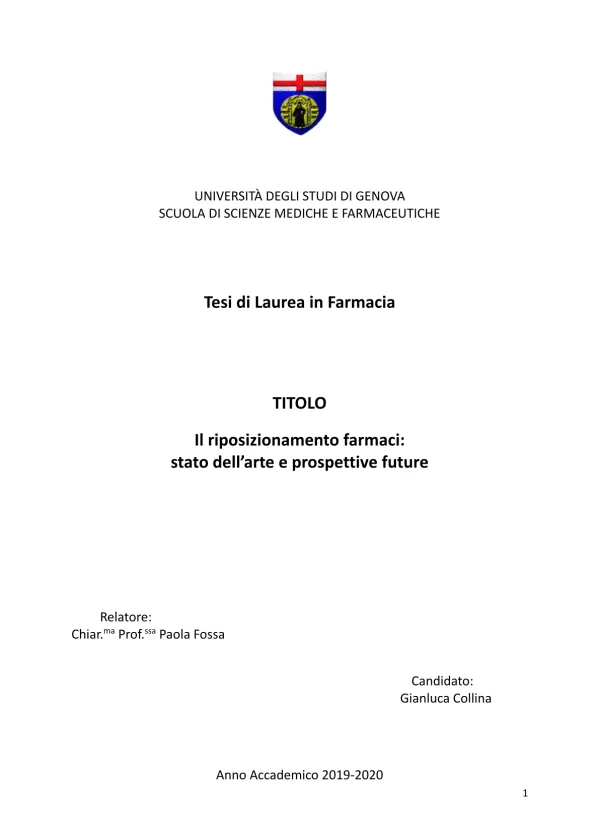
Riposizionamento Farmaci: Stato dell'Arte
Informazioni sul documento
| Scuola | Università Degli Studi Di Genova, Scuola Di Scienze Mediche E Farmaceutiche |
| Specialità | Farmacia |
| Tipo di documento | Tesi Di Laurea |
| Luogo | Genova |
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 1.61 MB |
Riassunto
I.L Alto Costo e la Bassa Efficacia dello Sviluppo di Nuovi Farmaci
Lo sviluppo e l'approvazione di un nuovo farmaco è un processo lungo e costoso, che richiede dai 10 ai 15 anni e un investimento di quasi 1,2 miliardi di dollari, arrivando anche a 2-3 miliardi per singola molecola. Nonostante l'aumento degli investimenti in Ricerca e Sviluppo (R&S), il numero di nuovi farmaci approvati è drasticamente diminuito, con solo 22 nuovi farmaci approvati tra il 2014 e il 2016 rispetto ai 53 di due decenni prima. Questo evidenzia l'elevata percentuale di fallimento e le sfide che l'industria farmaceutica globale deve affrontare, rendendo il settore potenzialmente poco attraente per gli investitori a causa del basso ritorno sull'investimento in R&S.
1.1. L elevato costo dello sviluppo farmaceutico
Il processo di sviluppo e approvazione di un nuovo farmaco è estremamente lungo e costoso, richiedendo dai 10 ai 15 anni e un investimento che si aggira attorno a 1,2 miliardi di dollari, con punte che possono raggiungere i 2-3 miliardi per singola molecola. Questa cifra rappresenta un investimento significativo per le aziende farmaceutiche, che negli anni '90 destinavano circa 16 miliardi di dollari all'anno in Ricerca e Sviluppo (R&S), cifra salita a 40 miliardi nel decennio successivo e con proiezioni che supereranno i 100 miliardi in futuro. L'enorme spesa in R&S non si traduce proporzionalmente in un aumento dei farmaci approvati, anzi, si osserva una diminuzione: tra il 2014 e il 2016 sono stati approvati solo 22 nuovi farmaci, un numero nettamente inferiore ai 53 approvati due decenni prima. Questo divario tra investimento e risultati evidenzia l'elevato rischio di fallimento in questa fase e la complessità del processo di sviluppo farmaceutico.
1.2. Le sfide dell industria farmaceutica globale
L'industria farmaceutica globale deve affrontare numerose sfide che contribuiscono all'aumento dei costi e alla diminuzione del numero di farmaci approvati. Tra queste, spiccano le elevate percentuali di fallimento durante lo sviluppo, i tempi più lunghi per l'immissione sul mercato in alcune aree terapeutiche e l'evoluzione continua dei requisiti normativi. Questi fattori, combinati, incrementano significativamente i costi complessivi del processo. Si stima che per ogni dollaro speso in R&S, il guadagno sia inferiore a un dollaro, creando un'incertezza economica che potrebbe scoraggiare gli investimenti futuri nel settore. Il processo di approvazione di un farmaco per uso umano è complesso e richiede la valutazione preclinica di circa 5000 composti, dei quali solo 5 in media vengono selezionati per lo sviluppo clinico, dopo anni di ulteriori valutazioni. Questo lungo e selettivo percorso contribuisce ulteriormente all'alto costo e al basso numero di farmaci che raggiungono il mercato.
1.3. Implicazioni per gli investitori
Il basso ritorno sull'investimento in ricerca e sviluppo di nuovi farmaci, dovuto all'elevata percentuale di fallimenti, ai lunghi tempi di sviluppo e ai crescenti costi normativi, rappresenta una seria preoccupazione per gli investitori. Il rapporto costi-benefici attualmente sfavorevole potrebbe rendere l'industria farmaceutica meno attraente rispetto ad altri settori, con potenziali conseguenze negative per l'innovazione e lo sviluppo di nuove terapie. L'aumento esponenziale delle spese in R&S, senza un parallelo aumento del numero di farmaci approvati, rende necessario esplorare strategie più efficienti ed economiche per lo sviluppo di nuovi trattamenti. La necessità di un ritorno sull'investimento più consistente è quindi un fattore chiave per la sostenibilità e il futuro dell'industria farmaceutica.
II.Il Riposizionamento di Farmaci Una Strategia Più Efficiente
Il riposizionamento di farmaci, ovvero l'utilizzo di farmaci già approvati per trattare nuove patologie, rappresenta una strategia promettente per ridurre i costi e i tempi di sviluppo. Questo approccio, illustrato da esempi di successo come il sildenafil (Viagra) e la talidomide, presenta diversi vantaggi: minore rischio di fallimento, tempi di sviluppo ridotti e minori investimenti. La Celgene Corporation, ad esempio, ha registrato un fatturato di 8,2 miliardi di dollari nel 2017 con il lenalidomide, un derivato della talidomide.
2.1 Definizione e vantaggi del riposizionamento di farmaci
Il riposizionamento di farmaci consiste nell'identificare nuovi usi terapeutici per farmaci già approvati o in fase di sperimentazione, al di fuori della loro indicazione originale. Questa strategia offre notevoli vantaggi rispetto allo sviluppo di un farmaco completamente nuovo, riducendo significativamente i tempi e i costi del processo. In primo luogo, il rischio di fallimento è minore, poiché la sicurezza del farmaco è già stata parzialmente dimostrata in studi preclinici e, in alcuni casi, anche in studi clinici di Fase III sull'uomo. In secondo luogo, i tempi di sviluppo si accorciano, dato che molti test preclinici, relativi alla sicurezza e allo sviluppo della formulazione, sono già stati completati. Infine, gli investimenti necessari sono inferiori, anche se la riduzione dei costi varia a seconda della fase di sviluppo in cui si trova il farmaco candidato. Mentre i costi di regolamentazione e della Fase III rimangono sostanzialmente invariati, si ottengono risparmi significativi nelle fasi precliniche e nelle prime fasi della sperimentazione clinica (Fase I e II).
2.2 Esempi di successo di riposizionamento farmaceutico
Diversi esempi di successo illustrano l'efficacia del riposizionamento di farmaci. La talidomide, inizialmente commercializzata come sedativo e poi ritirata a causa di gravi effetti collaterali, ha trovato successivamente un'applicazione efficace nel trattamento dell'eritema nodoso leproso e del mieloma multiplo. Il suo derivato, il lenalidomide (Revlimid®, Celgene Corporation), ha generato un fatturato globale di 8,2 miliardi di dollari nel 2017. Un altro esempio è il sildenafil, inizialmente sviluppato come antiipertensivo, poi riposizionato da Pfizer nel 2000 per il trattamento della disfunzione erettile (Viagra), raggiungendo una quota di mercato del 47% nel 2012, con un fatturato di circa 2,05 miliardi di dollari. Anche il metotrexato, approvato dalla FDA nel 1988 per il trattamento dell'artrite reumatoide, rappresenta un caso di successo di riposizionamento, diventando uno dei farmaci più prescritti al mondo. Questi esempi, pur non derivando da un approccio sistematico di ricerca, dimostrano il potenziale di questa strategia.
III.Approcci Computazionali per il Riposizionamento di Farmaci
L'analisi di grandi quantità di dati ha portato allo sviluppo di approcci computazionali, o in silico, per il riposizionamento di farmaci. Questi metodi sfruttano database come ChemBank, DrugBank, e Pubmed per identificare potenziali nuove indicazioni per farmaci esistenti, analizzando network biologici e utilizzando tecniche di text mining. Metodi come l'approccio di propagazione (locale e globale) e l'analisi di firme trascrittomiche (es. utilizzando la Connectivity Map del Broad Institute e il database LINCS del NIH) permettono di individuare correlazioni tra l'espressione genica di un farmaco e una malattia, suggerendo potenziali applicazioni terapeutiche. L'analisi degli effetti collaterali rappresenta un ulteriore strumento per identificare possibili nuove indicazioni.
3.1 Approcci in silico e l utilizzo di database
L'aumento esponenziale dei dati disponibili in ambito biomedico ha reso possibile lo sviluppo di approcci computazionali, definiti in silico, per il riposizionamento di farmaci. Questi approcci si basano sull'analisi integrata di informazioni provenienti da diverse fonti, tra cui ricerche, studi clinici e dati pubblicati, per identificare nuove connessioni tra farmaci e patologie. Vengono utilizzate diverse banche dati pubbliche, come ChemBank, DrugBank, la Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG), PubMed, Online Mendelian Inheritance in Animals (OMIA), Protein Data Bank (PDB), GenBank, Gene Expression Omnibus (GEO) e il Mammalian protein-protein interaction database. Attraverso metodi bioinformatici, si identificano i network di interazione tra target e farmaci, sfruttando la potenza del text mining per estrarre informazioni rilevanti dalla letteratura scientifica. L'integrazione di queste informazioni permette di individuare potenziali nuovi utilizzi di farmaci esistenti, riducendo i tempi e i costi tradizionalmente associati alla scoperta e allo sviluppo di nuovi farmaci.
3.2 Metodi di analisi basati su network e text mining
Gli approcci computazionali per il riposizionamento di farmaci comprendono diverse strategie, tra cui l'approccio di propagazione. Questo metodo sfrutta la struttura dei network biologici per individuare interazioni tra patologia e geni, tra diverse patologie e tra target e patologia. Esistono approcci locali, che estraggono informazioni da porzioni limitate del network, e approcci globali, che considerano l'intero network, ritenuti attualmente più efficaci. Il text mining rappresenta un'altra tecnica chiave, che consente di analizzare grandi quantità di testo (pubblicazioni scientifiche) per estrarre informazioni utili e identificare connessioni farmaco-target. Le tecniche di elaborazione del linguaggio naturale (Natural Language Processing, NLP) giocano un ruolo fondamentale nello sviluppo di strumenti per il text mining, migliorando la capacità di individuare farmaci riposizionabili.
3.3 Analisi di firme trascrittomiche e profili di effetti avversi
Un metodo promettente per il riposizionamento di farmaci è l'analisi delle firme trascrittomiche. Questa tecnica confronta il profilo di espressione genica di un campione biologico (cellula o tessuto) prima e dopo il trattamento con un farmaco, identificando la signature molecolare del farmaco. Questa signature viene poi confrontata con il profilo di espressione genica associato a una particolare malattia. Una correlazione negativa suggerisce un potenziale effetto terapeutico del farmaco sulla malattia. Questo approccio si basa sul principio della reversibilità della signature, ovvero la capacità del farmaco di ripristinare il profilo di espressione genica a uno stato più simile a quello sano. La Connectivity Map (cMap) del Broad Institute, con oltre 1,5 milioni di profili di espressione genica, è una risorsa fondamentale per questo tipo di analisi. Infine, l'analisi dei profili di effetti avversi, relativamente unici per ogni farmaco, può essere utilizzata come metodo di confronto tra farmaci o per individuare analogie tra gli effetti avversi di un farmaco e il fenotipo di una malattia, suggerendo potenziali target terapeutici comuni.
IV.Database e Strumenti per il Riposizionamento di Farmaci
L'efficacia degli approcci computazionali per il riposizionamento farmaceutico dipende fortemente dalla qualità e dalla disponibilità dei database. L'analisi di pubblicazioni su PubMed, utilizzando le parole chiave "drug repurposing or repositioning", mostra una forte correlazione tra il numero di pubblicazioni e la disponibilità di database specializzati. Le caratteristiche importanti di un database includono capacità di ricerca avanzata, query specifiche (anche tramite SQL), possibilità di full download dei dati e informazioni aggiuntive come dati GWAS/PheWAS, informazioni sulle vie metaboliche e sui lncRNA. Alcuni database menzionati includono DrugBank, The Health Improvement Network (THIN), Drug Repurposing Hub (DHUB), e il Tuberculosis Database.
V.Applicazione del Riposizionamento di Farmaci a Diverse Patologie
Il documento presenta esempi di riposizionamento di farmaci in diverse aree terapeutiche, tra cui: il sistema nervoso centrale (disturbo depressivo maggiore, morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson, sclerosi multipla), il cancro (tumori gastrointestinali, glioblastoma, leucemia mieloide acuta), malattie infettive (virus dell'encefalite giapponese, tubercolosi, infezione da Staphylococcus aureus, virus della dengue), e altre patologie (fibrosi polmonare, malattie cutanee). Vengono descritti studi specifici e i risultati ottenuti, sottolineando il potenziale di questa strategia per affrontare malattie con opzioni terapeutiche limitate.
VI.Riposizionamento di Farmaci per la COVID 19
La pandemia di COVID-19 ha stimolato la ricerca sul riposizionamento di farmaci. Il documento menziona diversi farmaci antivirali (come lopinavir/ritonavir e remdesivir) e agenti immunomodulatori (come baricitinib) che sono stati proposti o studiati per il trattamento della malattia. Inoltre, vengono discussi farmaci antineoplastici come imatinib, il cui meccanismo d'azione potrebbe essere rilevante per contrastare l'infezione da SARS-CoV-2. La ricerca si concentra anche sull'inibizione delle citochine pro-infiammatorie, come l'IL-6, tramite farmaci come tocilizumab e siltuximab.
5.1 Panoramica sulla COVID 19 e la ricerca di farmaci
La pandemia di COVID-19, causata dal SARS-CoV-2, ha evidenziato l'urgente necessità di trovare trattamenti efficaci. Il virus, appartenente alla famiglia dei coronavirus, si manifesta con una sintomatologia variabile, da forme asintomatiche o paucisintomatiche a forme severe che richiedono supporto respiratorio, con possibile sepsi, shock settico e sindrome da disfunzione multiorgano. I sintomi più comuni includono febbre, tosse secca, mialgia, affaticamento e dispnea, mentre sintomi meno frequenti sono la produzione di espettorato, mal di testa, emottisi e diarrea. Le analisi di laboratorio possono evidenziare leucopenia, linfopenia e trombocitopenia. La ricerca di nuovi trattamenti si concentra su diverse strategie, tra cui il riposizionamento di farmaci già esistenti, approccio che offre vantaggi in termini di tempo e costi rispetto allo sviluppo di nuove molecole.
5.2 Farmaci antivirali riposizionati contro la COVID 19
L'associazione lopinavir/ritonavir, efficace contro la SARS e la MERS, ha mostrato scarso o nullo effetto sulla COVID-19. La sua inefficacia è probabilmente dovuta alla diversa struttura delle proteasi virali. Il remdesivir, un farmaco antivirale ad ampio spettro sviluppato contro il virus Ebola, ha dimostrato efficacia in silico contro l'RNA polimerasi RNA-dipendente del SARS-CoV-2. Il farmaco agisce interferendo con l'azione della RNA polimerasi virale dopo l'ingresso del virus nella cellula ospite. Altre strategie mirano a bloccare l'ingresso del virus nelle cellule bersaglio. Il baricitinib, inibitore delle chinasi JAK e della proteina chinasi 1 associata ad Ap2 (coinvolte nell'endocitosi mediata da clatrina), può interferire con la penetrazione virale e, contemporaneamente, inibire il rilascio di citochine attraverso la via di segnalazione JAK-STAT, riducendo l'infiammazione. La città di Wuhan, in Cina, è stata l'epicentro dell'epidemia iniziale di COVID-19.
5.3 Inibizione delle citochine e agenti antineoplastici
Nei casi più gravi di COVID-19 si osserva una tempesta di citochine, con un eccessivo rilascio di interleuchine (IL-2, IL-7, IL-10), fattore di crescita stimolante le colonie granulocitiche, interferone-γ inducibile, chemokina 2, proteina infiammatoria dei macrofagi e fattore di necrosi tumorale α (TNF-α). Questa risposta immunitaria eccessiva causa danni polmonari e fibrosi, con conseguenti disabilità a lungo termine. Per contrastare questo fenomeno, sono stati studiati diversi farmaci in grado di inibire le citochine, come il siltuximab (anti-IL-6), il tocilizumab (anti-IL-6), il sarilumab (anti-IL-6) e l'anakinra (antagonista del recettore dell'interleuchina-1). Anche alcuni farmaci antineoplastici sono stati proposti per la terapia della COVID-19, tra cui carfilzomib, bortezomib e imatinib, quest'ultimo inibitore delle chinasi Abl, che sembrano avere un ruolo nell'ingresso del virus nelle cellule.
