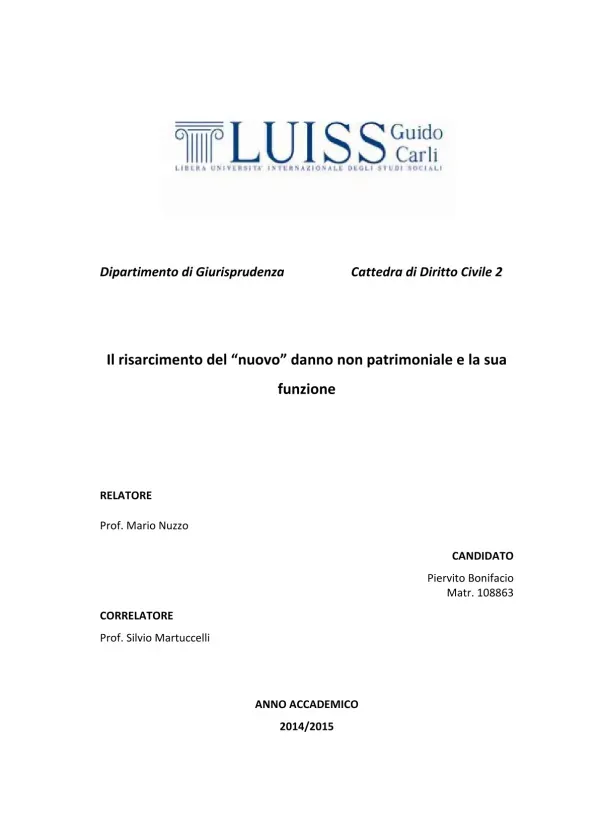
Risarcimento danno non patrimoniale: nuove prospettive
Informazioni sul documento
| Autore | Piervito Bonifacio |
| instructor/editor | Prof. Mario Nuzzo |
| school/university | Dipartimento di Giurisprudenza |
| subject/major | Diritto Civile |
| Tipo di documento | Tesi di Laurea |
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 1.16 MB |
Riassunto
I.Evoluzione del Risarcimento del Danno Non Patrimoniale in Italia
Questo documento analizza l'evoluzione del risarcimento del danno non patrimoniale nel diritto civile italiano, dal Codice Civile del 1865 al Codice Civile del 1942 e oltre, con particolare attenzione alle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2008 (le “sentenze di San Martino”). Inizialmente, il danno morale era risarcibile solo in casi eccezionali previsti dalla legge (ad esempio, art. 185 c.p.). La giurisprudenza, soprattutto dopo la Costituzione, ha ampliato notevolmente la nozione di danno non patrimoniale, includendo il danno biologico e il danno esistenziale, legando la risarcibilità alla lesione di interessi inerenti alla persona tutelati dalla Costituzione (art. 2 Cost.). Le sentenze del 2008 hanno chiarito che il danno non patrimoniale è una categoria unitaria, comprendente diverse voci (morale, biologico, esistenziale), risarcibili nei casi espressamente previsti dalla legge o quando vi sia lesione di diritti inviolabili della persona, richiedendo un’ingiusta lesione e un minimo di gravità dell'offesa per evitare le “liti bagatellari”. La liquidazione avviene tramite valutazione equitativa, spesso con riferimento alle tabelle milanesi per il danno biologico, ma con necessaria personalizzazione. Il documento analizza anche le diverse funzioni del risarcimento (riparatoria, punitiva, satisfattiva, solidaristica) e i criteri per la determinazione del quantum.
1. Il passaggio dal Codice Civile del 1865 al Codice Civile del 1942 l introduzione del risarcimento del danno non patrimoniale
L'analisi parte dal confronto tra il Codice Civile italiano del 1865 e quello del 1942, evidenziando una significativa innovazione: l'esplicita previsione del risarcimento del danno non patrimoniale. L'articolo 1151 del Codice del 1865, in linea con l'articolo 1383 del Code Civil francese, si limitava a indicare il danno come oggetto del risarcimento senza ulteriori specificazioni. Questa genericità portò parte della dottrina a sostenere la risarcibilità di qualsiasi pregiudizio, incluso il danno morale. La giurisprudenza, invece, prevalentemente ancorata alla tradizione romanistica, limitava il risarcimento alla sola perdita patrimoniale economicamente valutabile. Questa interpretazione, confermata da un passo di Gaio riportato nel Digesto, escludeva la risarcibilità del danno non patrimoniale per evitare una mercificazione della persona. L'introduzione del danno non patrimoniale nel Codice del 1942 rappresenta quindi un'importante rottura con questa tradizione, aprendo la strada a una più ampia tutela della persona.
2. Il Codice Penale del 1889 e successive modifiche l evoluzione della risarcibilità del danno non patrimoniale nel diritto penale
Il documento prosegue esaminando l'evoluzione della risarcibilità del danno non patrimoniale nel diritto penale. L'articolo 38 del Codice Penale del 1889 introduceva la riparazione in denaro per delitti contro l'onore, estesa poi ad altri reati da successive modifiche (art. 7, comma II, codice di procedura penale del 1913). L'articolo 185 del Codice Penale attualmente vigente sancisce espressamente l'obbligo di risarcire il danno patrimoniale o non patrimoniale causato da ogni reato, costituendo un'importante innovazione. Questa norma è rilevante sia per l'obbligo di risarcire il danno non patrimoniale derivante dal reato (senza possibilità di filtro da parte del giudice, salvo prova), sia per l'equiparazione terminologica tra risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Questo evidenzia un'evoluzione verso una maggiore tutela delle vittime di reato, indipendentemente dalla natura patrimoniale o meno del danno subito.
3. La natura dei danni non patrimoniali danno morale e la Relazione al Re
Il testo affronta la questione della definizione dei danni non patrimoniali, in particolare la distinzione tra danno morale e danni non patrimoniali in senso lato. La formula “danni non patrimoniali” del codice civile poteva far sorgere il dubbio di una definizione negativa, ossia l’esclusione dei danni con ripercussioni economiche (riconducibili all’art. 2043). Tuttavia, sin dalle prime fasi applicative, la giurisprudenza ha interpretato l'art. 2059 c.c. come riferito principalmente al danno morale, confermato dalla Relazione al Re che usa questa terminologia e non quella di “danni non patrimoniali”. L'art. 185 c.p., inoltre, sembrava avvalorare questa interpretazione, legando il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da reato ai patemi d’animo della vittima, specificando però che non tutti i patemi sono risarcibili, ma solo quelli conseguenti a reato. Questo passaggio evidenzia la stretta connessione iniziale tra risarcimento del danno non patrimoniale e reato.
4. Le diverse concezioni della responsabilità civile e le funzioni del risarcimento
Il documento presenta diverse concezioni della responsabilità civile e le relative implicazioni sulla funzione del risarcimento del danno non patrimoniale. Si passa da una concezione tradizionale, essenzialmente repressiva e sanzionatoria (modello liberista, “nessuna responsabilità senza colpa”), in cui la responsabilità civile aveva un carattere etico, fondata sulla colpa come manifestazione patologica della volontà, ad una più moderna, che considera anche aspetti riparatori e solidaristica. Vengono analizzate diverse teorie sulla funzione del risarcimento: punitivo-afflittiva (con critiche sulla impossibilità di compensare il dolore), consolatorio-satisfattiva (che mira a lenire la sofferenza), e solidaristica (che tutela la persona in quanto tale). L'evoluzione giurisprudenziale e normativa ha portato a un superamento della concezione puramente repressiva, verso una visione più complessa che integra diversi scopi del risarcimento, in relazione alle diverse tipologie di danno non patrimoniale.
II. 2059 c
L'art. 2059 c.c. è al centro dell'analisi, con particolare attenzione alla sua interpretazione costituzionalmente orientata. Il documento evidenzia il passaggio da una concezione tradizionale, che limitava il risarcimento del danno non patrimoniale ai casi di reato e al danno morale soggettivo, ad una più ampia visione che riconosce la risarcibilità di diversi tipi di danno non patrimoniale, legati alla lesione di diritti fondamentali della persona (art. 32 Cost. per la salute). Si discute la doppia soglia di ingiustizia introdotta dalle Sezioni Unite: ingiustizia generica nei casi espressamente previsti dalla legge (reato) e ingiustizia costituzionalmente qualificata negli altri casi. Viene analizzato il ruolo del giudice nell'interpretare la clausola generale di ingiustizia del danno, bilanciando il principio di solidarietà e quello di tolleranza nella valutazione della gravità dell'offesa e della serietà del danno, evitando così un’eccessiva dilatazione del risarcimento.
1. L articolo 2059 c.c. e la sua evoluzione interpretativa
L'articolo 2059 del codice civile italiano, che disciplina il risarcimento del danno non patrimoniale, è al centro dell'analisi. Inizialmente interpretato in modo restrittivo, limitando la risarcibilità al danno morale soggettivo conseguente a reato (art. 185 c.p.), l'articolo 2059 ha subito un'evoluzione interpretativa, influenzata dall'entrata in vigore della Costituzione e dalla giurisprudenza successiva. Questa evoluzione ha portato a un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, ampliando il concetto di danno non patrimoniale e la sua risarcibilità. Non si tratta più solo del danno morale conseguente a reato, ma della lesione di qualsiasi interesse inerente alla persona, costituzionalmente rilevante, anche in assenza di una specifica previsione di legge. L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. ha avuto un impatto significativo sulla giurisprudenza, modificando la tradizionale concezione della responsabilità civile.
2. L interpretazione costituzionalmente orientata e la doppia soglia di ingiustizia
L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 2059 c.c. ha introdotto il concetto di una “doppia soglia di ingiustizia”. Nei casi espressamente previsti dalla legge (come il reato, art. 185 c.p.), è sufficiente un'ingiustizia generica, come previsto dall'art. 2043 c.c. Al di fuori di questi casi, però, è necessaria un'ingiustizia costituzionalmente qualificata, cioè la lesione di un diritto inviolabile della persona, desumibile dal sistema costituzionale. Questa distinzione ha generato dibattito dottrinale e giurisprudenziale, ponendo interrogativi sulla coerenza interna dell'articolo 2059 c.c. e sul bilanciamento tra la tutela dei diritti inviolabili della persona e il principio di tolleranza sociale. La Corte Costituzionale ha contribuito a chiarire alcuni aspetti, ma alcuni dubbi interpretativi permangono. L'interpretazione costituzionalmente orientata cerca di conciliare la necessità di una tutela adeguata delle persone con la prevenzione di un eccessivo ampliamento della responsabilità civile.
3. La lesione di diritti inviolabili e la necessità di una ingiustizia costituzionalmente qualificata
Il documento approfondisce la relazione tra la lesione di diritti inviolabili della persona e il requisito dell'ingiustizia costituzionalmente qualificata, necessaria per il risarcimento del danno non patrimoniale al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Si sottolinea che la lesione di diritti inviolabili, spesso garantiti da norme costituzionali, comporta un obbligo risarcitorio. Il dibattito si concentra sulla configurazione dell'art. 2059 c.c. come norma a “doppia soglia di ingiustizia”, una questione che mette in discussione la coerenza interna della norma. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che, in alcuni casi, è sufficiente un’ingiustizia generica, mentre in altri è necessaria un’ingiustizia costituzionalmente qualificata. Questo aspetto solleva dubbi sulla discrezionalità del legislatore nell'ampliare le ipotesi di risarcibilità del danno non patrimoniale, e sui limiti di tale discrezionalità alla luce del principio di costituzionalità.
4. Il ruolo del giudice la gravità dell offesa la serietà del danno e le liti bagatellari
L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. attribuisce al giudice un ruolo fondamentale nella selezione degli interessi meritevoli di tutela risarcitoria. Per evitare l'arbitrio giudiziario e le cosiddette “liti bagatellari”, le Sezioni Unite hanno introdotto i filtri della gravità dell’offesa e della serietà del danno, come parametri per il bilanciamento tra solidarietà e tolleranza. Questo doppio filtro, però, si applica solo ai casi al di fuori di quelli espressamente previsti dalla legge, mentre per i reati il risarcimento è sempre ammesso. La presenza di questa “doppia soglia” solleva critiche sulla coerenza interna dell’art. 2059 c.c. e sul rischio di una tutela meno efficace per i diritti previsti a livello costituzionale. Il ruolo del giudice nella valutazione equitativa del danno diventa quindi centrale, ma necessita di chiare linee guida per garantire uniformità e coerenza nell’applicazione della legge.
III.Il Danno Morale Biologico ed Esistenziale Autonomia e Unitarietà
Il documento approfondisce le tre principali tipologie di danno non patrimoniale: il danno morale, inteso sia come sofferenza soggettiva che come lesione della dignità; il danno biologico, definito dalla legislazione in materia di assicurazioni (artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005); e il danno esistenziale, inteso come pregiudizio alla sfera relazionale della persona. Nonostante la distinzione tra queste categorie, le sentenze delle Sezioni Unite affermano l'unitarietà del danno non patrimoniale, ribadendo che si tratta di voci descrittive di un'unica categoria ampia ed onnicomprensiva. La valutazione del quantum deve considerare tutti gli aspetti del danno subito, evitando duplicazioni, pur riconoscendo una certa autonomia a ciascuna voce. Si discute anche del danno da morte e della sua rilevanza nella categoria del danno non patrimoniale.
IV.Criteri di Liquidazione e Ruolo del Giudice
La liquidazione del danno non patrimoniale avviene con valutazione equitativa, tenendo conto delle circostanze concrete. Le tabelle milanesi rappresentano un parametro di riferimento uniforme, soprattutto per il danno biologico, ma il giudice deve personalizzare la liquidazione, considerando la gravità del fatto e le condizioni soggettive del danneggiato. La giurisprudenza ha cercato di definire criteri per evitare l'arbitrio giudiziario, introducendo filtri di gravità e serietà del danno per escludere le liti bagatellari. Il documento evidenzia il delicato compito del giudice nel bilanciare la tutela del danneggiato con il principio di tolleranza, interpretare la norma in modo costituzionalmente orientato, e applicare i principi delle sentenze di San Martino e della giurisprudenza successiva.
1. La valutazione equitativa e il ruolo del giudice
La liquidazione del danno non patrimoniale avviene tramite valutazione equitativa, un processo che richiede al giudice una attenta considerazione di tutte le circostanze del caso concreto. Questo approccio, pur basandosi sul principio di equità, necessita di parametri uniformi per garantire la parità di trattamento tra i danneggiati. Il documento fa riferimento alle Tabelle milanesi come punto di riferimento per la liquidazione del danno biologico, pur sottolineando la necessità di una personalizzazione del risarcimento in base alle sofferenze effettivamente patite dal danneggiato. La valutazione equitativa è sindacabile in sede di legittimità, e la Corte di Cassazione, nella sua funzione nomofilattica, indica le Tabelle milanesi come parametro di riferimento “equo”. L’utilizzo del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005) è limitato ai danni derivanti dalla circolazione stradale, escludendosi l’applicazione analogica ad altre fattispecie.
2. Personalizzazione del risarcimento e criteri di liquidazione
La necessità di una personalizzazione del risarcimento, anche nell'ambito dell'utilizzo delle tabelle, è fortemente enfatizzata. Il giudice deve valutare la reale consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche del danneggiato, andando oltre eventuali meccanismi semplificativi automatici. Si evidenzia la difficoltà di quantificare la sofferenza soggettiva, elemento centrale del danno morale. L'articolo 138, comma 3, del d.lgs. 209/05, che prevede un incremento fino al 30% per il danno biologico in caso di significativa incidenza su aspetti dinamico-relazionali, viene analizzato nel caso in cui si accompagni a sofferenza morale. In questo caso, si pone il problema se il limite del 30% sia comunque applicabile o se il giudice possa procedere a una stima indipendente. Il documento evidenzia la mancanza di criteri specifici per quantificare la sofferenza soggettiva del danno morale e il rischio di undercompensation.
3. Il problema delle liti bagatellari e la soglia di tollerabilità
Il documento analizza il problema delle cosiddette “liti bagatellari”, cioè i casi in cui il danno non patrimoniale, pur esistente, presenta un'entità modesta, non superando una certa soglia di tollerabilità. Le Sezioni Unite del 2008, pur riconoscendo la necessità di evitare un’eccessiva dilatazione delle responsabilità, hanno introdotto il filtro della gravità dell'offesa e della serietà del danno per escludere questi casi dal risarcimento, limitando questo filtro alle lesioni di diritti inviolabili della persona al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Si sottolineano le critiche a questa impostazione, in quanto non vengono definiti criteri oggettivi per stabilire la soglia minima di risarcibilità, e si evidenzia la disparità di trattamento rispetto ai danni patrimoniali, dove anche danni di modesta entità sono risarcibili. L'analisi evidenzia la difficoltà di bilanciare la tutela della persona con il principio di tolleranza sociale.
4. Le sentenze del 2008 e successive un quadro ancora in evoluzione
Il documento conclude riassumendo l’impatto delle sentenze delle Sezioni Unite del 2008 (sentenze di San Martino) e la successiva giurisprudenza. Si sottolinea come queste sentenze, pur affermando l'unitarietà del danno non patrimoniale e individuando criteri per la liquidazione equitativa, abbiano lasciato aperti alcuni dubbi interpretativi, in particolare riguardo alla funzione del risarcimento per le diverse voci di danno. La sentenza n. 1361 del 2014, pur recependo gli orientamenti successivi, non risolve definitivamente le questioni, sottolineando la necessità di un ulteriore intervento chiarificatore delle Sezioni Unite. L'analisi evidenzia la complessità del sistema di liquidazione del danno non patrimoniale e il delicato compito del giudice nell’interpretazione e applicazione delle norme, in continua evoluzione giurisprudenziale.
