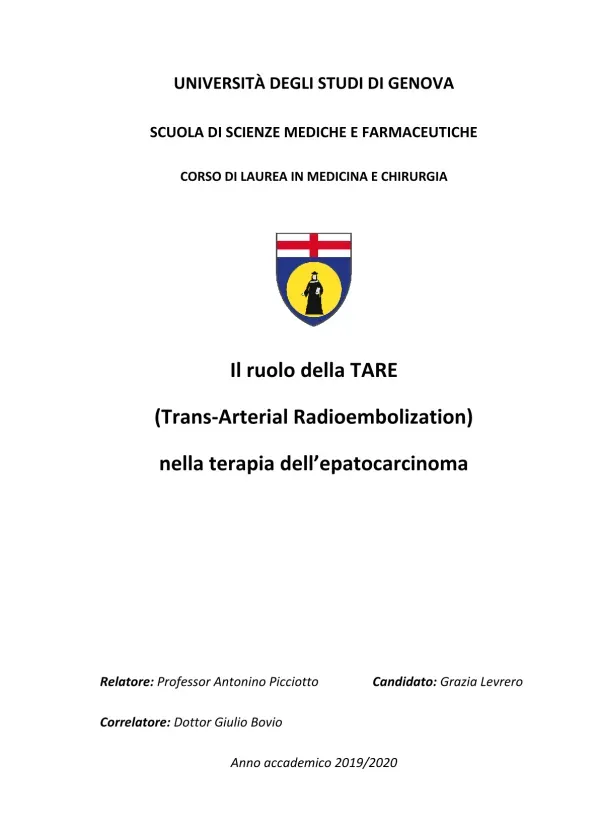
TARE per Epatocarcinoma: Trattamento e Risultati
Informazioni sul documento
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 1.23 MB |
Riassunto
I.Fattori di Rischio e Prevenzione del Carcinoma Epatocellulare HCC
Il carcinoma epatocellulare (HCC) è il tumore maligno primitivo del fegato più comune, con un'incidenza in aumento. La cirrosi epatica, causata da epatite B (HBV), epatite C (HCV) o steatoepatite non alcolica (NAFLD), è il principale fattore di rischio. La vaccinazione HBV, obbligatoria in Italia dal 1991, è fondamentale per la prevenzione. Altri fattori includono l'abuso di alcol e uno stile di vita non sano che porta a obesità e sindrome metabolica. La prevenzione si concentra sulla gestione delle epatopatie di base e sull'adozione di uno stile di vita sano.
1. Incidenza e Fattori di Rischio dell HCC
Il carcinoma epatocellulare (HCC) è il tumore maligno primitivo del fegato più frequente, con un'incidenza globale in costante aumento. Tra il 50% e il 70% dei casi viene diagnosticato in fase intermedia-avanzata, rendendo difficile l'applicazione di una terapia radicale. La cirrosi epatica rappresenta il principale fattore di rischio, sia di origine virale (epatite B e C) che non virale. L'infezione da virus dell'epatite B (HBV) è la causa principale a livello mondiale. Anche il virus dell'epatite C (HCV) e la steatoepatite non alcolica (NAFLD) possono contribuire allo sviluppo di HCC, anche se con minore frequenza, attraverso meccanismi che coinvolgono le specie reattive dell'ossigeno (ROS), l'alterazione dell'omeostasi lipidica epatocitaria e l'immunomodulazione. Questi ultimi due fattori, insieme all'abuso di alcol, contribuiscono all'insorgenza di cirrosi e, di conseguenza, ad un aumentato rischio di HCC. Il documento sottolinea l'importanza di prevenire lo sviluppo e la progressione dell'epatopatia di base verso la cirrosi come migliore strategia preventiva.
2. Ruolo della Vaccinazione contro l Epatite B
Data l'importanza dell'infezione da HBV come principale causa mondiale di HCC, la vaccinazione emerge come metodo di prevenzione efficace. Il rapporto costo-beneficio della vaccinazione è ampiamente riconosciuto e confermato da studi in numerosi paesi. In Italia, la vaccinazione contro l'HBV è obbligatoria per i neonati dal 1991, dimostrando un'alta efficacia nella prevenzione dell'infezione. L'incidenza è diminuita da 5,1 casi per 100.000 abitanti nel 1991 a 0,9 casi per 100.000 abitanti nel 2010. Attualmente, la vaccinazione è raccomandata anche per persone a rischio, come il personale sanitario, i viaggiatori in aree endemiche per l'HBV e le persone che convivono con portatori cronici di HBV. Questa misura preventiva rappresenta un intervento cruciale per ridurre l'incidenza di cirrosi e, di conseguenza, di HCC.
3. Prevenzione dell Abuso di Alcol e Stile di Vita Sano
Considerando che l'abuso di alcol è la terza causa importante di cirrosi, la prevenzione attraverso programmi di educazione sanitaria e riabilitazione per i pazienti che abusano di alcol rappresenta una strategia aggiuntiva per la riduzione dei casi di cirrosi e, conseguentemente, di HCC. Inoltre, l'adozione di uno stile di vita sano, che includa attività fisica regolare e un'alimentazione equilibrata, contribuisce alla prevenzione dell'obesità e della sindrome metabolica, fattori emergenti di primaria importanza nello sviluppo di HCC. Promuovere uno stile di vita salutare è quindi un'azione fondamentale per la prevenzione a lungo termine di questa patologia, mitigando i rischi correlati a fattori di rischio modificabili.
II.Diagnosi del Carcinoma Epatocellulare HCC
La diagnosi precoce di HCC è difficile a causa dei sintomi aspecifici nelle fasi iniziali. Tecniche di imaging come l'ecografia, la tomografia computerizzata (TC) e la risonanza magnetica (RM), spesso con mezzo di contrasto, sono cruciali per l'individuazione di lesioni. L'alfa-fetoproteina (αFP) è un biomarcatore, ma la sua sensibilità e specificità sono limitate. L'agobiopsia ecoguidata è necessaria per la conferma istologica.
1. Aspetti Clinici e Difficoltà Diagnostiche
I sintomi clinici dell'HCC nelle fasi iniziali sono spesso aspecifici e sovrapponibili a quelli dell'epatopatia di base, rendendo difficile la diagnosi precoce. Per manifestare sintomi significativi, il tumore deve spesso raggiungere dimensioni considerevoli, arrivando a uno stadio avanzato. In questo stadio, i sintomi possono essere anche dovuti a eventuali metastasi. La considerevole capacità di riserva del fegato fa sì che l'insufficienza epatica si manifesti solo quando gran parte del parenchima è compromesso. I sintomi classici includono malessere generale, astenia, dolore sordo all'ipocondrio destro e all'epigastrio, senso di distensione addominale, febbre, anoressia, senso di ripienezza postprandiale e calo ponderale. Sintomi meno frequenti, legati alla localizzazione del tumore, possono essere ittero (compressione della via biliare) e forti dolori addominali (distensione della capsula di Glisson o coinvolgimento del peritoneo). Anche i reperti obiettivi sono aspecifici e simili a quelli dell'epatopatia di base, enfatizzando ulteriormente la sfida nella diagnosi precoce di HCC.
2. Ruolo delle Tecniche di Imaging
Le tecniche di imaging giocano un ruolo fondamentale nella diagnosi di HCC. L'ecografia, grazie alla sua elevata riproducibilità, permette di identificare lesioni anche minori di 1-2 cm e di evidenziare caratteristiche tipiche dell'HCC, come la presenza di capsula, l'invasione della vena porta, delle vene epatiche o della vena cava superiore, e la presenza di shunt artero-venosi. Tuttavia, in pazienti con sindrome metabolica e obesità, l'abbondanza di tessuto adiposo addominale può ostacolare l'esame, impedendo la visualizzazione completa del fegato. Studi dimostrano che un BMI > 25 è associato a un fallimento della sorveglianza ecografica. In presenza di immagini non conclusive all'ecografia, si ricorre a tecniche più sofisticate come la tomografia computerizzata (TC) o la risonanza magnetica (RM) con mezzo di contrasto, per valutare l'ipervascolarizzazione arteriosa (wash-in) e la rapida eliminazione del contrasto (wash-out), caratteristiche tipiche dell'HCC in pazienti cirrotici. Se anche queste tecniche non forniscono immagini chiare, si procede all'agobiopsia ecoguidata per l'esame istologico. In pazienti non cirrotici, l'agobiopsia ecoguidata è la prima indagine indicata.
3. Il Biomarcatore Alfa Fetoproteina αFP
L'alfa-fetoproteina (αFP) è il biomarcatore più studiato per l'HCC. Livelli persistentemente elevati di αFP sono un fattore di rischio per lo sviluppo dell'HCC e possono aiutare a identificare popolazioni a rischio. Tuttavia, il dosaggio dell'αFP non è raccomandato per la sorveglianza perché la sua sensibilità e specificità sono inadeguate. Trova invece utilizzo come indice di risposta alla terapia e di recidiva. Il dosaggio ha valore diagnostico solo in pazienti cirrotici con nodulo epatico, se il valore supera i 200 ng/mL. In ogni caso, le linee guida raccomandano un ulteriore test diagnostico per confermare la diagnosi di tumore. L'utilizzo dell'αFP è dunque limitato principalmente alla valutazione post-trattamento e non alla diagnosi precoce.
III.Stadiazione e Prognosi dell HCC
La stadiazione dell'HCC, complessa a causa della coesistenza di tumore e cirrosi, considera fattori come il numero e le dimensioni delle lesioni, l'invasione vascolare, la funzione epatica (Child-Pugh) e lo stato generale del paziente (ECOG). La presenza di metastasi peggiora significativamente la prognosi.
1. La complessità della stadiazione dell HCC
La stadiazione dell'HCC, a differenza di altri tumori, presenta una complessità maggiore dovuta alla presenza quasi costante di due patologie distinte: il tumore stesso e la cirrosi epatica. Entrambe possono causare la morte del paziente, rendendo inadeguati i comuni criteri TNM (tumore primitivo, metastasi locoregionali e a distanza) per predire la sopravvivenza e guidare la scelta terapeutica. La presenza di cirrosi complica notevolmente la valutazione prognostica, richiedendo un approccio più complesso e una metodologia di stadiazione che tenga conto di entrambe le condizioni patologiche, influenzando la prognosi e le decisioni terapeutiche. Questo rende necessario un sistema di stadiazione più accurato e completo.
2. Fattori prognostici clinici nell HCC
Per una corretta stadiazione e prognosi dell'HCC, sono stati identificati diversi fattori prognostici clinici. Questi includono dati relativi al tumore stesso, come il numero, le dimensioni e la presenza di invasione vascolare macroscopica. Un altro fattore importante è la funzione epatica, spesso valutata tramite la classificazione Child-Pugh. Infine, lo stato generale del paziente, definito attraverso il performance status ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group), influenza la prognosi. L'eziologia del tumore, invece, non è risultata essere un fattore prognostico indipendente. L'integrazione di questi parametri permette una valutazione più accurata del rischio e una migliore personalizzazione delle strategie terapeutiche, tenendo conto delle caratteristiche individuali di ogni paziente.
IV.Opzioni Terapeutiche per l HCC
Le opzioni terapeutiche dipendono dalla stadiazione (BCLC). Le terapie curative includono la resezione epatica, il trapianto di fegato e le tecniche ablative (RFA, PEI). Per stadi più avanzati, si utilizzano la chemioembolizzazione transarteriosa (TACE) e la terapia sistemica (es. Sorafenib). La radioembolizzazione transarteriosa (TARE) con microsfere di Yttrio-90 (Y-90) emerge come opzione per tumori non resecabili, offrendo un profilo di tossicità ridotto rispetto alla TACE, ma con sopravvivenza simile. La scelta del trattamento considera anche la presenza di trombosi portale.
1. Opzioni Terapeutiche di Prima Linea per l HCC
Il documento indica cinque opzioni terapeutiche per l'HCC raccomandate nelle linee guida internazionali: la resezione epatica, il trapianto di fegato, le tecniche ablative, la chemioembolizzazione transarteriosa (TACE) e la terapia sistemica (come con Sorafenib). Le prime tre sono considerate opzioni curative, mentre le ultime due sono palliative. La scelta del trattamento dipende dalla stadiazione della neoplasia secondo i criteri del BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer). La resezione epatica è la terapia di elezione nei pazienti non cirrotici, con una sopravvivenza a 5 anni superiore al 50% grazie alla possibilità di asportare porzioni significative di fegato con basso rischio di insufficienza. L'indicazione alla resezione sta crescendo anche per pazienti con HCC e NAFLD (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease), con un potenziale curativo apparentemente superiore rispetto a casi dovuti ad infezioni virali. Tuttavia, le comorbidità associate a NAFLD e sindrome metabolica (dislipidemie, ipertensione, diabete, obesità, malattie cardiovascolari e respiratorie) possono influenzare negativamente la prognosi.
2. Tecniche Chirurgiche e Ablative
Le tecniche chirurgiche per la resezione epatica includono resezione parziale, subsegmentale, segmentale, di due segmenti, estesa di due segmenti o di tre segmenti. Considerata l'invasione del sistema portale da parte dell'epatocarcinoma, la chirurgia dovrebbe seguire i margini anatomici del segmento, rimuovendo tutto il parenchima vascolarizzato dallo stesso ramo portale per ridurre il rischio di metastasi. Le tecniche ablative, potenzialmente curative per stadi precoci non candidabili a resezione o trapianto, utilizzano calore, sostanze chimiche o basse temperature per distruggere le cellule tumorali. La termoablazione include radiofrequenze (RFA), laser e microonde (MWA), mentre la crioterapia impiega il raffreddamento. L'iniezione percutanea di etanolo (PEI) e di acido acetico (PAI) rappresentano forme di ablazione chimica. Tra le tecniche ablative, RFA e PEI sono le più diffuse. L'RFA presenta tassi di recidiva locale inferiori a PEI, grazie alla capacità di trattare anche tessuto apparentemente sano attorno al tumore. Sebbene i costi e i tempi di ospedalizzazione siano inferiori per le tecniche ablative rispetto alla resezione chirurgica, quest'ultima offre una valutazione istologica del rischio di recidiva, informazioni non disponibili con le tecniche ablative.
3. TACE Terapia Sistemica e Radioembolizzazione TARE
La chemioembolizzazione transarteriosa (TACE) e la terapia sistemica (es. Sorafenib) sono opzioni palliative utilizzate per stadi avanzati. La TACE è limitata dalla presenza di cirrosi e insufficienza epatica. Negli ultimi anni, i farmaci molecolari hanno aperto nuove prospettive. La radioembolizzazione transarteriosa (TARE) con microsfere di Yttrio-90 (Y-90) rappresenta un'opzione terapeutica emergente, soprattutto per tumori non resecabili. Studi retrospettivi mostrano una minore tossicità, migliore qualità di vita e maggior tempo alla progressione (TTP) rispetto alla TACE, con sopravvivenza equivalente. La TARE è considerata un'opzione terapeutica valida anche dalla Società Europea di Oncologia Medica (ESMO) e dal National Comprehensive Cancer Network (NCCN) in specifici casi. Trial clinici come SARAH suggeriscono una possibile alternativa al Sorafenib in pazienti con HCC avanzato e tossicità correlata al trattamento sistemico, ma sono necessari ulteriori studi per confermare questo dato.
V.Radioembolizzazione Transarteriosa TARE e Complicanze
La TARE sfrutta la diversa vascolarizzazione tra tumore e fegato sano. Le microsfere di Y-99 rilasciano radiazioni nel tumore. Le complicanze includono la malattia epatica radio-indotta (REILD) e la sindrome post-radioembolizzazione (PRS). Una pianificazione accurata e la profilassi sono cruciali per ridurre il rischio di complicanze. La TARE viene eseguita presso l'Ospedale Policlinico San Martino da oltre dieci anni, con un'esperienza significativa nel trattamento di HCC e metastasi epatiche, principalmente da tumori del colon-retto. I risultati mostrano una sopravvivenza media di 11,4 mesi (range 4,4 – 31,0) nei pazienti deceduti. Nei pazienti con trombosi portale, la sopravvivenza media è minore (15,5 mesi vs 20,6 mesi nei pazienti con vena porta pervia).
1. Meccanismo d Azione della TARE
La radioembolizzazione transarteriosa (TARE) sfrutta la differenza di vascolarizzazione tra il tumore epatico e il parenchima sano. I tumori epatici hanno una vascolarizzazione prevalentemente arteriosa, mentre il fegato sano dipende principalmente dal sistema portale (70-80%). Questo diverso pattern vascolare permette alle terapie loco-regionali transarteriose di somministrare alte dosi di radiazioni al tumore risparmiando il tessuto sano circostante. La TARE utilizza microsfere (TheraSphere© o SirSpheres©), che differiscono per dimensioni e attività, rilasciando radiazioni direttamente nel tumore. A differenza della TACE, la TARE non ha un effetto macroembolizzante; quindi, i benefici e gli effetti tossici dipendono dalle radiazioni rilasciate e non dall'effetto ischemico. L'approccio femorale è preferito per il minor rischio di complicanze, ma anche quello brachiale è possibile. Prima dell'infusione delle microsfere, viene eseguita un'angiografia per valutare la vascolarizzazione epatica e individuare eventuali anomalie vascolari. L'embolizzazione dell'arteria cistica non è ancora standardizzata.
2. Procedure e Valutazione Pre Trattamento
Prima della TARE, si esegue un'angiografia diagnostica per studiare l'aorta addominale, l'arteria mesenterica superiore e le arterie epatiche, identificando eventuali arterie accessorie. Si valuta anche la vena porta per verificarne la pervietà. Un obiettivo importante è la quantificazione di eventuali shunt epato-polmonari (LSF) usando 99mTc-MAA (macroaggregati di albumina marcati con tecnezio-99m), che, essendo simili alle microsfere per dimensioni, ne prevedono la distribuzione. Questo permette di valutare il rischio di polmonite radio-indotta. La distribuzione dei MAA può anche evidenziare una potenziale distribuzione al tratto gastrointestinale, segnalando il rischio di enterite radio-indotta. Il modello di partizione, basato sul modello MIRD, mira a massimizzare l'attività sul tumore, mantenendo dosi accettabili ai tessuti radiosensibili (polmone e fegato sano). Questo metodo è applicabile solo se le masse tumorali sono aree distinte, delineate come 'volumi di interesse' su uno studio SPECT-CT. La velocità di infusione delle microsfere deve imitare il flusso arterioso per evitare reflussi.
3. Complicanze della TARE e loro Gestione
Le complicanze della TARE comprendono la malattia epatica radio-indotta (REILD), la fibrosi epatica con ipertensione portale, ascesso epatico, bilioma intraepatico e infarto epatico. La REILD è un peggioramento della funzione epatica rispetto al pre-trattamento, in assenza di progressione tumorale, manifestandosi con sintomi (ascite, ittero, astenia) e alterazioni biochimiche (bilirubina, fosfatasi alcalina). La sindrome post-radioembolizzazione (PRS) è l'effetto avverso più frequente (20-55%), e un follow-up a due settimane è raccomandato. La prevenzione delle complicanze passa attraverso una attenta selezione dei pazienti. L'uso profilattico di inibitori di pompa protonica, antiemetici e analgesici è comune, con l'eventuale impiego di corticosteroidi in casi rari. Il trattamento delle complicanze è prevalentemente conservativo.
VI.Valutazione della Risposta al Trattamento
La valutazione della risposta al trattamento, per esempio dopo TARE o TACE, si basa sui criteri RECIST e mRECIST, che tengono conto della necrosi tumorale e della riduzione della vascolarizzazione, piuttosto che solo sulle dimensioni del nodulo. La tempistica ottimale per la valutazione della risposta è ancora dibattuta, ma generalmente si attende almeno 3 mesi.
1. Criteri di Valutazione della Risposta al Trattamento
La valutazione della risposta al trattamento, ad esempio dopo TARE o altri trattamenti per l'HCC, necessita di criteri standardizzati. Nel 2000 sono stati introdotti i criteri RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors), successivamente modificati nel 2009 in RECIST 1.1, che riducono il numero di lesioni target da considerare. Tuttavia, considerando la particolare natura del tessuto tumorale epatico, che può trasformarsi in tessuto necrotico o fibrotico in risposta al trattamento, l'American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) ha proposto i criteri mRECIST (modified RECIST). Questi criteri misurano la porzione vitale del tumore, in base alla captazione del mezzo di contrasto in fase arteriosa, correlandola meglio alla sopravvivenza. Oltre ai criteri standard che valutano la riduzione delle dimensioni del nodulo, la valutazione della risposta dovrebbe considerare anche la necrosi tumorale, la riduzione della vascolarizzazione, la riduzione dell'uptake di 18-FDG alla PET e il cambiamento nell'intensità del segnale di diffusione alla risonanza magnetica. La tempistica per valutare la risposta è ancora oggetto di dibattito, ma si suggerisce di attendere almeno 3 mesi.
2. Limiti dell Ablazione Percutanea e la Radioembolizzazione come Alternativa
L'ablazione percutanea presenta dei limiti, soprattutto quando il tumore è vicino a strutture vitali (diaframma, vena porta, vena cava, colecisti), rendendo la procedura ad alto rischio. In questi casi, la radioembolizzazione può essere utilizzata per una 'RE segmentectomia', concentrando dosi di radiazioni in un vaso segmentale, spesso portando ad atrofia del segmento trattato. Sebbene manchino studi randomizzati prospettici che confrontino direttamente la chemioembolizzazione (TACE) e la radioembolizzazione (TARE), studi retrospettivi indicano una minore tossicità, migliore qualità di vita e maggiore TTP (time-to-progression) con la TARE rispetto alla TACE, con sopravvivenza equivalente. Trial clinici, come SARAH, confermano tassi di sopravvivenza sovrapponibili tra TARE e TACE, con riduzione degli effetti avversi e aumento del TTP nella TARE. Questo suggerisce la TARE come possibile alternativa al Sorafenib in pazienti con HCC avanzato e tossicità legata alla terapia sistemica, ma ulteriori studi sono necessari per confermare questa ipotesi.
