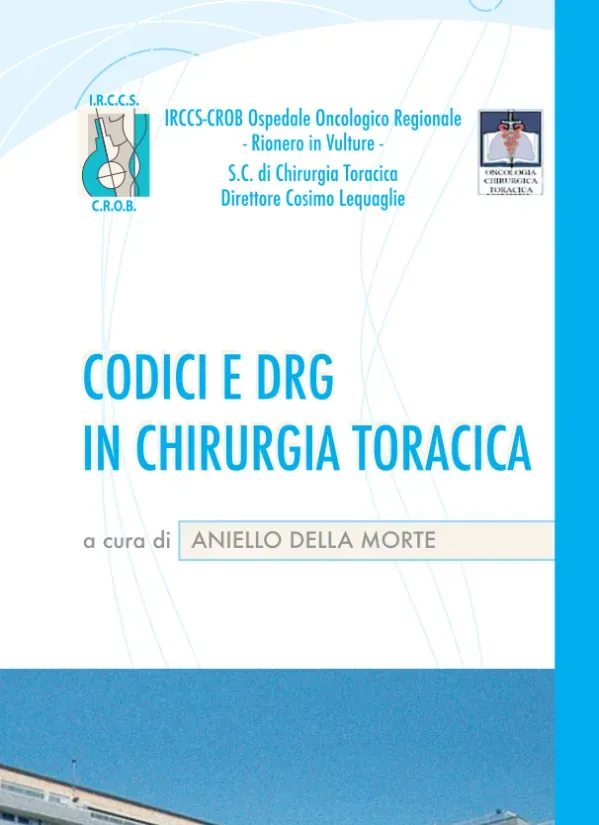
Codici DRG Chirurgia Toracica
Informazioni sul documento
| Autore | Cosimo Lequaglie |
| Scuola | IRCCS-CROB Ospedale Oncologico Regionale |
| Specialità | Chirurgia Toracica |
| Luogo | Rionero in Vulture |
| Tipo di documento | Manuale Tascabile |
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 354.81 KB |
Riassunto
I.Codifica SDO e DRG in Chirurgia Toracica
Questo manuale fornisce una guida pratica per la corretta codifica della Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) e l'assegnazione dei Diagnosis Related Groups (DRG) in Chirurgia Toracica. Si concentra sulla nomenclatura e sui codici ICD-9-CM relativi a diagnosi, traumatismi e procedure, inclusi casi complessi e procedure innovative. L'obiettivo è ridurre gli errori di codifica e garantire l'omogeneità nella compilazione delle SDO, fondamentali per il calcolo corretto dei DRG e il rimborso delle prestazioni.
1. Introduzione alla Codifica SDO e DRG in Chirurgia Toracica
Il manuale si propone di assistere i chirurghi toracici nella corretta codifica della Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) e nella determinazione dei relativi Diagnosis Related Groups (DRG). Si focalizza sulla Chirurgia Toracica, offrendo una sistematizzazione della nomenclatura e dei codici ICD-9-CM per diagnosi, traumatismi e procedure. Vengono affrontate situazioni complesse e prestazioni innovative, spesso fonte di errori di codifica o di incoerenze nella pratica. La parte conclusiva del manuale illustra la SDO, i codici ICD-9-CM, il sistema DRG e le relative regole di codifica emanate dal Ministero della Salute. L'obiettivo principale è quello di fornire uno strumento pratico e di facile consultazione per garantire l'accuratezza e l'uniformità nella codifica, aspetti cruciali per il corretto rimborso delle prestazioni sanitarie e il monitoraggio dei dati a livello nazionale. La legenda indica un criterio topografico per la suddivisione dei contenuti, con sezioni dedicate ai vari distretti anatomici (diaframma, esofago, linfonodi, mediastino, ecc.), patologie (benigne, maligne, traumatiche) e procedure specifiche. Sono inoltre presenti sezioni sulle diagnosi secondarie che influenzano i DRG, esami strumentali e di laboratorio, complicanze e comorbilità.
2. La Scheda di Dimissione Ospedaliera SDO e la sua Compilazione
La compilazione della SDO è obbligatoria per ricoveri ordinari e day hospital, ma non per attività ambulatoriali o strutture socio-assistenziali (salvo diverse disposizioni regionali). La SDO raccoglie informazioni anagrafiche (sesso, data e luogo di nascita, residenza) e cliniche (diagnosi, procedure diagnostiche, informazioni sul ricovero e sulla dimissione), oltre a dati organizzativi (unità operative, trasferimenti, soggetto pagante). Un sottoinsieme di queste informazioni viene trasmesso dalle Regioni al Ministero della Salute per attività di indirizzo e monitoraggio nazionale. Anche i pazienti provenienti dall'estero sono inclusi. Istituita con decreto ministeriale del 28 dicembre 1991, la SDO ha sostituito il precedente modello ISTAT/D10. Dal 27 ottobre 2000, le informazioni vengono codificate con i codici internazionali ICD-9-CM. La corretta compilazione della SDO è fondamentale per l'assegnazione del DRG e per la corretta remunerazione delle prestazioni erogate. L'accuratezza delle informazioni riportate è quindi di primaria importanza per il corretto funzionamento del sistema di rimborso ospedaliero. La compilazione della SDO deve essere effettuata da personale sanitario adeguatamente formato e deve rispettare fedelmente le informazioni riportate dal medico compilatore, fatta salva la possibilità di revisioni concordate.
3. Il Sistema di Classificazione ICD 9 CM
La International Classification of Disease, 9th revision, Clinical Modification (ICD-9-CM) è un sistema di classificazione che ordina malattie e traumatismi in gruppi correlati per finalità statistiche. Traduce termini medici in codici alfanumerici per diagnosi, problemi di salute e procedure. Approvata nel 1893 dalla Conferenza dell'Istituto internazionale di statistica a Chicago, in Italia è adottata dal 1924 per le statistiche di mortalità, e dal 1948 (6a revisione) anche per la morbilità. La 9a revisione (ICD-9) è stata approvata nel 1975 a Ginevra dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Negli Stati Uniti, un comitato aggiorna annualmente la versione ICD-9-CM, ampliandola con nuovi interventi e procedure. La versione italiana è curata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ed è pubblicata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'utilizzo dei codici ICD-9-CM è fondamentale per la codifica delle diagnosi e delle procedure nella SDO e per l'assegnazione del DRG. L'accuratezza della codifica è determinante per la correttezza dei dati statistici e per il corretto rimborso delle prestazioni.
4. Codici ICD 9 CM Specificità e Regole di Codifica
I codici NIA (non indicato altrove) e SAI (senza altre indicazioni) vanno usati solo se la documentazione clinica non permette l'utilizzo di codici più specifici. I codici NIA si usano per condizioni specifiche non presenti nell'ICD-9-CM, mentre i codici SAI si usano quando le informazioni sulla SDO sono insufficienti. Si deve sempre mirare alla massima specificità nella codifica di diagnosi e procedure. La diagnosi principale è la condizione responsabile del ricovero e del maggior utilizzo di risorse. Nel caso di più condizioni analoghe, si sceglie quella che ha richiesto più risorse. I codici V (fattori che influenzano lo stato di salute) possono essere diagnosi principali per pazienti cronici o in via di guarigione. Se non c'è diagnosi definitiva, si usano i codici per segni, sintomi e condizioni mal definite (capitolo 16 dell'ICD-9-CM). Le condizioni pregresse vanno riportate come diagnosi secondarie solo se influenzano il trattamento attuale; le complicanze del trattamento vanno codificate come diagnosi principali. Le infezioni insorte durante il ricovero sono diagnosi secondarie obbligatorie; le complicanze che allungano la degenza vanno considerate per l'assegnazione al DRG 'complicato'. I postumi di malattia o trauma richiedono due codici: uno per la condizione residua e uno per la causa. Codici combinati classificano simultaneamente due diagnosi o una diagnosi con manifestazione/complicazione associate; vanno usati se descrivono completamente le condizioni.
II.La Scheda di Dimissione Ospedaliera SDO
La SDO è un documento obbligatorio per i ricoveri ordinari e in day hospital, contenente informazioni anagrafiche e cliniche del paziente, essenziali per il monitoraggio nazionale della sanità. Contiene diagnosi principali e secondarie, procedure diagnostiche e terapeutiche, e informazioni sul ricovero. La corretta compilazione della SDO, utilizzando i codici ICD-9-CM, è fondamentale per l'assegnazione del DRG corretto.
1. Definizione e Obbligo di Compilazione della SDO
La Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) è un documento fondamentale per la registrazione delle informazioni relative al ricovero ospedaliero di un paziente. La sua compilazione è obbligatoria sia per i ricoveri ordinari che per quelli in regime di day hospital. Al contrario, non è richiesta per l'attività ambulatoriale e per le strutture socio-assistenziali, salvo diverse disposizioni regionali. La SDO contiene una serie di informazioni estrapolate dalla cartella clinica del paziente, suddivisibili in tre categorie principali: dati anagrafici, dati clinici e dati organizzativi. I dati anagrafici includono informazioni quali sesso, data e luogo di nascita, e comune di residenza. I dati clinici comprendono diagnosi, procedure diagnostiche effettuate, informazioni sul ricovero e sulla dimissione. Infine, i dati organizzativi riguardano aspetti come l'unità operativa di ammissione e dimissione, eventuali trasferimenti interni e il soggetto che si assume i costi del ricovero. Un numero ristretto di queste informazioni, indispensabili per il monitoraggio nazionale, viene trasmesso dalle Regioni al Ministero della Salute. Sono considerate anche le schede relative ai pazienti provenienti da Stati esteri. La SDO rappresenta dunque un elemento essenziale per il sistema sanitario nazionale, fornendo dati cruciali per la gestione e il monitoraggio dell'attività ospedaliera.
2. Storia e Normativa della SDO
La SDO è stata istituita con decreto del Ministero della Sanità del 28 dicembre 1991, sostituendo il precedente modello ISTAT/D10. Si tratta di un database integrato nelle cartelle cliniche di tutti gli istituti di ricovero e cura, pubblici e privati, accreditati e non accreditati. Le informazioni sanitarie contenute nella SDO, nel rispetto della normativa sulla privacy, vengono trasmesse alla Regione. Il decreto ministeriale del 27 ottobre 2000 ha stabilito l'utilizzo dei codici internazionali ICD-9-CM per inserire le informazioni nella SDO. La versione italiana dell'ICD-9-CM è curata dalla sezione Salute del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e pubblicata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'utilizzo del sistema ICD-9-CM è quindi parte integrante della normativa che regola la compilazione e la trasmissione dei dati contenuti nella SDO. La completezza e l'accuratezza delle informazioni riportate nella SDO sono di fondamentale importanza per garantire la validità dei dati utilizzati per il monitoraggio e la pianificazione delle politiche sanitarie a livello nazionale e regionale. La SDO rappresenta quindi uno strumento cruciale per la gestione del sistema sanitario e per la tutela della privacy del paziente.
3. Utilizzo della SDO per l Assegnazione del DRG
La SDO svolge un ruolo centrale nell'assegnazione dei Diagnosis Related Groups (DRG), un sistema di classificazione che raggruppa i pazienti in categorie omogenee per caratteristiche cliniche e di costo. Il software DRG-grouper utilizza i dati clinici rilevati dalla SDO (età, profilo clinico, durata della degenza, modalità di dimissione, complicanze, diagnosi secondarie, sesso, tipo di dimissione) per produrre un numero a tre cifre che identifica il DRG corrispondente. La codifica delle informazioni cliniche riportate nella SDO deve essere eseguita da personale sanitario adeguatamente formato e deve rispettare fedelmente l'ordine e il contenuto delle formulazioni riportate dal compilatore nella scheda. È consentita una revisione concordata con il medico compilatore. L'accuratezza della codifica nella SDO è quindi determinante per l'assegnazione corretta del DRG e, di conseguenza, per il rimborso delle prestazioni sanitarie. Una codifica scorretta può portare a una remunerazione inadeguata dell'attività ospedaliera, sottolineando l'importanza di una formazione specifica del personale incaricato della compilazione della SDO. La corretta compilazione della SDO è quindi un aspetto fondamentale per il buon funzionamento del sistema DRG e per garantire un equo rimborso delle prestazioni ospedaliere.
III.La Classificazione ICD 9 CM
Il manuale descrive la classificazione ICD-9-CM (International Classification of Diseases, 9th revision, Clinical Modification), un sistema per codificare diagnosi, traumatismi e procedure in codici alfanumerici. Spiega l'uso dei codici NIA (non indicato altrove) e SAI (senza altre indicazioni) per situazioni non completamente definite. Sottolinea l'importanza di utilizzare il livello più alto di specificità nella codifica delle diagnosi e degli interventi.
1. Descrizione del Sistema ICD 9 CM
Il manuale descrive l'International Classification of Diseases, 9th revision, Clinical Modification (ICD-9-CM), o Classificazione Internazionale delle Malattie, IX revisione, modificazione clinica. Questo sistema di classificazione, utilizzato a livello internazionale, organizza malattie e traumatismi in gruppi correlati per finalità statistiche. Il suo scopo principale è quello di tradurre i termini medici utilizzati nelle diagnosi di malattia, negli altri problemi di salute e nelle procedure diagnostiche e terapeutiche in codici alfanumerici. Questa codifica standardizzata permette una migliore raccolta, analisi e comparazione dei dati sanitari a livello globale. La sua adozione in Italia risale al 1924 per le statistiche sulla mortalità, estendendosi poi alla morbosità dal 1948 (con la 6a revisione). La 9a revisione (ICD-9) è stata approvata nel 1975 a Ginevra dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Negli Stati Uniti, un apposito comitato, composto da rappresentanti di diverse associazioni professionali e accademiche mediche, di associazioni ospedaliere, dell'Ufficio regionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'agenzia HCFA, sviluppa e aggiorna annualmente la versione ICD-9-CM, integrando nuovi interventi e procedure diagnostiche e terapeutiche. La versione italiana è curata dalla sezione Salute del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e pubblicata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
2. Codici NIA e SAI e il Principio di Massima Specificità
Il manuale evidenzia l'importanza di utilizzare i codici ICD-9-CM con il massimo livello di specificità possibile nella codifica delle diagnosi e degli interventi/procedure. Vengono introdotti i codici NIA (non indicato altrove) e SAI (senza altre indicazioni), che devono essere utilizzati solo quando la formulazione diagnostica e la documentazione clinica non forniscono informazioni sufficienti per applicare un codice più specifico. I codici NIA sono utilizzati quando una condizione è identificata ma non esiste un codice specifico nella classificazione ICD-9-CM. I codici SAI, invece, si applicano quando le informazioni presenti nella SDO non consentono l'utilizzo di un codice più preciso. Si raccomanda di consultare attentamente sia l'indice alfabetico che l'elenco sistematico dell'ICD-9-CM per individuare il codice più appropriato e specifico per ogni situazione clinica. L'utilizzo corretto di questi codici è fondamentale per garantire la precisione e la comparabilità dei dati sanitari raccolti, evitando ambiguità e garantendo l'efficacia del sistema di classificazione. La scelta del codice più specifico possibile contribuisce a una migliore analisi statistica e a una più accurata valutazione delle risorse utilizzate nel trattamento del paziente.
IV.Regole di Codifica delle Diagnosi
Il manuale definisce la diagnosi principale come la condizione che ha richiesto il ricovero e l'utilizzo maggiore di risorse. Spiega la codifica delle neoplasie e l'utilizzo dei codici V (fattori che influenzano lo stato di salute). Descrive le regole per la codifica delle diagnosi secondarie, comprese le condizioni pregresse rilevanti per il trattamento attuale, le complicazioni e le comorbilità. La corretta identificazione delle diagnosi secondarie influisce sul DRG assegnato.
1. Definizione della Diagnosi Principale
La sezione sulle regole di codifica delle diagnosi inizia definendo la diagnosi principale come la condizione che, al termine del ricovero, risulta essere la principale responsabile del bisogno di trattamento e/o di indagini diagnostiche. Se durante lo stesso ricovero sono presenti più condizioni con caratteristiche analoghe, la diagnosi principale sarà quella che ha determinato il maggiore impiego di risorse, considerando sia l'intensità del trattamento che la durata della degenza. Questa definizione è fondamentale per l'assegnazione corretta del DRG, in quanto la diagnosi principale è il criterio principale per la classificazione del caso clinico all'interno del sistema DRG. La scelta accurata della diagnosi principale è quindi un elemento cruciale per il corretto calcolo del DRG e per la successiva remunerazione della prestazione sanitaria. Una errata identificazione della diagnosi principale può portare a un'assegnazione di DRG non congrua con la complessità del caso clinico e, di conseguenza, a un'errata remunerazione della prestazione erogata dall'ospedale.
2. Codifica di Neoplasie e Codici V
Il manuale specifica le regole di codifica per le neoplasie e l'utilizzo dei codici V, che rappresentano fattori che influenzano lo stato di salute del paziente o che costituiscono una causa di ricorso alle strutture sanitarie. I codici V possono essere utilizzati come diagnosi principale in specifici casi, come ad esempio per pazienti cronici o in via di guarigione ricoverati per cure o procedure specifiche (radioterapia, chemioterapia, dialisi, rimozione di dispositivi ortopedici). L'utilizzo appropriato di questi codici è fondamentale per una corretta classificazione dei pazienti e per una rappresentazione accurata del loro percorso di cura. La corretta codifica delle neoplasie e l'applicazione dei codici V, in base alle specifiche situazioni cliniche, contribuisce a un'analisi più accurata dei dati e a una migliore comprensione della prevalenza e dell'impatto delle diverse patologie sul sistema sanitario. L'interpretazione corretta di queste regole è essenziale per una codifica precisa e per l'assegnazione del DRG appropriato.
3. Diagnosi Secondarie e Condizioni Pregresse
La sezione affronta le diagnosi secondarie, definite come condizioni che coesistono al momento del ricovero o si sviluppano successivamente, influenzando il trattamento ricevuto e/o la durata della degenza. Le diagnosi correlate a ricoveri precedenti, senza influenza sul ricovero attuale, non devono essere riportate. Le diagnosi secondarie devono essere codificate solo se hanno un impatto significativo sull'episodio di cura attuale. Un esempio specifico è rappresentato dalla codifica delle condizioni pregresse: i codici per malattie pregresse e non più presenti (come l'anamnesi personale di tumore maligno, altri rischi di malattia, o anamnesi familiare) vanno riportati tra le diagnosi secondarie solo se hanno avuto un ruolo nell'episodio di cura attuale. Fanno eccezione i casi di ricovero per controlli specifici in pazienti con tumore maligno. Il codice V66.7 (ricovero per cure palliative) può essere usato come diagnosi principale per ricoveri dedicati alle cure palliative, con la diagnosi di tumore come secondaria. I codici V71 (osservazione e valutazione di condizioni sospette) si utilizzano per la diagnosi principale se una condizione sospetta, non confermata al termine del ricovero, ha richiesto una valutazione specifica.
4. Codici Combinati Complicazioni e Infezioni
Il manuale definisce i codici combinati, utilizzati per classificare simultaneamente due diagnosi, una diagnosi con una manifestazione secondaria associata, o una diagnosi con una complicazione associata. Questi codici sono riportati nell'indice alfabetico e nell'elenco sistematico. Un codice combinato deve essere utilizzato quando identifica pienamente tutte le condizioni riportate o quando l'indice alfabetico lo richiede esplicitamente. Se il codice combinato non descrive tutte le condizioni, si può aggiungere un codice aggiuntivo. Quando il ricovero riguarda il trattamento di una complicazione di un trattamento medico o chirurgico (incluse reazioni a farmaci), il codice della complicazione è la diagnosi principale. Se la complicazione è classificata tra i codici 996-999, un codice aggiuntivo può specificarne la natura. Le infezioni insorte durante il ricovero devono essere riportate tra le diagnosi secondarie. Le complicanze 'cc' (che comportano un maggiore impegno assistenziale e allungano la degenza) determinano l'assegnazione al DRG 'complicato' del gruppo omologo.
V. Codifica degli Interventi e delle Procedure
Il manuale illustra le regole per la codifica degli interventi chirurgici, compresi gli interventi simultanei, aggiuntivi e le procedure complementari. Spiega l'importanza di identificare l'intervento principale (quello che consuma più risorse) e la codifica multipla quando necessaria per una descrizione completa. La codifica delle biopsie è dettagliata, distinguendo tra biopsie eseguite durante un intervento e biopsie eseguite separatamente. La descrizione dell'approccio chirurgico (a cielo aperto, endoscopico, laparoscopico) è altrettanto rilevante per una corretta codifica.
1. Intervento Principale e Livello di Specificità
La codifica degli interventi chirurgici deve essere effettuata con il massimo livello di specificità possibile, utilizzando tutti e quattro i caratteri del codice quando disponibile. Se il codice ha meno di quattro caratteri, questi devono essere allineati a sinistra. L'intervento principale è quello che ha comportato il maggior consumo di risorse durante il ricovero, considerando l'utilizzo della sala operatoria, il personale medico e infermieristico coinvolto, e la durata dell'intervento. È importante riportare tutti gli altri interventi chirurgici effettuati durante lo stesso ricovero, oltre alle procedure diagnostiche e terapeutiche più significative. La scelta dell'intervento principale è cruciale per la corretta assegnazione del DRG, in quanto influisce direttamente sul calcolo dei costi e sulla remunerazione della prestazione sanitaria. Una corretta codifica degli interventi chirurgici richiede una conoscenza approfondita del sistema di classificazione e delle relative regole, al fine di garantire un'accurata rappresentazione dell'attività svolta.
2. Codifica di Interventi Multipli e Procedure Complementari
Quando durante lo stesso ricovero vengono effettuati più interventi e/o procedure, il manuale fornisce criteri specifici per la scelta della sequenza corretta nella codifica. In presenza di più interventi chirurgici, quello da codificare come principale è quello maggiormente correlato alla diagnosi principale di dimissione e che ha comportato il maggior peso assistenziale e consumo di risorse. Se sono presenti sia interventi chirurgici che procedure, gli interventi chirurgici devono essere codificati per primi. Quando il numero di interventi e/o procedure supera i sei previsti dalla struttura della SDO, la priorità delle segnalazioni è lasciata al medico che compila la scheda, tenendo conto di un ordine decrescente di priorità. La codifica di interventi simultanei o procedure complementari può richiedere codici separati, a meno che non sia previsto un codice combinato. L'espressione “codificare anche” indica la necessità di utilizzare codici aggiuntivi per identificare diverse componenti di un intervento o procedure complementari. La codifica multipla può essere necessaria per descrivere completamente un intervento complesso.
3. Codifica delle Biopsie e Descrizione dell Approccio Chirurgico
Il manuale fornisce indicazioni specifiche sulla codifica delle biopsie. Il prelievo e l'analisi di materiale istologico durante un intervento chirurgico non richiedono una codifica aggiuntiva di biopsia, a meno che il risultato non sia necessario per definire il tipo e l'estensione dell'intervento in corso, oppure se la biopsia è effettuata su organi diversi da quello interessato dall'intervento principale. Le biopsie chiuse possono essere descritte con un codice combinato, se disponibile; altrimenti, si applicano regole specifiche. La descrizione dell'approccio chirurgico è importante: i codici di procedura spesso identificano approcci specifici (a cielo aperto, endoscopico, laparoscopico). Se non esiste un codice specifico per l'approccio utilizzato, si ricorre alla codifica multipla, indicando il codice dell'intervento principale e quello dell'approccio come codice aggiuntivo. Anche per le agobiopsie eseguite su organi diversi da quelli operati durante interventi a cielo aperto, si utilizza il codice della biopsia chiusa. Una corretta codifica di questi aspetti è fondamentale per riflettere accuratamente la complessità dell'intervento e le risorse impiegate.
VI.I DRG Diagnosis Related Groups
Il manuale spiega il sistema DRG, che raggruppa i pazienti in categorie omogenee per caratteristiche cliniche e di costo. Descrive le MDC (Major Diagnostic Categories), le 25 categorie principali in cui sono suddivisi i 538 DRG. Spiega come il software DRG-grouper utilizza i dati della SDO per assegnare il DRG corretto, che determina l'importo del rimborso regionale. Il peso relativo del DRG riflette il grado di impegno assistenziale e di costo.
1. Definizione e Scopo dei DRG
I Diagnosis Related Groups (DRG), o Raggruppamenti omogenei di diagnosi, costituiscono un sistema di classificazione che raggruppa i pazienti degli ospedali pubblici e privati convenzionati in categorie omogenee per caratteristiche cliniche ed assistenziali, prevedendo quindi anche un profilo di trattamento e di costi attesi simile all'interno di ciascuna categoria. Questo sistema permette di confrontare l'efficienza e i costi di diverse strutture ospedaliere e di gestire al meglio le risorse disponibili. L'obiettivo dei DRG è quello di creare un sistema di rimborso più equo ed efficiente, basato sulla tipologia di patologia e sul tipo di trattamento ricevuto dal paziente, piuttosto che sul semplice numero di giorni di degenza. Il sistema DRG si basa su una serie di variabili, tra cui la diagnosi principale e le diagnosi secondarie, le procedure effettuate, la durata della degenza, e altre informazioni cliniche rilevanti. La corretta classificazione dei pazienti all'interno delle diverse categorie DRG è fondamentale per garantire l'equità e l'efficienza del sistema di rimborso.
2. MDC Major Diagnostic Categories e Calcolo del DRG
In base alla diagnosi principale, il software di attribuzione DRG-grouper suddivide i 538 DRG in 25 categorie diagnostiche maggiori (MDC). Queste MDC costituiscono l'architettura di base del sistema di classificazione, raggruppando diagnosi in base a criteri anatomici (apparato affetto) ed eziologici (causa della patologia). Ad esempio, i DRG da 001 a 035, relativi a patologie e interventi sul sistema nervoso, sono inclusi nella MDC 1. Il software DRG-grouper utilizza i dati clinici della SDO (età, profilo clinico, durata della degenza, modalità di dimissione, complicanze, diagnosi secondarie, sesso, tipo di dimissione) per assegnare il DRG corrispondente, producendo come output un numero a tre caratteri. La codifica delle informazioni cliniche deve essere eseguita da personale sanitario adeguatamente formato, rispettando ordine e contenuto della SDO, con la possibilità di revisioni concordate con il medico compilatore. La precisione di questa codifica è essenziale per l'accuratezza dell'assegnazione del DRG.
3. Rimborso Peso Relativo e Casi Anomali
Ad ogni DRG è associato un importo che rappresenta il rimborso massimo che la regione può corrispondere per quella categoria. Questo importo è predefinito in base al consumo atteso di risorse, simile all'interno della stessa categoria DRG. Il sistema tiene conto di una certa variabilità nel consumo di risorse all'interno di ogni DRG, rappresentando un valore medio. Il peso relativo del DRG indica il grado di impegno assistenziale e il costo relativo rispetto al costo medio standard per ricovero. Il rimborso per un DRG è generalmente proporzionale al suo peso relativo, con una quota definita dalla Regione. Il peso medio annuo è la media dei pesi relativi di tutti i DRG prodotti in un anno. Il calcolo del peso relativo viene aggiornato dalle Regioni, considerando i costi del personale, dei materiali, delle apparecchiature e dei costi generali. Il sistema identifica anche i casi anomali (outlier), ovvero i ricoveri la cui durata di degenza si discosta significativamente dalla media del DRG, per i quali si applica un rimborso aggiuntivo a giornata.
4. DRG Medico Chirurgico e Non Classificabili
I DRG vengono distinti in chirurgici (sigla 'C'), caratterizzati dalla presenza di un intervento chirurgico o di altra procedura significativa, e medici (sigla 'M'), in assenza di tale procedura. I DRG chirurgici hanno generalmente un peso relativo maggiore rispetto a quelli medici. Esistono anche DRG non classificabili, come quelli della MDC 15 (malattie e disturbi del periodo neonatale) e alcuni DRG anomali (469, 470). Il peso relativo di un DRG, calcolato e aggiornato dalle singole regioni, riflette il grado di impegno assistenziale di ciascun ricovero. Il rimborso per un DRG è in genere proporzionale al suo peso relativo, con una quota stabilita dalla Regione. Il peso medio annuo è dato dalla media dei pesi relativi di tutti i DRG prodotti in un anno. Le Regioni aggiornano il peso relativo del DRG in base a fattori come il costo del personale, dei materiali, delle apparecchiature e dei costi generali dell'unità produttiva. Questi calcoli possono variare da regione a regione a causa di differenze nelle metodologie utilizzate, nelle versioni di DRG adottate e nell'applicazione di tariffe regionali specifiche.
VII.Errori di Codifica e Sanzioni
Il documento mette in guardia contro gli errori di codifica, che possono comportare sanzioni amministrative o penali, quali truffa e falso ideologico, in caso di compilazione fraudolenta della SDO. Vengono infine presentate alcune proposte per migliorare il sistema di codifica SDO/DRG in Chirurgia Toracica, per esempio, la revisione di alcune procedure più costose e l'inserimento di DRG oncologici.
1. Sanzioni per Errori di Codifica
La compilazione di una SDO non veritiera può comportare sanzioni amministrative sul piano civile, ma anche reati penali, in caso di prestazioni dichiarate ma non erogate o di manipolazioni della documentazione. Nel caso di falso ideologico da parte di pubblico ufficiale, le pene previste sono la reclusione da tre a dieci anni (art. 476 comma 2 e 479 C.P.), mentre per truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) la pena va da uno a cinque anni di reclusione (art. 640 comma 2 c.p.). È compito del direttore sanitario verificare la completezza delle informazioni contenute nella SDO e trasmetterle alla Regione e al Ministero della Salute. Errori di codifica casuali e involontari, non dovuti a condotte dolose o colpose, comportano una sanzione amministrativa solo se superano il 5%. La precisione nella compilazione della SDO e la corretta codifica delle informazioni sono quindi cruciali per evitare conseguenze legali e garantire la trasparenza e l'affidabilità dei dati del sistema sanitario. L'attenzione alla precisione e alla correttezza nella codifica è quindi fondamentale per evitare sanzioni e garantire la correttezza del sistema di rimborso.
2. Proposte per Migliorare la Codifica SDO e DRG
Il documento conclude presentando alcune proposte per migliorare la codifica SDO e DRG, in particolare in ambito di chirurgia toracica. Una proposta riguarda la revisione periodica delle procedure più costose, effettuata da chirurghi toracici specialisti, per una più precisa valorizzazione dei costi di degenza e un adeguamento della remunerazione dei DRG. Questa revisione è necessaria perché nello stesso DRG possono ricadere interventi e prestazioni con impegno professionale, economico e assistenziale differente, a causa di fattori come l'inflazione e l'introduzione di nuovi presidi medici e chirurgici. Un'altra problematica evidenziata è la possibile contrazione eccessiva del periodo di degenza a causa del sistema DRG, con conseguente accelerazione del turnover dei pazienti, peggioramento della qualità dell'assistenza e scarsa considerazione delle comorbilità. Si propone inoltre l'inserimento a pieno titolo nel gruppo dei DRG oncologici di alcuni DRG attualmente classificati come non oncologici in alcune regioni (es. 076, 077, 394...), che includono procedure come la videotoracoscopia transpleurica, la mediastinoscopia cervicale e l'asportazione linfonodale, che confermano istologicamente la malignità della patologia o patologie potenzialmente maligne come i timomi.
3. Errori e Limiti della Codifica
Infine, il documento riconosce l'esistenza di errori e limiti nella codifica, spesso dovuti a una carente formazione del personale. La compilazione e la gestione della SDO possono essere involontariamente scorrette, e il confronto tra dati di anni diversi può essere influenzato dal diverso grado di completezza dei dati nelle varie Regioni, da modifiche organizzative o da cambiamenti nelle definizioni e nelle codifiche adottate. Per migliorare la situazione, si suggerisce l'introduzione di codici combinati o multipli per codificare completamente tutte le componenti di una prestazione, soprattutto nei casi di interventi multipli, simultanei o aggiuntivi, procedure complementari o interventi bilaterali maggiori. Attualmente, anche utilizzando più codici, il DRG potrebbe non modificarsi, nonostante un maggior dispendio di risorse. Un esempio citato è il DRG 075, che include diverse tipologie di lobectomia, con differenti complessità e costi, ma con lo stesso rimborso. Questo evidenzia la necessità di un aggiornamento continuo delle procedure e delle relative codifiche per garantire la correttezza e l'equità del sistema DRG.
