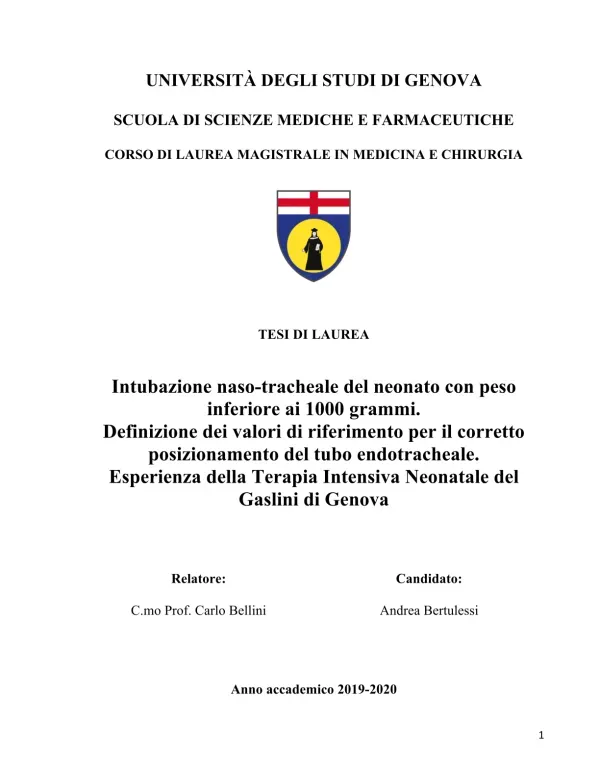
Intubazione Neonatale: Guida
Informazioni sul documento
| Scuola | Università Degli Studi Di Genova, Scuola Di Scienze Mediche E Farmaceutiche |
| Specialità | Medicina E Chirurgia |
| Tipo di documento | Tesi Di Laurea |
| Luogo | Genova |
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 5.96 MB |
Riassunto
I.Peculiarità Anatomofunzionali del Neonato e Indicazioni all Intubazione Endotracheale
L'intubazione endotracheale rappresenta lo standard d'oro per il controllo delle vie aeree nel neonato, ma presenta peculiarità legate all'anatomia pediatrica. Le dimensioni variabili dei neonati richiedono strumenti specifici. L'intubazione endotracheale è indicata in diverse situazioni, tra cui: aspirazione di liquido amniotico tinto di meconio in neonati depressi, ostruzione delle vie aeree superiori, necessità di ventilazione a pressione positiva prolungata o inefficace, ventilazione bronchiale selettiva e sospetta ernia diaframmatica. A differenza dell'adulto, le lesioni cervicali sono rare, rendendo l'approccio diverso. La procedura è preferita alla tracheotomia d'emergenza per i minori rischi. Anche l'aspirazione selettiva tracheale per colture o igiene bronchiale (es. in caso di meconio aspirazione) può richiedere intubazione endotracheale.
1. Differenze Anatomofunzionali tra Neonati e Adulti
La sezione evidenzia le significative differenze anatomofunzionali tra il tratto respiratorio del neonato e quello dell'adulto, che influenzano profondamente le tecniche di intubazione. La disponibilità di attrezzature specifiche per la pediatria è limitata rispetto a quella per adulti, rendendo inapplicabili alcune procedure utilizzate nei pazienti adulti. Il problema delle vie aeree pediatriche è ulteriormente complicato dalla notevole variabilità delle dimensioni e dei rapporti anatomici nel neonato, che cambiano in base al peso, alle dimensioni, alla maturità e alla funzione degli organi e dei sistemi coinvolti. Questa variabilità, particolarmente marcata nei primi sei anni di vita, impone l'utilizzo di strumenti e presidi di misura e tipo differenti a seconda del paziente, sottolineando la necessità di un approccio personalizzato in base alle caratteristiche individuali del neonato. La sezione introduce così il concetto di un approccio alla intubazione endotracheale specifico per l’età pediatrica, differente da quello dell’adulto, a causa della dinamica anatomica e funzionale in continua evoluzione.
2. Indicazioni all Intubazione Endotracheale Neonatale
Il testo elenca diverse situazioni cliniche che richiedono l'intubazione endotracheale nel neonato. Tra le principali indicazioni si evidenziano: l'aspirazione di liquido amniotico tinto di meconio in neonati depressi, che necessitano di un intervento immediato per la rimozione del meconio dalle vie aeree; l'ostruzione delle vie aeree superiori, che impedisce il passaggio dell'aria e richiede un intervento per ristabilire la pervietà; la necessità di una ventilazione a pressione positiva continua (CPAP) per un periodo prolungato, o quando la ventilazione a pressione positiva intermittente (PPV) risulta inefficace; l'esigenza di stabilire una via preferenziale per la ventilazione bronchiale selettiva, permettendo la ventilazione di un singolo polmone; ed infine, il sospetto di ernia diaframmatica, una condizione che richiede un controllo respiratorio accurato. La sezione mette in evidenza che, diversamente dall’adulto dove le lesioni cervicali sono frequenti e rappresentano una controindicazione assoluta all’intubazione tramite laringoscopio, nel neonato queste sono rare. Si sottolinea, infine, l’importanza dell’intubazione endotracheale come metodo preferenziale rispetto alla tracheotomia d’emergenza per il minore rischio di complicanze.
3. Aspirazione Tracheale e Controindicazioni
Un'ulteriore indicazione per l'intubazione endotracheale è rappresentata dalla necessità di ottenere un aspirato tracheale selettivo per analisi colturali o per migliorare l'igiene bronchiale in presenza di abbondanti secrezioni, ad esempio in caso di inalazione di meconio. Il documento specifica che, nelle situazioni cliniche descritte, non esistono controindicazioni assolute all'esecuzione della procedura, purché effettuata da personale esperto e con l'ausilio delle appropriate attrezzature e tecniche. Questa affermazione sottolinea l'importanza della competenza e della preparazione del personale medico coinvolto nell'esecuzione della procedura, così come della corretta valutazione del caso clinico per stabilire l'appropriatezza della tecnica di intubazione endotracheale. La scelta della tecnica più idonea, e l'individuazione di eventuali controindicazioni relative, devono essere attentamente valutate in relazione alle condizioni cliniche del paziente e alle competenze del personale medico.
II.Strumenti e Tecniche di Intubazione
Per l'intubazione endotracheale, sono necessari strumenti specifici come il laringoscopio pediatrico (lama retta tipo Miller, dimensioni 0, 00 o 1 a seconda del neonato), pinza di Magill per l'intubazione nasotracheale, tubi endotracheali pediatrici di diametro appropriato (2-4 mm, con aggiustamento per tubi cuffiati), mandrini malleabili e aspiratore. La dimensione del tubo può essere calcolata con la formula ([età in anni + 16]/4) o valutando la corrispondenza con il mignolo del paziente. La corretta posizione del tubo deve essere verificata tramite auscultazione, monitoraggio dei parametri vitali e assenza di perdite d'aria. La manovra richiede spesso l'ausilio di un secondo operatore per evitare iperestensione e applicare la manovra di Sellick (compressione cricoidea).
1. Strumentazione Necessaria per l Intubazione Endotracheale Pediatrica
La sezione descrive gli strumenti essenziali per eseguire correttamente un'intubazione endotracheale nel neonato. Tra questi, il laringoscopio pediatrico è fondamentale, specificando l'utilizzo di lame rette tipo Miller (dimensione 1 per neonati a termine, 0 o 00 per pretermine), sconsigliando l'uso di lame curve. L'importanza di una luce intensa emessa dal laringoscopio è sottolineata. Per quanto riguarda i tubi endotracheali pediatrici, la loro dimensione deve essere accuratamente scelta, possibilmente utilizzando la formula ([età in anni + 16]/4) e confrontando il diametro esterno con la larghezza del mignolo del paziente, o utilizzando sistemi basati sull'altezza o la lunghezza del bambino (es. nastro di rianimazione Broslow-Luten). La dimensione del tubo deve essere ridotta di 0,5 mm se si tratta di un tubo cuffiato (da evitare nel neonato). Altri strumenti indispensabili includono la pinza di Magill per l'intubazione nasotracheale (con doppia curvatura per una migliore visualizzazione), mandrini malleabili e un aspiratore. La presenza di un secondo operatore esperto è ritenuta fondamentale per ridurre al minimo i traumi durante la procedura, evitando iperestensione e rotazioni eccessive del capo del neonato.
2. Verifica del Corretto Posizionamento del Tubo
La corretta dimensione del tubo endotracheale è cruciale per il successo della procedura. La sezione evidenzia come la verifica della corretta misura del tubo scelto sia fondamentale per evitare perdite d'aria. Questo controllo viene effettuato mediante auscultazione con fonendoscopio pediatrico sulla faccia anteriore del collo e monitoraggio dei parametri del neonato e delle pressioni dei gas sul display del ventilatore. Un tubo delle giuste dimensioni garantirà una tenuta completa, senza perdite d'aria. La sezione evidenzia anche le difficoltà che possono insorgere durante la procedura, come ad esempio l'intralcio della lingua, secrezioni massive che ostacolano la visualizzazione delle corde vocali o la chiusura delle corde vocali stesse, rendendo l'accesso in trachea difficoltoso. La necessità di un team esperto per affrontare queste eventualità viene esplicitamente menzionata, sottolineando l'importanza di una preparazione accurata, della valutazione dell'adeguatezza della strumentazione, della scelta del laringoscopio più adatto, dell'utilizzo di tubi di diametro appropriato e della disponibilità di mandrini malleabili e di un aspiratore. La manovra di Sellick viene presentata come procedura fondamentale durante la intubazione.
III.Premedicazione e Tecniche di Esecuzione Orotracheale e Nasotracheale
La procedura di intubazione endotracheale può causare alterazioni fisiologiche (bradicardia, aumento della pressione intracranica). Una premedicazione con farmaci vagolitici, sedativi e miorilassanti è spesso necessaria. L'intubazione orotracheale richiede una corretta posizione del paziente (“sniffing morning air”) e l'eventuale manovra BURP (backward, upward, rightward, pressure). L'intubazione nasotracheale può essere un'alternativa all'orotracheale, ma richiede attenzione per evitare complicanze. Il monitoraggio continuo della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca è fondamentale durante entrambe le procedure. Il passaggio da intubazione orotracheale a intubazione nasotracheale richiede attenzione e può essere dilazionato se il personale non è esperto.
1. Premedicazione Farmacologica per l Intubazione
La sezione introduce l'importanza della premedicazione farmacologica prima dell'intubazione endotracheale. La procedura di intubazione, infatti, può causare alterazioni dei parametri fisiologici, come variazioni della pressione arteriosa, bradicardia riflessa e aumento della pressione intracranica. Per prevenire queste alterazioni e facilitare la riuscita della manovra, si ricorre ad un trattamento farmacologico precoce con farmaci vagolitici, sedativi e miorilassanti. L'utilizzo di questi farmaci aiuta a ridurre significativamente gli effetti collaterali indesiderati della procedura di intubazione, migliorando il successo dell'intervento e garantendo una maggiore sicurezza per il paziente. La scelta dei farmaci e il dosaggio devono essere attentamente valutati in base alle condizioni cliniche specifiche del neonato, considerando fattori come peso, età gestazionale e presenza di patologie concomitanti. L'obiettivo principale è quello di ottenere una sedazione adeguata e un rilassamento muscolare sufficiente per facilitare l'intubazione, riducendo al minimo il rischio di complicanze.
2. Tecnica di Intubazione Orotracheale
Questa sezione dettaglia la tecnica di intubazione orotracheale. È fondamentale posizionare il paziente in posizione supina con l'occipite sollevato e il capo lievemente esteso a livello dell'articolazione atlanto-occipitale (posizione 'sniffing morning air'), per un migliore allineamento degli assi orale, faringeo e laringeo e una conseguente migliore visualizzazione della glottide durante la laringoscopia. Nei bambini sotto i due anni, un telino ripiegato sotto le spalle può facilitare questo allineamento. Si descrive poi il ruolo di un assistente, che può manipolare la laringe dall'esterno con la manovra BURP (backward, upward, rightward, pressure) per facilitare la visualizzazione. Il tubo viene inserito nell'orofaringe dall'angolo destro della bocca, mantenendo la concavità verso il basso ed esternamente alla lama del laringoscopio. L'importanza della visualizzazione costante della punta del tubo durante l'inserimento è sottolineata. L'utilizzo di un tubo endotracheale sterile e la rimozione del mandrino rigido prima dell'inserimento sono procedure imprescindibili.
3. Tecnica di Intubazione Nasotracheale e Passaggio da Orotracheale a Nasotracheale
La sezione descrive la tecnica di intubazione nasotracheale e il passaggio da una intubazione orotracheale ad una nasotracheale. Se l'intubazione orotracheale fallisce o non è possibile, con il tubo ancora in sede, si può rilasciare il fissaggio e posizionare il tubo nella parte sinistra della bocca per mantenere una buona ventilazione durante la successiva intubazione nasotracheale. Si suggeriscono metodi per valutare la corretta posizione del tubo, tra cui la valutazione della distanza labbro-punta del tubo, la valutazione della curva della respirazione sul monitor e l'utilizzo di un rilevatore esofageo (anche se meno raccomandato). Questo metodo, però, serve solo per verificare la presenza del tubo nelle vie aeree, non distinguendo tra trachea e bronchi principali. Il miglioramento dei parametri vitali (frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno, colorito e reattività del neonato) conferma il corretto posizionamento del tubo in trachea; un neonato cianotico, bradicardico e desaturato indica un posizionamento scorretto. Nel caso di gestione da parte di personale non esperto, si consiglia la ventilazione con pallone-maschera-ossigeno, posticipando l'intubazione fino a quando non possa essere eseguita in sicurezza.
IV.Vie Aeree Difficili nel Neonato e Posizionamento del Tubo
Le vie aeree difficili nel neonato sono generalmente prevedibili in presenza di sindromi o patologie specifiche. La classificazione di Mallampati non è affidabile in età pediatrica. Il corretto posizionamento del tubo endotracheale è cruciale, e diversi metodi sono descritti per determinarne la profondità ottimale: la “7-8-9 rule” di Tochen e la classificazione di Hansmann, con aggiustamenti recenti basati su studi presso l'Istituto Gaslini. La radiografia del torace è fondamentale per la conferma del posizionamento, verificando la posizione del tubo rispetto alle vertebre. Si deve considerare la potenziale intubazione selettiva del bronco destro e le sue conseguenze sulla ventilazione. Il tubo Portex 2.5 mm in PVC è citato come un'opzione comune.
1. Difficoltà Prevedibili e Imprevedibili nelle Vie Aeree Pediatriche
La sezione affronta il tema delle vie aeree difficili nel neonato, evidenziando che in età pediatrica, una difficoltà di ventilazione o di intubazione è generalmente prevedibile se associata a sindromi complesse o patologie specifiche, facilmente individuabili da un attento esame obiettivo. Si sottolinea però che l'incidenza di vie aeree difficili nella popolazione pediatrica al di fuori di questi contesti è presumibilmente bassa, rendendo le difficoltà impreviste un evento estremamente raro. La classificazione di Mallampati, utilizzata per predire le vie aeree difficili negli adulti, non risulta affidabile nei bambini a causa della mancata collaborazione del paziente, che influenza negativamente l'accuratezza dell'esame. Tuttavia, l'osservazione dell'apertura massimale della bocca durante il pianto può aiutare ad escludere una riduzione della mobilità dell'articolazione temporo-mandibolare, e permette di valutare la situazione dentale, le dimensioni della lingua rispetto al cavo orofaringeo e l'eventuale presenza di lesioni. I metodi predittivi utilizzati nell'adulto non sono applicabili nel bambino, anche per la maggiore soggettività nella definizione stessa di 'vie aeree difficili', che dipende fortemente dall'esperienza dell'operatore.
2. Metodi per la Determinazione della Profondità di Inserimento del Tubo
Il documento discute i diversi metodi proposti in letteratura per determinare la profondità ottimale di inserimento del tubo endotracheale nel neonato. Si citano la classificazione di Hansmann, gli studi di Low e Thibeault, Gill et al., e la '7-8-9 rule' di Tochen, quest'ultima forse la più conosciuta e utilizzata. Gli studi, e in particolare quelli condotti presso l'Istituto Gaslini, evidenziano la necessità di specificare i valori riportati in letteratura per i neonati con peso molto basso alla nascita (<1000 grammi), apportando correzioni ai lavori precedenti. Ad esempio, si fa riferimento ad una rivisitazione del nomogramma di Hansmann (Bellini et al.), mostrando una posizione finale del tubo in media 0,5 cm più alta rispetto a quanto precedentemente riportato. Nel testo si menziona l'utilizzo del tubo endotracheale pediatrico Portex 2.5 mm in PVC per la sua elevata tollerabilità biologica e minore abrasività di superficie. La posizione del tubo è determinata anche dalle linee guida approvate nel Giugno 2015 dal Neonatal Patient Care Teams, HSC & SBH Child Health Standards Committee, considerando la '7-8-9 rule' di Tochen e gli studi di Hansmann. La radiografia del torace in proiezione antero-posteriore, con il capo del neonato in posizione neutra, è fondamentale per verificare il corretto posizionamento del tubo.
3. Considerazioni sulla Posizione del Tubo e Possibili Complicazioni
La sezione analizza la posizione del tubo endotracheale e le possibili complicanze. Si evidenzia come la relazione lineare tra la lunghezza dell'albero respiratorio prossimale e il peso, l'età gestazionale e la lunghezza del neonato permetta una regolazione più fine dei marcatori dei tubi per i pazienti più piccoli. Questi neonati, infatti, presentano il rischio più alto di richiedere un ETT e di intubazione del bronco principale destro, a causa della lunghezza tracheale limitata. Si discutono le diverse situazioni che possono verificarsi con il tubo in trachea, considerando la direzione della punta del tubo rispetto ai bronchi e le conseguenti anomalie di ventilazione, che comunque risultano minime in base ai dati dello studio citato. L'intervallo di ± 0,5 cm dalla profondità ideale è considerato accettabile, in assenza di eventi avversi. Si conclude sottolineando che le valutazioni effettuate consentono un'elevata sicurezza anche per valori di profondità considerati alti da Tochen, riducendo al minimo il rischio di estubazione e di intubazione selettiva del bronco destro. Infine, si evidenzia l'importanza di considerare l'influenza della posizione del capo del neonato sull'interpretazione dell'esame radiologico.
