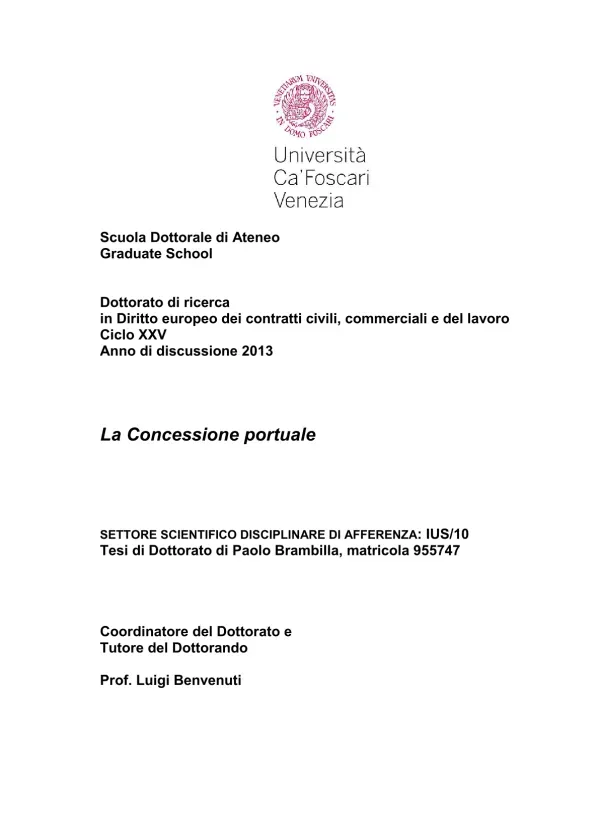
Concessioni Portuali: Tesi di Dottorato
Informazioni sul documento
| Autore | Paolo Brambilla |
| instructor | Prof. Luigi Benvenuti |
| Scuola | Scuola Dottorale di Ateneo Graduate School |
| Specialità | Diritto europeo dei contratti civili, commerciali e del lavoro |
| Tipo di documento | Tesi di Dottorato |
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 2.64 MB |
Riassunto
I.La Disciplina delle Concessioni Portuali in Italia Un Analisi Storica e Giuridica
Il documento analizza la complessa legislazione italiana in materia di concessioni portuali, tracciando un percorso storico che evidenzia l'evoluzione normativa dal Codice della Navigazione (Codice della navigazione) agli sviluppi più recenti. Si esaminano le attribuzioni delle Autorità portuali italiane e l'evoluzione del ruolo delle imprese portuali, comprese le compagnie portuali e le imprese terminaliste, nell'ambito del demanio marittimo. L'analisi si concentra sulle diverse tipologie di concessioni, comprese quelle per la costruzione e gestione di opere portuali, e sui servizi portuali, inclusi quelli specialistici. Vengono esaminate le diverse interpretazioni giurisprudenziali, in particolare quelle del Consiglio di Stato, e l'influenza della normativa comunitaria (diritto comunitario) sul diritto della navigazione. Casi specifici, come quelli di Genova e Venezia, illustrano l'applicazione pratica della legislazione portuale. Sono inoltre analizzate le diverse giurisdizioni (giurisprudenza amministrativa) coinvolte nelle controversie relative alle concessioni.
II.Il Ruolo del Demanio Marittimo e la Gestione dei Porti Commerciali
Il documento approfondisce il ruolo del demanio marittimo nella regolamentazione delle attività portuali. Vengono analizzati gli articoli del Codice della Navigazione (Codice della navigazione) che definiscono le competenze dei capitani e ufficiali di porto riguardo alla sicurezza e alla polizia portuale, in particolare nelle aree del demanio marittimo. Si esamina il ruolo dei comuni, delle camere di commercio e del Ministero dei Lavori Pubblici nell'approvazione dei progetti e nella concessione di aree portuali. L'analisi si concentra sulle differenze tra la legislazione e la prassi, evidenziando come nei porti maggiori spesso prevalgano le singole leggi istitutive degli enti portuali, limitando o escludendo l'intervento di imprese private nella movimentazione merci.
1. Competenze delle Autorità Portuali e Gestione del Demanio Marittimo
Questo paragrafo approfondisce le competenze delle autorità portuali e il loro rapporto con il demanio marittimo nella gestione dei porti commerciali. Gli articoli 163 e 165 del Codice della Navigazione vengono analizzati per definire il ruolo dei capitani e ufficiali di porto nella sorveglianza e nella sicurezza dei porti, inclusa la regolamentazione dell'ingerenza nelle aree commerciali (docks). L'articolo 165 specifica come, nei porti con gru o altri meccanismi per il carico/scarico merci installati dal Municipio, dalle Camere di Commercio o da altri enti, l'esercizio di tali meccanismi debba essere regolato in accordo con l'ufficio del porto, al quale spetta la sorveglianza di polizia sia sulle macchine sia sulle persone addette. Il testo prosegue descrivendo come tra le opere di interesse per la navigazione e il commercio marittimo siano incluse tutte quelle che facilitano il carico, scarico, deposito e trasporto delle merci. La realizzazione di tali opere nelle aree portuali o demaniali marittime richiede il consenso preventivo del Ministero dei Lavori Pubblici, che approva i progetti, e le relative concessioni sono soggette alle disposizioni del Codice per la Marina Mercantile e al relativo regolamento. Si cita l'esempio del Consorzio del Porto di Genova, il cui regolamento prevede la costruzione di magazzini e l'installazione di meccanismi per il carico e lo scarico delle merci, salvo che non si faccia affidamento all'industria privata.
2. Confronto tra Normativa e Prassi Il Caso di Genova e Venezia
Il documento evidenzia una discrepanza tra la normativa e la prassi nella gestione dei porti commerciali italiani. Nonostante l'introduzione del Codice della Navigazione, nei porti maggiori continuava ad applicarsi il regime previsto dalle singole leggi istitutive degli enti portuali. Questi enti, a volte, si occupavano direttamente delle operazioni di carico, scarico e movimentazione delle merci, limitando o escludendo l'intervento di imprese private. Il testo cita esplicitamente il caso del porto di Venezia, il cui esercizio commerciale era affidato al Provveditorato al porto, un'azienda autonoma dipendente dal Ministero delle Comunicazioni, con attribuzioni specifiche nella gestione delle operazioni di sbarco, imbarco, trasbordo, deposito e trasporto delle merci, compresa la disciplina delle prestazioni della mano d'opera. Il Provveditorato gestiva anche depositi franchi, magazzini generali e altri stabilimenti in zone demaniali marittime, sempre nel rispetto delle leggi doganali. Un altro esempio è quello dei Magazzini generali di Trieste, la cui azienda aveva il compito di gestire l'esercizio commerciale esclusivo degli impianti portuali, inclusi rive, moli, hangar, binari e gru, sia nei porti franchi sia nella parte del porto doganale provvisto di hangar. L'azienda si occupava anche del carico, scarico e deposito di merci e dell'esercizio ferroviario merci, oltre alla manutenzione delle opere affidate alla sua gestione. La gestione degli apparecchi di carico e scarico poteva essere affidata direttamente alla Capitaneria di porto o concessa a privati.
III.La Legge 84 94 e l Introduzione delle Imprese Terminaliste
Questo paragrafo tratta l'impatto della Legge 84/94 sulla gestione dei porti italiani. Viene introdotta la figura delle imprese terminaliste, soggetti in grado di gestire in maniera integrata il ciclo operativo delle merci nei porti. Si analizza la novità rappresentata dall'introduzione di queste imprese e la loro relazione con le operazioni portuali e i servizi portuali specialistici, evidenziando il superamento del precedente sistema normativo. L’analisi considera le modalità di affidamento delle aree demaniali alle imprese terminaliste e la loro interazione con altri operatori portuali, ponendo l'accento sul rapporto tra diritto antitrust e regolamentazione portuale.
1. Introduzione delle Imprese Terminaliste con la Legge 84 94
La Legge 84/94 rappresenta un punto di svolta nella regolamentazione delle attività portuali italiane, introducendo la figura delle imprese terminaliste. Questi nuovi attori del settore sono definiti come soggetti capaci di gestire l'intero ciclo operativo dei servizi relativi alla merce, dal suo sbarco all'imbarco, e dispongono delle risorse umane e strutturali per sviluppare i traffici marittimi del porto. L'introduzione delle imprese terminaliste segna un cambiamento significativo rispetto al sistema precedente, dove la gestione delle operazioni portuali era spesso appannaggio diretto di enti pubblici o aziende statali, con limitata o assente concorrenza privata. L'articolo 18 della legge 84/94, in particolare, assegna all'Autorità competente la responsabilità di concedere in concessione alle imprese terminaliste le aree demaniali e le banchine all'interno del porto. Questo passaggio evidenzia una maggiore apertura verso la privatizzazione e la liberalizzazione del settore portuale, in linea con le tendenze economiche del tempo, ma ancora sconosciuta al Codice della Navigazione. La legge prevede che le imprese terminaliste ricevano spazi riservati per le loro operazioni, una disposizione fondamentale per la loro operatività.
2. Obblighi del Concessionario e Ambito delle Attività Esercitabili
L'analisi prosegue approfondendo gli obblighi delle imprese terminaliste concessionarie. Oltre al pagamento del canone per l'utilizzo delle aree demaniali, il concessionario assume l'obbligo contrattuale di garantire una produzione di servizi portuali a ciclo integrale e continuativo. Questo implica una gamma completa di prestazioni che coprono l'intero ciclo operativo collegato alla partecipazione del vettore marittimo, considerando le tecnologie e le caratteristiche strutturali del bene demaniale concesso. Il documento evidenzia che l'obbligo del terminalista è più ampio e articolato rispetto a quello di un semplice concessionario di spazi pubblici. La normativa, tuttavia, non fornisce un quadro sistematico esaustivo delle attività esercitabili dal concessionario. Mentre la possibilità di svolgere tutte le operazioni portuali per le quali è autorizzato (se la concessione riguarda aree e banchine) sembra chiara, la questione è più complessa per i servizi portuali specialistici, introdotti dall'art. 16 della legge 84/94 e dalla legge 136 del 2000. Questi servizi, complementari e accessori al ciclo delle operazioni portuali, sono individuati dalle autorità portuali. Il testo cita un'opinione dottrinale secondo cui il terminalista potrebbe svolgere anche tali attività, altrimenti dovrebbe terziarizzare il servizio, anche se questo obbligo non è espressamente imposto dalla legge. Infine, il comma 7bis dell'articolo 16 esclude dall'ambito di applicazione della legge i depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato libero, siti in ambito portuale.
IV. Concessioni Portuali Natura Giuridica e Giurisprudenza
Questa sezione approfondisce la natura giuridica delle concessioni portuali, confrontando le diverse interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali. Si discute sulla classificazione delle concessioni come atti amministrativi o contratti, considerando le implicazioni in termini di giurisdizione (giurisprudenza amministrativa) e di applicazione delle normative sui contratti pubblici. Vengono citate sentenze importanti della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, evidenziando l’evoluzione del pensiero giuridico sulla materia. Il ruolo della Commissione Europea e la normativa comunitaria (diritto comunitario) sono analizzati in relazione alle procedure di aggiudicazione delle concessioni e all'obbligo di trasparenza.
1. La Natura Giuridica delle Concessioni Portuali Tra Atto Amministrativo e Contratto
Questa sezione analizza la controversa natura giuridica delle concessioni portuali, esplorando il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla loro classificazione. La questione centrale è se debbano essere considerate atti amministrativi unilaterali o contratti bilaterali. La prospettiva tradizionale le inquadra come concessioni di beni pubblici, riconducibili all'articolo 36 del Codice della Navigazione. Tuttavia, alcuni autori contestano questa visione, sostenendo che le modalità di rilascio e le funzioni delle concessioni vanno oltre un semplice uso delle aree demaniali. L'obbligo del concessionario non si limita al pagamento del canone, ma include l'esercizio di una specifica attività sottoposta al controllo costante delle Autorità portuali. La funzione della concessione è spesso circoscritta allo svolgimento di operazioni portuali, suggerendo una ricostruzione dell'istituto che vada oltre la prospettiva tradizionale. Il documento menziona l'influenza della dottrina precedente all'entrata in vigore dell'articolo 18 della legge 84/94, dove le concessioni alle imprese che svolgono operazioni portuali (artt. 111 cod. nav. e 201 reg. nav. mar.) erano considerate concessioni di aree portuali attrezzate per l'imbarco e lo sbarco. L'analisi considera anche la prospettiva della Commissione Europea, che evidenzia l'obbligo di trasparenza e concorrenza nelle procedure di concessione, anche in assenza di una specifica normativa comunitaria in materia.
2. Giurisprudenza e Interpretazioni Il Ruolo della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato
Il paragrafo approfondisce l'interpretazione giurisprudenziale delle concessioni portuali, focalizzandosi sul contributo della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato. Viene discussa la riconducibilità dell'istituto concessorio alle concessioni di beni pubblici, evidenziando le divergenze dottrinali su questa classificazione. Si sottolinea che alcuni autori considerano insoddisfacente la semplice qualificazione come concessione di beni pubblici, a causa delle modalità di rilascio e del controllo costante da parte delle Autorità portuali. Il documento evidenzia l'importanza di una ricostruzione che valorizzi aspetti non considerati dalla prospettiva tradizionale. La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione viene citata, specificando che la convergenza di un negozio unilaterale e autoritativo dell'Amministrazione con una convenzione attuativa (contratto) non altera la natura concessoria dell'istituto, giustificando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Si fa riferimento anche all'insegnamento della Corte Costituzionale e a diverse sentenze che evidenziano l'importanza della finalità produttiva delle aree portuali e la preponderanza dell'attività economica e imprenditoriale rispetto al regime demaniale nella disciplina portuale. L’analisi considera infine la distinzione tra giurisdizione amministrativa e ordinaria in base alla natura del bene concesso (demaniale o disponibile) e all'oggetto della controversia (concessione o corrispettivi).
