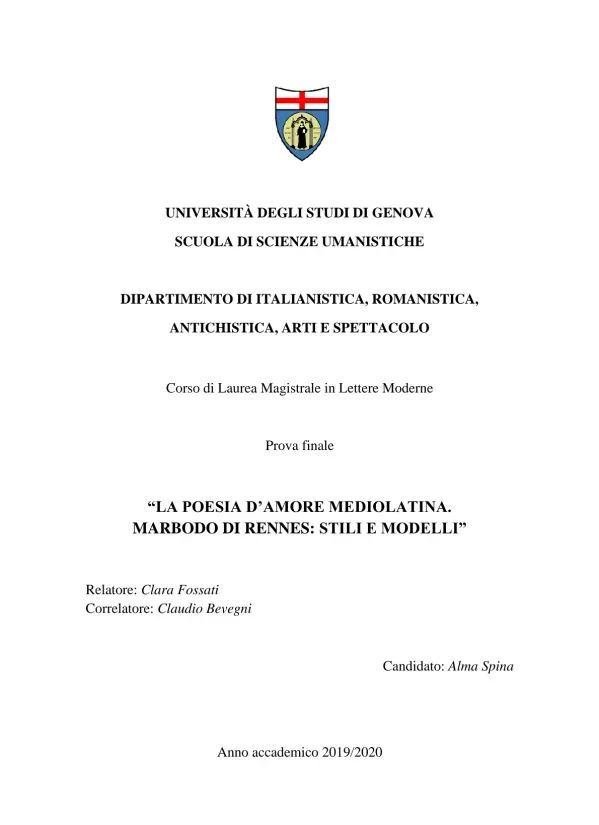
Poesia amorosa mediolatina: Marbodo di Rennes
Informazioni sul documento
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 804.51 KB |
Riassunto
I.La Poesia Lirica Amorosa nel Medioevo Latino Caratteri Generali e Modelli
Questo studio approfondisce la poesia amorosa mediolatina, analizzando il vasto e diversificato corpus poetico giunto fino a noi. Si concentra sull'identificazione dei principali modelli poetici a cui si ispirarono i poeti medievali, evidenziando l'importanza di Ovidio come figura chiave e l'influenza del Cantico dei Cantici come fonte di ispirazione religiosa. L'analisi si focalizza sulla contaminazione tra cultura classica e cultura cristiana, e sul processo di simbolizzazione dei topoi letterari classici all'interno di un contesto cristiano. L'obiettivo è comprendere come questa poesia latina medievale abbia preparato il terreno per la successiva poesia trobadorica, in particolare la fin'amor.
1.1 Caratteri generali e inquadramento storico della poesia lirica amorosa latina medievale
Il corpus della poesia lirica amorosa latina medievale è vasto, vario e complesso da classificare. La difficoltà risiede nella sua eterogeneità e nell'ampiezza temporale (VI-XIII secolo) e geografica. A differenza della poesia d’amore classica (greca e latina, quest'ultima con un corpus più unitario), gli studi sulla poesia mediolatina sono recenti. I metodi di classificazione si basano sulla comunanza di modelli, sulla provenienza geografica dei poeti (escludendo la maggioranza di componimenti anonimi) e sulle finalità dei testi (a chi/perché sono dedicati, chi li ha commissionati). Un’ulteriore prospettiva riguarda la fortuna di questo corpus: come e perché questi testi sono giunti fino a noi, quali modifiche hanno subito, e il loro contributo alla letteratura europea successiva. La sfida è quindi quella di individuare criteri unitari per analizzare un materiale così ampio e diversificato, andando oltre le semplici classificazioni genealogiche.
1.2 La produzione poetica amorosa e la stratificazione sociale
L'analisi considera la produzione di poesia amorosa in relazione alla stratificazione sociale del Medioevo. I chierici e i nobili di rango inferiore creavano liriche e romanzi d'amore per i loro patroni nobiliari. Tra i nobili di rango inferiore si ricordano gli autori di romanzi dei cicli classico e arturiano (come Benoit de Sainte-Maure, autore del Roman de Troie; gli autori anonimi del Roman de Thebes e dell'Eneas; Wace, autore del Roman de Brut; Chrétien de Troyes; e Gottfried von Strassburg). Si evidenzia l'Archipoeta di Colonia, uno dei pochi autori di questo periodo che scriveva in latino. I monaci e i frati, inizialmente esclusi dalla produzione di poesia d'amore, sono considerati anche in questo contesto: la loro precedente vita mondana, l'influenza del Cantico dei Cantici e dell'innologia liturgica e il loro rapporto con la nobiltà che li sosteneva finanziariamente, ne hanno permesso la partecipazione. Anche la figura femminile trova spazio, seppur con l'incertezza se autrice o meno di numerosi componimenti anonimi, come il famoso “lamento della donna incinta”.
1.3 Ovidio e la poesia amorosa mediolatina un modello principale
Ovidio è individuato come il modello principale della poesia amorosa mediolatina. Il suo successo derivava dall’attingere ad un bagaglio culturale comune al suo pubblico, fatto che i poeti medievali replicarono. L'esempio citato è l'utilizzo da parte di Ovidio, nel libro IV delle Metamorfosi, delle figure retoriche e del lessico in modo da creare una connessione profonda col pubblico, un'operazione di imitazione-ricreazione consapevole. L’imitazione ovidiana non è semplice copiatura, ma una rielaborazione che crea un dialogo tra l’autore medievale e il suo modello classico. Si evidenzia la ricchezza di rimandi e richiami nelle opere di Ovidio, che creano continuità con il passato e connessione col pubblico, una strategia che ha un parallelo anche nella poesia contemporanea.
1.3.1 Venanzio Fortunato un modello per la poesia amorosa
Venanzio Fortunato (530-600) è presentato come il primo modello per i poeti successivi. La sua opera, vasta e scorrevole, comprende la Vita Martini (576), preceduta da un'epistola a Gregorio di Tours e da una dedica a Radegonda e Agnese. I componimenti dedicati a queste due figure, contenuti nei Miscellanea, sono particolarmente rilevanti per lo studio della poesia amorosa. Il testo cita alcuni versi di Venanzio Fortunato, evidenziando il tema amoroso e la complessa relazione tra eros e agape. L'analisi si estende brevemente al Ludus super iconia Sancti Nicolai di Ilario, inserendolo nel ciclo di uffici drammatici sul tema del miracolo di San Nicola e mostrando l'evoluzione del teatro latino medievale verso forme più profane e in volgare, con esempi come il Jeu de saint Nicholas di Jean Bodel. La sezione tocca anche i Carmina Cantabrigiensia, una raccolta di componimenti dove prevale la tematica religiosa su quella amorosa, diversamente dai Carmina Burana.
II.Autori Chiave e le Loro Opere Marbodo di Rennes Ildeberto di Lavardin Balderico di Bourgueil
Tra gli autori principali, lo studio analizza le opere di Marbodo di Rennes, Ildeberto di Lavardin, e Balderico di Bourgueil, tre figure chiave della poesia amorosa mediolatina nella Valle della Loira. Le loro liriche, indirizzate a nobildonne (come Adele di Blois, Cecilia di Normandia, Matilde d'Inghilterra) e monache (Muriel, Costanza, Emma), mostrano un'evoluzione del genere, con un'attenzione particolare alla celebrazione della cultura e della cortesia femminile, anticipando alcuni aspetti della successiva poesia trobadorica. Si esaminano le tecniche metriche, tra cui l'utilizzo dell'esametro leonino, e l'influenza di autori classici e del Cantico dei Cantici sulle loro composizioni.
1. Marbodo di Rennes vita e opere principali
Il testo introduce Marbodo di Rennes come figura chiave della poesia amorosa mediolatina. Sebbene noto per il Liber Lapidum, trattato di mineralogia medica che ebbe larga diffusione, l'analisi si concentra sulla sua poesia amorosa. Si menziona il Liber decem capitulorum, una raccolta di dieci poesie in esametri con riflessioni moralistiche su vizi, virtù, amicizia, morte e destino, dedicata ad Ildeberto di Lavardin. L'opera evidenzia l'utilizzo di autori pagani come Cicerone, mostrando come Marbodo riesca a integrare la tradizione classica con la cultura cristiana senza creare un conflitto diretto. Un esempio è il De fato et genesi, dove critica l'astrologia. La sezione presenta poi un componimento dedicato alla contessa Ermengarda, dove si evidenzia l’accostamento tra la contessa e Artemide/Diana, sottolineando il tema della verginità, pur trattandosi di una donna sposata e madre. Un altro componimento analizzato è quello dedicato a Matilde di Scozia, moglie di Enrico I d'Inghilterra, in cui viene celebrata la bellezza della regina e il suo tentativo, per pudore, di nasconderla.
2. Ildeberto di Lavardin e Balderico di Bourgueil la scuola di Angers e la poesia amorosa
Ildeberto di Lavardin e Balderico di Bourgueil sono presentati come due importanti poeti della scuola di Angers, attivi nel periodo della riforma gregoriana. Entrambi, oltre all'impegno pastorale nelle rispettive diocesi (Levardin e Bourgueil), si dedicarono alla composizione di liriche profane d'amore, proseguendo la linea di Venanzio Fortunato. La loro produzione poetica è caratterizzata da una passione per i testi antichi romani e da un'attenzione particolare alla composizione di liriche amorose rivolte a nobildonne e monache. Le destinatarie principali sono donne colte, come Adele di Blois, Cecilia di Normandia e Matilde d'Inghilterra, le quali sono lodate non solo per la bellezza ma anche per la cultura e la cortesia. Il testo evidenzia la novità rappresentata dal loro modo di celebrare le donne, andando oltre i semplici elogi di bellezza e fede, per focalizzarsi sulla loro cultura e cortesia, elementi che anticipano la letteratura cortese. Si cita il componimento Ad Muriel litteratam di Ildeberto, che lamenta l'esilio e gli attribuisce l'appellativo di “novello Ovidio”.
3. Le destinatarie delle liriche nobildonne e monache
L'analisi si concentra sulle destinatarie delle liriche di Marbodo, Ildeberto e Balderico. Si distinguono due categorie principali: le nobildonne e le monache. Tra le nobildonne, sono analizzate le figure di Adele di Blois, Cecilia di Normandia e Matilde d'Inghilterra, le cui virtù principali celebrate sono la bellezza, la purezza e l’appartenenza a casate prestigiose. L'analisi si concentra anche sulle monache, tra cui Muriel e Costanza, evidenziando il diverso tipo di lode rispetto alle nobildonne, spesso focalizzata sulla loro verginità e sul loro ruolo di educande e maestre. Il testo evidenzia anche la figura della donna guerriera, presente nelle liriche dedicate alle nobildonne (ma non alle monache), che contribuisce ad elevare il loro status. La celebrazione della cultura e della cortesia femminile in queste liriche è considerata un'innovazione importante, anticipatrice di temi che troveranno ampio sviluppo nella poesia trobadorica e nella letteratura cortese, sottolineando un'evoluzione dai semplici elogi del periodo carolingio.
III.L Influenza di Ovidio e il Cantico dei Cantici
L'analisi approfondisce il ruolo di Ovidio come modello principale per la poesia amorosa mediolatina. Le Metamorfosi, gli Amores, l'Ars amatoria, e i Remedia amoris sono costantemente richiamati, anche se sottoposti a processi di moralizzazione e riadattamento al contesto cristiano. In parallelo, si esamina l'influenza del Cantico dei Cantici, esplorando come i temi dell'amore divino siano stati integrati nella poesia amorosa medievale, spesso attraverso l'allegoria. L'interazione tra questi due influssi, classico e cristiano, è centrale nella definizione dello stile e dei temi della letteratura mediolatina di questo periodo.
1. Ovidio modello principale della poesia amorosa mediolatina
Il testo identifica Ovidio come modello principale e quasi esclusivo per la poesia amorosa mediolatina. Non solo l'aspetto elegiaco e amoroso delle sue opere ( Amores, Heroides, Ars amatoria, Remedia amoris, Medicamina faciei femineae) è rilevante, ma soprattutto l'aspetto epico-mitologico delle Metamorfosi, con le sue storie d'amore e morte (Orfeo ed Euridice, Narciso, Piramo e Tisbe, utilizzate come modelli di vicende amorose esemplari nel Medioevo latino e volgare). La scelta di Ovidio come modello è motivata dalla sua capacità di creare un legame con il pubblico attraverso un linguaggio e una metrica che richiamano la cultura e i miti comuni. L'imitazione ovidiana, sottolineata nel testo, non è una mera copiatura, ma un processo di imitazione-ricreazione consapevole, che permette all'autore medievale di dialogare con il suo modello classico. L’influenza ovidiana, in particolare per quanto concerne l’esametro e il pentametro, è presente fino alla formazione, nel XII secolo, di modelli metrici perfettamente ovidiani. Si nota anche un'azione di moralizzazione cristiana delle opere di Ovidio, soprattutto delle Metamorfosi, effettuata da diversi studiosi come Arnolfo d’Orléans, Giovanni di Garlandia, Giovanni di Virgilio e Pierre Bursuire.
2. Il Cantico dei Cantici influenza religiosa e simbolica
Il Cantico dei Cantici, per la sua tematica spiccatamente amorosa, è presentato come un’importante influenza religiosa sulla poesia amorosa medievale. La sua canonizzazione, avvenuta nel II secolo d.C. dopo lunghe polemiche, fu dovuta alla sua interpretazione allegorica: l'amore descritto è visto come amore divino, con l'amebeo interpretato come un canto d'amore verso Dio. Il testo evidenzia l'interesse di Francesco Stella sull’attestazione del Cantico nell’epistolografia del XII secolo, citando diversi esempi come le lettere nelle Artes dictandi di Bernard de Meung, Bernardo di Bologna, Pietro Boattieri e Guido d’Arezzo; le lettere di Tegernsee (1160-1186); le lettere di Matteo di Vendôme; la corrispondenza tra Marbodo di Rennes e le sue allieve; le lettere tra Balderico di Bourgueil e la monaca Costanza; la Rota Veneris di Boncompagno da Signa; e le lettere di Abelardo ed Eloisa. Lo studio conclude che il Cantico dei Cantici è più attestato nella poesia d’amore del XII secolo rispetto all’epistolografia, usato come ‘canto sacro’ o ‘canto divino’, raramente come modello per la poesia erotica. Solo più tardi, nei cisterciensi e in Pietro di Blois, si sviluppa una simbologia dell'amore cristiano che attinge pienamente dal Cantico.
IV.Metrica e Stile nella Poesia Amorosa Medievale
Lo studio analizza la metrica utilizzata nella poesia latina medievale, con particolare attenzione all'utilizzo dell'esametro e del distico elegiaco, ereditati dalla tradizione classica. Si evidenzia l'introduzione della rima, in particolare la rima leonina, come innovazione metrica significativa nel XII e XIII secolo. L'analisi stilistica si concentra sulla capacità dei poeti di integrare elementi classici e cristiani, creando un linguaggio allusivo e ricco di riferimenti intertestuali, un aspetto chiave della poesia amorosa mediolatina.
1. Metrica nella poesia amorosa mediolatina tradizione classica e innovazioni
La poesia latina medievale mantiene i metri quantitativi della tradizione classica e tardo-antica, principalmente quelli dattilici (esametro e distico elegiaco), con una forte imitatio ovidiana che influenza anche le tendenze metriche. Nel XII secolo si sviluppa un esametro e un pentametro perfettamente ovidiani. L'introduzione della rima, sempre più diffusa nei secoli XII e XIII, porta alla creazione di esametri leonini e distici leonini, con la rima del primo emistichio con il secondo, creando una musicalità interna al verso. La rima leonina, con la sua corrispondenza bisillabica pura (come in datis/satis), si afferma tra la fine dell'XI e l'inizio del XII secolo, ma la sua diffusione si attenua già nel corso del XII secolo. L'utilizzo dei metri quantitativi e l'introduzione della rima mostrano la coesistenza tra la tradizione classica e le innovazioni della poesia medievale.
2. Stile e allusività nella poesia amorosa mediolatina
La poesia latina, fin dalle sue origini, è fortemente allusiva, basata su una fitta rete di ipertestualità. L'operazione di imitatio, presente anche nella poesia d'amore, non è una semplice copiatura ma una ricreazione consapevole che crea un dialogo con il modello. Questa dialettica tra continuità e contrasto con i modelli precedenti denota una grande cultura, come dimostra Ovidio. L'assorbimento di topoi, personaggi e temi della letteratura latina classica subisce un processo di simbolizzazione nel Medioevo, integrandoli con la cultura cristiana. Questa operazione di contaminazione, non sempre facile da classificare, mira a creare un clima di accettazione tra le due culture. L'allusività è una tecnica consolidata nella poesia classica (studiata da Gian Biagio Conte), ma la sua applicazione nella poesia amorosa mediolatina è un ambito di studio ancora in sviluppo. La citazione, più o meno velata, di un autore del passato da parte di uno scrittore diventa fonte di interesse per la critica e strumento di dialogo con il pubblico, creando una connessione attraverso un background culturale comune.
V.Le Donne nella Poesia Amorosa Medievale Destinatarie e Modelli
Un'analisi significativa riguarda il ruolo delle donne nella poesia amorosa mediolatina. Si esaminano le figure di nobildonne come Adele di Blois, Cecilia di Normandia e Matilde d'Inghilterra, e la loro rappresentazione nelle liriche dei tre poeti. Lo studio approfondisce come queste donne, spesso colte, potenti e influenti, siano state celebrate non solo per la loro bellezza, ma anche per la loro cultura e la loro posizione sociale. Si valuta l'importanza di questi testi come anticipatori di alcuni temi e stilemi della poesia trobadorica e della letteratura cortese.
