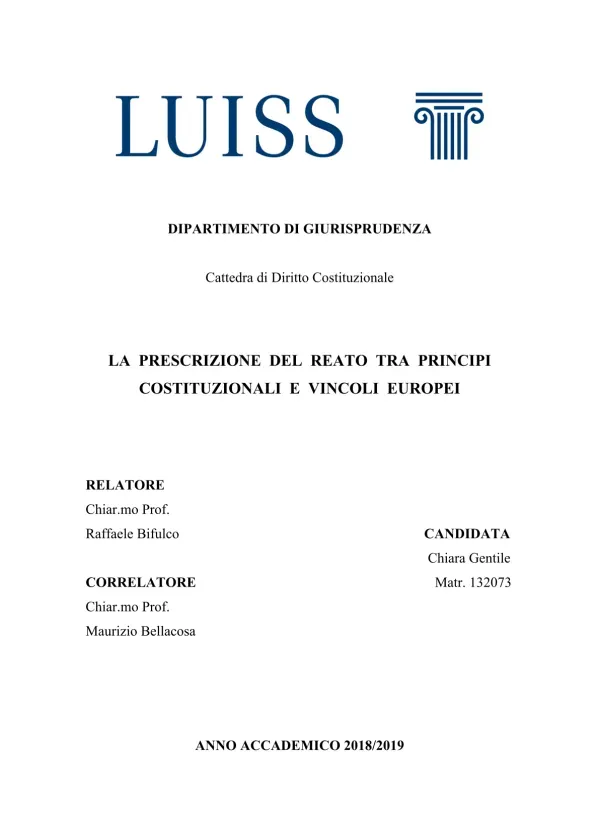
Prescrizione del reato: principi costituzionali ed europei
Informazioni sul documento
| Autore | Chiara Gentile |
| instructor | Raffaele Bifulco |
| Scuola | Dipartimento di Giurisprudenza |
| Specialità | Diritto Costituzionale |
| Tipo di documento | Tesi di Laurea |
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 0.92 MB |
Riassunto
I.La Natura della Prescrizione del Reato Sostanziale o Processuale
Questo capitolo analizza la controversa natura della prescrizione del reato nel diritto italiano. La dottrina maggioritaria, in linea con la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la considera di natura sostanziale, in accordo con il codice penale. Tuttavia, esistono opinioni dissenzienti che la definiscono processuale, come nei codici precedenti al 1930. Questa distinzione ha importanti implicazioni, soprattutto riguardo alla successione delle leggi nel tempo (nullum crimen, nulla poena sine lege vs. tempus regit actum). L'interazione con altri diritti fondamentali, come la ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), è anch'essa cruciale. Il dibattito coinvolge l'interpretazione di principi costituzionali fondamentali (art. 2, 3, 25 Cost.).
1. La Controversa Natura della Prescrizione Sostanziale o Processuale
La sezione principale si concentra sulla natura giuridica della prescrizione del reato, un istituto che genera un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Mentre la maggior parte della dottrina, seguendo la giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale e la formulazione del codice penale, attribuisce alla prescrizione una natura sostanziale, una parte rilevante della dottrina sostiene invece una natura processuale, posizione più vicina a quella dei codici precedenti al 1930. Questa divergenza di opinioni non è meramente accademica, ma ha profonde ripercussioni pratiche, soprattutto in materia di successione delle leggi nel tempo. Se la prescrizione è sostanziale, il suo regime è soggetto al principio nullum crimen, nulla poena sine lege (art. 25, co. 2 Cost.), mentre se processuale, si applica il principio tempus regit actum. La sezione evidenzia inoltre l'interazione della prescrizione con altri diritti e principi fondamentali, in particolare con il diritto alla ragionevole durata del processo (art. 111, co. 2 Cost.), sottolineando le implicazioni costituzionali di tale interazione. La determinazione della natura della prescrizione è dunque fondamentale per la corretta applicazione dei principi costituzionali.
2. Implicazioni della Natura Sostanziale o Processuale
L'attribuzione di una natura sostanziale o processuale alla prescrizione del reato ha conseguenze dirette e significative sull'applicazione del diritto. Nel caso di una natura sostanziale, il principio di nullum crimen, nulla poena sine lege (art. 25, co. 2 Cost.) diventa predominante, garantendo che la pena non possa essere applicata retroattivamente a fatti non precedentemente incriminati. Al contrario, se la prescrizione è considerata un istituto processuale, il principio tempus regit actum prevale, determinando l'applicazione della legge vigente al momento del giudizio. Questa distinzione ha ripercussioni cruciali sulla successione delle leggi nel tempo e influenza in maniera decisiva il decorso dei termini prescrizionali. La sezione analizza come la prescrizione, a prescindere dalla sua classificazione, interagisce con altri principi costituzionali, in particolare con l'art. 111, co. 2 Cost., che tutela la ragionevole durata del processo. Questa interazione solleva interrogativi sulla compatibilità di lunghi termini prescrizionali con la tutela del diritto di difesa e l'impatto sulla vita dell'imputato, che potrebbe subire di fatto una pena derivante dalla durata eccessiva del procedimento, a prescindere dalla sentenza finale.
3. Fondamento Costituzionale e Diritto all Oblio
La sezione approfondisce il dibattito sul fondamento costituzionale della prescrizione, esplorando le argomentazioni a suo favore. Si sostiene che il diritto dello Stato a perseguire i reati deve essere bilanciato con il diritto del cittadino ad avere certezza della propria vita futura, entro un tempo ragionevole rapportato alla pena comminabile. Alcuni autori individuano il fondamento costituzionale della prescrizione nell'essenza personalistica del nostro ordinamento, garantendo il rispetto dei diritti fondamentali del reo anche durante il periodo di potenziale soggezione alle sanzioni. Si argomenta che negare al tempo la capacità di estinguere il potere punitivo violerebbe diritti fondamentali come quelli sanciti dagli artt. 2 e 3 Cost., trasformando l'attesa stessa in una pena. L'istituto della prescrizione è quindi visto come portatore di un 'diritto all'oblio', consentendo al reo di riorganizzare la propria vita dopo un periodo di tempo legalmente determinato, in linea con i valori dell'ordinamento. Questo aspetto evidenzia l'importanza della prescrizione non solo per il reo, ma anche per l'equilibrio sociale e il rispetto dei diritti fondamentali.
4. Evoluzione Storica Dal Code d Instruction Criminelle al Codice Rocco
La sezione traccia un excursus storico sull'evoluzione della disciplina della prescrizione, partendo dal Code d’Instruction Criminelle del 1808 (in vigore dal 1811), che la definiva come causa estintiva dell'azione penale, quindi di natura processuale. Questo approccio, che riconosceva al tempo la capacità di incidere sull'esercizio del potere punitivo, fu poi seguito dal codice del Regno delle Due Sicilie del 1819. Quest'ultimo differenziava tra prescrizione della condanna e prescrizione dell'azione penale, prevedendo termini diversificati a seconda della gravità del reato. Il codice Rocco, invece, colloca la disciplina della prescrizione nel codice penale, non di rito, tra le cause di estinzione dell'azione penale e delle condanne. Sebbene la collocazione nel codice penale possa suggerire una natura sostanziale, l'organizzazione della disciplina e la graduazione dei termini sulla base della gravità delle sanzioni irrogabili mantengono un'affinità con la concezione processuale. L'analisi di questi diversi approcci storici contribuisce a chiarire la complessità del dibattito sulla natura della prescrizione.
II.Proposte di Riforma della Prescrizione e Esperienze Straniere
Questo capitolo esamina le proposte di modifica della prescrizione, avanzate dopo il 2005 da Parlamento, Governo, Magistratura e mondo accademico. L'analisi considera il calo degli arresti per prescrizione post-legge Cirielli (Legge 251/2005), le sentenze europee (soprattutto Taricco I del 2015), e l'esigenza di sintesi. Si confrontano le proposte con esperienze straniere e con i principi europei e costituzionali, includendo un'analisi della giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di Giustizia UE. La compatibilità con la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e i Trattati istitutivi dell'UE (inclusi gli effetti del Trattato di Lisbona sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) è attentamente valutata.
1. Analisi delle Proposte di Riforma post 2005
Questa sezione esamina le proposte di riforma del sistema della prescrizione presentate a partire dal 2005 da diverse istituzioni e personalità, tra cui membri e commissioni parlamentari, il Governo, la Magistratura e accademici. La scelta di focalizzarsi sul periodo post-2005 è motivata da diversi fattori. In primo luogo, si evidenzia un calo significativo degli arresti dei procedimenti per prescrizione intervenuta nel periodo successivo all'entrata in vigore della Legge ex-Cirielli (Legge 251/2005), suggerendo che i problemi da affrontare siano cambiati rispetto al passato. In secondo luogo, le recenti pronunce della Corte di Giustizia Europea, in particolare la prima sentenza Taricco del 2015, hanno introdotto nuove questioni e sfide nel dibattito sulla prescrizione. Infine, si sottolinea l'esigenza di sintesi e di una riforma coerente con le nuove realtà. L'analisi delle proposte mira a individuare elementi comuni e punti di divergenza, in vista di una possibile riforma del sistema.
2. Il Ruolo delle Decisioni Europee e il Dibattito Interno
L'influenza delle corti europee, sia la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU) che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), è centrale in questa sezione. Le molteplici censure della normativa italiana in materia di prescrizione, sollevate dalle due Corti, hanno fortemente contribuito al dibattito interno. La Corte EDU e la CGUE si sono pronunciate ripetutamente sulla compatibilità del regime italiano con gli obblighi derivanti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dai Trattati istitutivi dell'Unione Europea, rispettivamente. Alcune di queste decisioni, come il caso Scoppola del 2009, hanno costituito punti di riferimento per la Corte Costituzionale, mentre altre, come la saga Taricco, hanno generato conflitti e il rischio di attivazione dei controlimiti. L'analisi delle sentenze europee evidenzia la necessità di una visione più completa del sistema prescrizionale italiano, che tenga conto degli obblighi internazionali e dell'evoluzione giurisprudenziale europea. Legislatore e interprete non possono prescindere da questa giurisprudenza nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Confronto con Esperienze Straniere e Valutazione di Congruità
Questo paragrafo si concentra sul confronto tra il sistema prescrizionale italiano e le esperienze di altri paesi con una tradizione giuridica affine. L'obiettivo è identificare eventuali profili mutuabili o adattabili al nostro ordinamento. L'analisi comparativa mira a individuare soluzioni alternative e best practices per affrontare i problemi del sistema italiano, tenendo conto delle peculiarità del nostro contesto giuridico e sociale. Si valuta se modelli giuridici stranieri possano fornire spunti per una riforma più efficace ed equilibrata. Infine, la sezione si concentra sulla verifica della congruità delle proposte di riforma avanzate con i dettami europei e costituzionali, assicurando la compatibilità della legislazione italiana con gli obblighi internazionali e i principi fondamentali del nostro ordinamento. Questa analisi garantisce che qualsiasi riforma del sistema prescrizionale sia non solo efficiente, ma anche conforme al diritto internazionale e ai principi costituzionali.
III.La Prescrizione nel Codice Rocco e le successive modifiche
Si analizza la disciplina della prescrizione nel Codice Rocco, evidenziando la sua collocazione tra le cause di estinzione dell'azione penale e delle condanne, mantenendo una natura, secondo alcuni, processuale. Si esaminano le modifiche successive, inclusa la legge n. 689 del 1981 (termine per le contravvenzioni) e il d.lgs. 271/1989 (cause interruttive, art. 160 c.p.). Viene discussa la riforma del 2005 (Legge Cirielli) e le sue successive modifiche, in particolare quelle introdotte dalla legge 103/2017 (Orlando), sottolineando l'impatto sulle cause sospensive e interruttive e sul principio di retroattività della legge più favorevole (art. 2 co. 4 c.p.). Vengono analizzate le sentenze della Corte Costituzionale in merito alla ragionevolezza (art. 3 Cost.) della normativa.
1. La Prescrizione nel Codice Rocco Natura e Termini
Questa sezione analizza la disciplina della prescrizione nel Codice Rocco, evidenziando la sua collocazione all'interno del codice penale, non nel codice di rito. Questa scelta di collocazione ha generato dibattito sulla sua natura, sostanziale o processuale. Il testo sottolinea che la disciplina, nel Codice Rocco, colloca la prescrizione tra le cause di estinzione dell'azione penale e delle condanne. I termini prescrizionali non sono fissi, ma graduati in base alla gravità del reato, suddividendo le fattispecie in sei fasce di gravità, con aggiunta di termini specifici previsti da altre disposizioni di legge. Il dies a quo è generalmente il giorno della consumazione del reato, con specificazioni per reati permanenti o continuati. La sezione descrive anche le cause di sospensione e interruzione dei termini prescrizionali, sottolineando l'irrinunciabilità alla prescrizione e la sua rilevabilità d'ufficio. La disciplina del codice Rocco, pur essendo oggetto di diverse interpretazioni sulla sua natura, ha rappresentato un punto di riferimento per decenni.
2. Modifiche Legislative e Giurisprudenziali Precedenti al 2005
La sezione illustra le modifiche legislative e giurisprudenziali apportate alla disciplina della prescrizione nel periodo precedente alla riforma del 2005 (Legge ex-Cirielli). Tra le modifiche legislative si ricorda la legge n. 689 del 1981, che ha innalzato il termine prescrizionale per le contravvenzioni punite con ammenda, e l'art. 239 del d.lgs. 271/1989, che ha aggiornato l'elenco tassativo delle cause interruttive (art. 160 c.p.). Queste modifiche, pur apportando aggiornamenti specifici, non hanno modificato sostanzialmente l'impianto del sistema delineato dal Codice Rocco. L'analisi evidenzia l'evoluzione giurisprudenziale, con particolare attenzione alle interpretazioni della Corte Costituzionale in merito a specifici articoli del codice penale riguardanti la prescrizione e alla loro compatibilità con i principi costituzionali. L'esame delle modifiche pre-2005 offre un contesto fondamentale per comprendere gli sviluppi successivi e le ragioni che hanno portato alle riforme più recenti.
3. La Riforma ex Cirielli 2005 e successive modifiche Legge Orlando 2017
Questo paragrafo si concentra sulle modifiche introdotte dalla riforma ex-Cirielli del 2005 (Legge 251/2005), evidenziando che la materia, salvo alcune piccole innovazioni, era rimasta sostanzialmente immutata fino a quella data. Viene analizzato l'impatto della riforma sulle soglie minime di prescrizione, volte ad evitare l'estinzione di reati con pene inferiori, e le perplessità sollevate da alcune disposizioni, come il quinto comma dell'art. 157 c.p., che ha poi visto l'intervento chiarificatore della Corte Costituzionale. L'analisi prosegue con l'esame della Legge 103/2017 (Riforma Orlando) e del suo regime transitorio, che ha generato un ulteriore dibattito dottrinale sulla natura sostanziale o processuale della prescrizione e sulla sua applicazione ai fatti commessi prima o dopo l'entrata in vigore della riforma. Viene sottolineato il potenziale conflitto con il principio di retroattività della legge più favorevole (art. 2 co. 4 c.p.), con riferimento alla sentenza della Consulta 393/2006, che impone un vaglio di ragionevolezza per le deroghe al principio della lex mitior. Si esaminano quindi le implicazioni delle diverse riforme sull'applicazione del principio di legalità penale (art. 25 co. 2 Cost.) e del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.).
IV.Il Conflitto tra Prescrizione e Diritto Europeo il Caso Taricco
Il capitolo analizza il conflitto tra la normativa italiana sulla prescrizione e il diritto dell'Unione Europea, focalizzandosi sulla saga Taricco. Si esaminano le decisioni della Corte di Giustizia UE (Taricco I e II) che evidenziano l'incompatibilità della disciplina italiana con l'obbligo di combattere efficacemente le frodi IVA (art. 325 TFUE) e il principio di leale cooperazione (art. 4 TUE). Le sentenze evidenziano la necessità di sanzioni penali effettive e dissuasive. Viene anche analizzato il contrasto con l'art. 25, co. 2 Cost. (legalità penale e irretroattività) e il ruolo del giudice nazionale nell'applicazione della “regola Taricco” e la sua potenziale disapplicazione di norme interne in contrasto col diritto UE. L'analisi include la Direttiva (UE) 2017/1371 sull'armonizzazione parziale della prescrizione per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE.
1. Il Caso Taricco Contesto e Questioni Sollevate
Questa sezione introduce il caso Taricco, un procedimento penale per associazione a delinquere finalizzata a frodi IVA (frodi carosello), che ha messo in luce il conflitto tra la legislazione italiana sulla prescrizione e il diritto dell'Unione Europea. Il caso coinvolgeva numerosi imputati e un'evasione di IVA per milioni di euro tra il 2005 e il 2009. I reati contestati sarebbero stati soggetti a prescrizione entro termini relativamente brevi, impedendo di fatto una condanna e creando una situazione di impunità per i presunti autori. Nel 2014, il Giudice di Cuneo ha sollevato una questione pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia UE, chiedendo se la disciplina nazionale della prescrizione fosse compatibile con il diritto comunitario. La questione cruciale era se l'impunità di fatto derivante dai brevi termini di prescrizione fosse compatibile con l'obbligo dell'Italia di combattere efficacemente le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'UE.
2. Le Decisioni della Corte di Giustizia UE Taricco I e II
La sezione analizza le sentenze della Corte di Giustizia UE nel caso Taricco, distinguendo tra Taricco I e Taricco II. La Corte di Giustizia, in Taricco I, evidenzia l'obbligo degli Stati membri di adottare misure effettive, proporzionate e dissuasive per contrastare le frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, in linea con l'art. 4 § 3 TUE (leale cooperazione) e l'art. 325 TFUE. La Corte sottolinea che un sistema di prescrizione che di fatto impedisce l'applicazione di tali sanzioni è incompatibile con il diritto comunitario. Taricco II ribadisce questi principi, specificando che alla data dei fatti del procedimento penale, il regime della prescrizione in materia di IVA non era stato armonizzato a livello europeo (armonizzazione parziale solo con la Direttiva (UE) 2017/1371). La Corte riconosce la competenza del legislatore nazionale a definire la prescrizione come istituto di diritto sostanziale, ma impone ai giudici nazionali di garantire la piena efficacia del diritto UE, disapplicando le norme interne contrastanti, garantendo al contempo il rispetto dei diritti fondamentali degli imputati.
3. La Regola Taricco e la sua Compatibilità con l Ordinamento Italiano
Questa parte del testo focalizza l'attenzione sulla cosiddetta “regola Taricco” e sulla sua compatibilità con l'art. 25, co. 2 Cost. (principio di legalità penale). La Corte Costituzionale, in diverse occasioni, ha ribadito la natura sostanziale della prescrizione nel diritto interno, contrastando con l'impostazione processuale che emerge dalle decisioni della Corte di Giustizia UE. La “regola Taricco”, che impone ai giudici italiani di disapplicare le norme interne che impediscono una repressione effettiva dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE, è ritenuta dalla Corte Costituzionale problematica per il suo “deficit di determinatezza”, in contrasto con il principio di determinatezza in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.). Si evidenzia l'incompatibilità della disapplicazione diretta della “regola Taricco” con il principio di riserva di legge, in quanto implica scelte di politica criminale che spettano al legislatore, non al giudice. L'analisi si conclude sottolineando la necessità di un intervento legislativo per armonizzare il diritto nazionale con quello europeo, nel rispetto dei principi costituzionali.
4. Impatto della Direttiva UE 2017 1371 e Conclusioni
La sezione introduce la direttiva (UE) 2017/1371, che ha introdotto un’armonizzazione parziale del regime prescrizionale applicabile ai reati che ledono gli interessi finanziari comunitari. Questa direttiva, in particolare l'articolo 12, fissa termini prescrizionali minimi, al fine di garantire una repressione efficace di tali reati. L'analisi mette in luce la necessità per gli stati membri di prevedere termini che consentano di condurre le indagini, esercitare l'azione penale e completare il processo entro un tempo congruo dalla commissione dei reati. La direttiva prevede termini minimi diversi a seconda della gravità del reato. La sezione conclude riaffermando la complessità del rapporto tra prescrizione e diritto europeo, evidenziando la necessità di una riforma legislativa che garantisca sia l'efficacia della lotta contro la criminalità che il rispetto dei principi fondamentali del diritto nazionale, in particolare il principio di legalità penale e il diritto alla ragionevole durata del processo. Il caso Kolev (C-612/15), simile a Taricco, conferma questa linea giurisprudenziale della Corte di Giustizia.
V.Prospettive Future e Conclusioni
Il documento conclude riassumendo la complessità della prescrizione del reato, sottolineando la necessità di riforme urgenti. L'analisi considera la necessità di bilanciare la tutela di interessi fondamentali (certezza del diritto, diritto di difesa, diritto all'oblio) con l'esigenza di una repressione efficace dei reati, in linea con la giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di Giustizia UE. Si citano le preoccupazioni riguardo al numero elevato di procedimenti conclusi per prescrizione, soprattutto in fase di indagini preliminari, e le proposte di riforma che mirano a conciliare i diversi principi costituzionali e le norme del diritto europeo, con particolare attenzione all'art. 111 Cost. (ragionevole durata) e all'art. 3 Cost. (principio di ragionevolezza).
1. Il Conflitto tra Prescrizione e Diritto UE Il Principio di Effettività
Questa sezione analizza il conflitto tra la normativa italiana sulla prescrizione e il diritto dell'Unione Europea, focalizzandosi sul principio di effettività. La Corte di Giustizia UE, nelle sentenze Taricco, ha sottolineato l'obbligo degli Stati membri di garantire un sistema sanzionatorio effettivo, proporzionato e dissuasivo per contrastare le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione (art. 325 TFUE). La legislazione italiana sulla prescrizione, con i suoi limiti temporali, è stata ritenuta in contrasto con questo principio, in quanto limita la possibilità di effettiva repressione dei reati, anche gravi come le frodi IVA. La Corte ha evidenziato che l'impunità di fatto derivante dalla prescrizione non è un'eccezione, ma una norma nel sistema italiano, una situazione inaccettabile alla luce degli obblighi comunitari. L'art. 4 § 3 TUE, sul principio di leale cooperazione, viene richiamato come ulteriore fondamento della necessità di un sistema sanzionatorio effettivo a livello nazionale.
2. Le Sentenza Taricco I e II Implicazioni per i Giudici Nazionali
La sezione approfondisce le sentenze Taricco I e II della Corte di Giustizia UE, evidenziando le implicazioni per i giudici nazionali. Taricco I ha stabilito che la normativa nazionale sulla prescrizione deve consentire una repressione effettiva dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Taricco II conferma questo principio, precisando che, prima dell'armonizzazione parziale del regime prescrizionale con la direttiva 1371/2017, lo Stato italiano era libero di disciplinare la prescrizione come istituto di diritto sostanziale. Tuttavia, anche in questo caso, i giudici nazionali, nell'applicazione delle leggi interne, devono assicurare il rispetto degli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, senza compromettere il primato, l'unità e l'effettività del diritto dell'Unione. La Corte di Giustizia ha quindi posto in capo al giudice nazionale il compito di verificare il rispetto del principio di legalità penale e dei suoi corollari (determinatezza e irretroattività sfavorevole), disapplicando all'occorrenza le norme interne contrastanti con il diritto UE, ma solo se non si verifichi una violazione dell'art. 25, co. 2 Cost. per retroattività in malam partem.
3. Il Conflitto con l Art. 25 co. 2 Cost. e il Principio di Determinazione
Questa sezione analizza il contrasto tra la “regola Taricco” e l’art. 25, co. 2 Cost., che garantisce il principio di legalità penale, con i suoi corollari di determinatezza e irretroattività. La Corte Costituzionale ha sollevato dubbi sulla compatibilità della regola Taricco con l’ordinamento italiano, sottolineando il deficit di determinatezza della decisione della Corte di Giustizia. L'imposizione di una disapplicazione di norme interne che non consentono sanzioni penali effettive in “un numero considerevole di casi”, senza indicare criteri legislativi precisi, è considerata una violazione del principio di determinatezza. Il giudice nazionale non può essere chiamato a compiere valutazioni di politica criminale, che spettano al legislatore. La Corte richiama indirettamente il principio di riserva di legge, affermando che scelte di politica criminale devono essere formalizzate in testi legislativi accessibili ai cittadini, e che il ruolo del giudice è quello di interpretare, non di legiferare.
4. La Direttiva 1371 2017 e le Prospettive Future
Questa sezione introduce la Direttiva (UE) 2017/1371, che ha apportato un’armonizzazione parziale del regime prescrizionale per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’UE, cercando di superare le criticità evidenziate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. La direttiva fissa termini prescrizionali minimi per garantire l'effettiva repressione di tali reati, con differenziazioni in base alla gravità della pena. L'analisi conclude che, nonostante le recenti riforme legislative italiane (Orlando e successiva), il problema della compatibilità tra il regime della prescrizione e il diritto UE rimane complesso e aperto, richiedendo un continuo dialogo tra le corti nazionali e sovranazionali. Si sottolinea ancora una volta l'alto numero di procedimenti conclusi per prescrizione in Italia, segnalando la necessità di una riflessione approfondita che tenga conto della lentezza della giustizia e della necessità di bilanciare l'esigenza di effettiva repressione del crimine con la tutela dei diritti fondamentali degli imputati.
