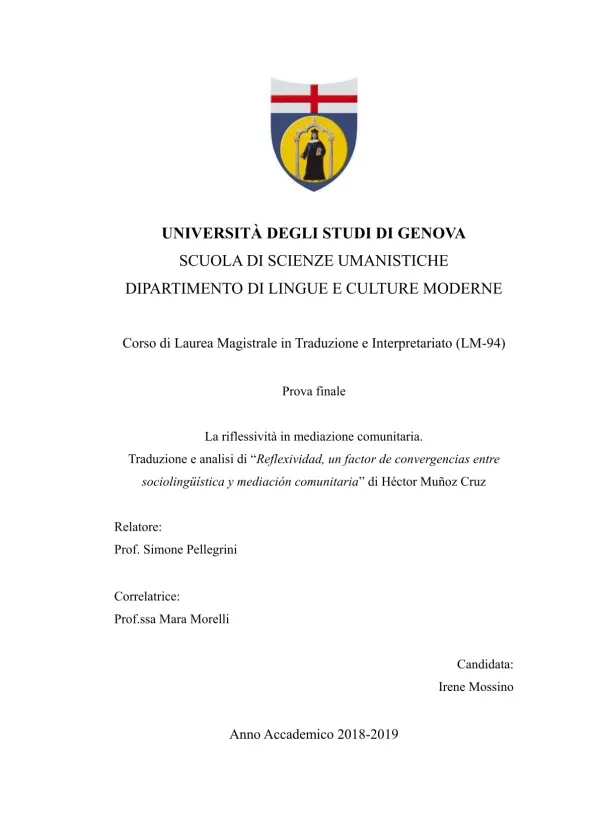
Riflessività in Mediazione: Tesi di Laurea
Informazioni sul documento
| school/university | Università Degli Studi Di Genova, Scuola Di Scienze Umanistiche, Dipartimento Di Lingue E Culture Moderne |
| subject/major | Traduzione E Interpretariato (LM-94) |
| Tipo di documento | Prova Finale (Thesis) |
| city where the document was published | Genova |
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 1.04 MB |
Riassunto
I.Intenzionalità e Riflessività nella Comunicazione Linguistica
Il documento analizza i meccanismi di intenzionalità e riflessività come elementi fondamentali della comunicazione linguistica, in particolare nell'ambito della mediazione interculturale. L'intenzionalità riguarda l'obiettivo comunicativo del parlante, mentre la riflessività implica un'analisi critica del processo comunicativo stesso, considerando le comunità, i parlanti e la lingua. La riflessività sociolinguistica è esplorata come un'abilità umana cruciale nelle interazioni sociali, particolarmente rilevante nel lavoro dell'interprete e del mediatore culturale.
1. Definizione di Intenzionalità e Riflessività
La sezione introduttiva pone le basi teoriche dell'analisi, definendo l'intenzionalità e la riflessività come due meccanismi fondamentali che coesistono in ogni atto comunicativo. L'intenzionalità è descritta come un processo relativamente evidente: il parlante si rivolge all'ascoltatore con un obiettivo specifico, mentre quest'ultimo riceve il messaggio e reagisce. La riflessività, invece, è un concetto più complesso che richiede un'analisi dell'opposizione tra pratica comunicativa e le sue rappresentazioni. Gli elementi base della riflessività sono identificati nelle comunità, nei parlanti e nella lingua stessa, elementi che costituiscono il fondamento delle rappresentazioni della pratica comunicativa. L'intenzionalità è vista come la parte meccanica della comunicazione, che permette il contatto tra parlante e ascoltatore; la riflessività, che si sviluppa in parallelo, regola il significato, la filosofia e lo spirito della comunicazione, senza necessariamente richiedere una conoscenza approfondita del linguaggio (Miglietta, 2018). Si introduce quindi il concetto di riflessività sociolinguistica, evidenziandone la complessità e la necessità di un'analisi approfondita.
2. Riflessività come Abilità Umana e Processo Interpretativo
Questa sezione approfondisce la natura della riflessività, definendola, sulla base degli studi di De la Cuesta-Benjumea (2011), come un'abilità umana presente nelle interrelazioni sociali. Sebbene l'autrice non si riferisca esplicitamente all'interpretazione, l'atto interpretativo, che richiede la presenza di almeno tre persone (due parlanti lingue diverse e un interprete), viene considerato un esempio di interrelazione sociale. La riflessività viene quindi descritta come un processo di auto-esame, in cui l'individuo, in questo caso specifico l'interprete, ripercorre il proprio lavoro e ne valuta l'effetto. Muñoz (2018) sostiene che il mediatore, essendo parziale, deve controllare le proprie convinzioni, frutto di possibili distorsioni del pensiero, e riflettere su se stesso per svolgere un buon lavoro. Si introduce, quindi, la connessione tra mediazione culturale e riflessività sociolinguistica, evidenziando come le strutture linguistiche, socioculturali ed etiche influenzino i contenuti della riflessività stessa. L’importanza della riflessione è ulteriormente sottolineata citando l'affermazione che l'incapacità di pensare e di riflettere è pericolosa anche per individui molto intelligenti; mentre non è causa di malvagità, essa è necessaria per compiere azioni malvagie (De Luise e Morelli, 2018).
3. Riflessività e Mediazione nel Supporto agli Immigrati
Questa parte del testo applica il concetto di riflessività al contesto della mediazione con gli immigrati. Baraldi (2017), nello studio di un caso in un centro italiano di aiuto agli immigrati, evidenzia il ruolo fondamentale della mediazione nell'applicazione dei mezzi istituzionali per sostenere gli immigrati nell'espressione dei loro problemi e nella ricerca di soluzioni. Tuttavia, viene chiaramente affermato che la mediazione non può risolvere la condizione di disuguaglianza ed esclusione sociale che gli immigrati spesso sperimentano nella società italiana. Questo evidenzia le limitazioni strutturali delle interrelazioni istituzionali. Nonostante ciò, l'analisi suggerisce che questa constatazione può essere un punto di partenza per un'analisi critica, anche dal punto di vista della riflessività, allo scopo di sviluppare un sistema di comunicazione più efficace ed inclusivo che permetta agli immigrati di sentirsi a proprio agio. Si pone quindi l'attenzione sulla necessità di superare le limitazioni strutturali per migliorare l'integrazione degli immigrati, sottolineando il ruolo della riflessione critica in questo processo.
II.La Riflessività nella Mediazione Culturale e Linguistica
L'analisi si concentra sul ruolo della riflessività nelle mediazioni culturali, evidenziando come le strutture di riferimento linguistico, socioculturale ed etico influenzino la riflessività stessa. L'incapacità di riflessione è considerata pericolosa, anche in presenza di grande intelligenza, e la riflessione viene proposta come strumento per prevenire azioni dannose. Si discute del ruolo fondamentale della mediazione nel supporto agli immigrati, pur riconoscendo i limiti strutturali delle interrelazioni istituzionali nel risolvere le disuguaglianze sociali. L'obiettivo è sviluppare una comunicazione più efficace che favorisca il benessere degli immigrati in contesti complessi.
1. Riflessività Sociolinguistica e Mediazioni Culturali
Questa sezione approfondisce il ruolo delle mediazioni culturali nei contenuti della riflessività sociolinguistica. Si evidenzia come strutture di riferimento linguistico, socioculturale ed etico, inerenti alla convivenza e ai ragionamenti, intervengano nella riflessività stessa. L'autrice cita l'idea che l'incapacità di riflessione, o di pensare in modo critico, sia pericolosa anche in presenza di grande intelligenza, non essendo essa causa di malvagità, ma condizione necessaria per compierla. Il dialogo interiore, definito da Socrate come "pensare", è presentato come un potenziale strumento preventivo rispetto alle azioni dannose (De Luise e Morelli, 2018). Si sottolinea l'importanza della riflessione critica nel contesto della mediazione interculturale, in particolare per quanto riguarda il supporto agli immigrati. Uno studio di caso (Baraldi, 2017) evidenzia il ruolo fondamentale della mediazione nell'applicazione di mezzi istituzionali per aiutare gli immigrati a esprimere i propri problemi, ma allo stesso tempo, sottolinea i limiti strutturali delle interrelazioni istituzionali nel far fronte alle disuguaglianze sociali. La riflessività viene quindi presentata come strumento per sviluppare sistemi di comunicazione più efficaci e inclusivi.
2. Dominio Culturale e Pratiche Riflessive
La sezione si concentra sul ruolo della dominanza culturale come cornice storica complessa delle pratiche riflessive. Nozioni quali "status", "prestigio", "potere", "egemonia", "influenza" e "dominanza" si sovrappongono nei discorsi riflessivi, rendendo complessa la comprensione della superiorità e dell'alterità. L'analisi delle scienze sociali oscilla tra un approccio focalizzato sulla struttura sociale e sulle relazioni di dominanza e un approccio sulle caratteristiche specifiche di ciascun gruppo. Si evidenzia come non si tratti di una separazione radicale, ma di due tipi di analisi differenti di una stessa problematica, che richiedono un'analisi interna ed esterna dei gruppi. La comprensione di queste dinamiche richiede un approccio multidimensionale, considerando la complessità delle relazioni di potere e influenza all'interno delle comunità. Si introduce l'importanza di considerare diversi punti di vista per una comprensione più completa della realtà sociolinguistica, evitando generalizzazioni semplicistiche e riconoscendo la complessità delle dinamiche sociali.
3. Strumenti Analitici Explicaciones de Interés e Subiettività
Questa parte presenta le strutture discorsive riflessive, conosciute come "explicaciones de interés", come strumenti per analizzare i conflitti comunitari e per comprendere i ragionamenti degli individui coinvolti. Queste strutture, caratterizzate dai loro obiettivi, bisogni e problemi, sono considerate compatibili con le verità e le richieste di rivendicazione dei gruppi interessati, diventando componenti della realtà in disputa. L'occultamento dei motivi individuali viene visto come un sintomo nei tentativi esplicativi. Knuuttila (2002) evidenzia la natura spesso "estropeada" di queste spiegazioni, richiedendo maggiore attenzione analitica senza necessariamente implicare un rifiuto. Si sottolinea l'importanza di considerare la soggettività come risorsa epistemologica, andando oltre la finzione di oggettività, per accedere ai significati profondi dei ragionamenti riflessivi. L’analisi della riflessività sociolinguistica presuppone che le operazioni intellettuali siano strutturate dalla presenza di fattori di mediazione, senza per questo considerarla una limitazione. Si evidenzia però la scarsità di sforzi metodologici ed epistemologici in linguistica per creare metodi alternativi di mediazione che minimizzino i pregiudizi del mediatore.
III.Rappresentazioni Cognitivi e Conflitti Sociolinguistici
Il testo esplora le rappresentazioni cognitive nei processi di intenzionalità progettata, sottolineando come le comunità umane non siano una semplice somma di individui, ma complesse strutture di interrelazioni. Si analizzano le norme di interazione comunicativa, considerate spesso come automatismi, e si evidenzia la necessità di considerare la soggettività come risorsa epistemologica per una comprensione più profonda dei ragionamenti riflessivi. Il concetto di dominanza culturale è presentato come un contesto frequente e complesso nelle pratiche riflessive, con nozioni come 'status', 'prestigio' e 'potere' che si intrecciano nei discorsi riflessivi.
1. Rappresentazioni Cognitive e Intenzionalità Progettata
La sezione approfondisce il ruolo delle rappresentazioni cognitive nell'intenzionalità progettata, evidenziando che le comunità umane non sono semplici somme di individui con interpretazioni indipendenti, ma complesse strutture di interrelazioni. Attraverso l'interazione sociale, i parlanti producono e negoziano i significati attribuiti alle lingue e alle culture, creando così specifici modelli di intenzionalità progettata, definiti da Bruner come "formati". L'analisi si concentra sul modo in cui queste rappresentazioni cognitive influenzano la progettazione e l'implementazione delle politiche linguistiche. Le norme di interazione comunicativa, spesso percepite come oggettive e naturali, sono in realtà convenzioni sociali che si impongono in modo quasi irresistibile (Aracil, 1982). Queste norme vengono seguite quasi automaticamente, dando l'illusione di una comprensione completa del loro significato, mentre si perdono di vista alternative possibili. L'analisi sottolinea come la comprensione di queste dinamiche richieda un'analisi attenta dei meccanismi cognitivi sociali e individuali coinvolti nella formazione delle rappresentazioni e nella negoziazione dei significati.
2. Dominanza Culturale e Ideologie nei Conflitti Sociolinguistici
Questa sezione esplora il contesto storico della dominanza culturale nelle pratiche riflessive, evidenziando la complessità delle relazioni tra diversi gruppi sociali. Nozioni come "status", "prestigio", "potere", "egemonia", "influenza" e "dominanza" sono analizzate nella loro sovrapposizione nei discorsi riflessivi. La comprensione di superiorità e alterità richiede un approccio multidimensionale, considerando le caratteristiche specifiche di ogni gruppo, ma anche la struttura sociale e le relazioni di dominanza. Si evidenzia la necessità di un'analisi sia interna che esterna ai gruppi per una comprensione completa del fenomeno. L'accesso a informazioni e conoscenze sulle lingue, comunità e culture è fondamentale per analizzare il ruolo delle ideologie nel plasmare le caratteristiche culturali, etniche e linguistiche delle comunità. Spesso le ideologie utilizzano riferimenti valutativi, indipendentemente da informazioni sistematiche, impedendo una comprensione del percorso di sviluppo delle società etnolinguistiche dal monoculturalismo egemonico al multiculturalismo plurale.
3. Strumenti Analitici e la Necessità di un Approccio Integrato
La sezione presenta strumenti analitici per comprendere le pratiche riflessive, focalizzandosi sulle strutture discorsive riflessive come le "explicaciones de interés". Queste strutture, che mettono in luce gli obiettivi, le necessità e i problemi dei gruppi, sono considerate compatibili con le verità e le richieste di rivendicazione dei gruppi coinvolti. L'occultamento dei motivi individuali è un sintomo degli intenti esplicativi. L'analisi richiede una maggiore attenzione alla soggettività come risorsa epistemologica, andando oltre la finzione di oggettività per comprendere appieno i significati. Si sottolinea la necessità di un approccio integrato che consideri la cognizione, la valutazione e il ragionamento riflessivo come processi inseparabili dalle pratiche reali dei soggetti, intesi come sistemi di relazioni. L'entità concettuale principale include il soggetto (individuale o gruppale), il suo oggetto, le filosofie dell'epoca, la comunità, l'organizzazione sociale e le norme di comportamento (Engeström, 1999). La dicotomizzazione del pensiero umano rappresenta una barriera nella comprensione del cambiamento, impedendo una convivenza armonica dei gruppi. È necessario un riconoscimento ufficiale di tutti i gruppi linguistici e la soluzione della necessità di intercomunicazione.
IV.Strumenti Analitici per la Riflessività Sociolinguistica
Il documento propone l'utilizzo delle strutture discursive riflessive, in particolare le 'explicaciones de interés', come strumento per comprendere i ragionamenti degli attori coinvolti nei conflitti socioculturali e linguistici. Si discute dell'importanza di considerare sia la soggettività che la finzione di oggettività nell'analisi della riflessività. Si sottolinea la scarsità di sforzi metodologici ed epistemologici nella linguistica per creare metodi alternativi di mediazione che minimizzino i pregiudizi del mediatore. Viene discusso il ruolo del multiculturalismo propositivo e la critica ai paradigmi coloniali nella comprensione dei conflitti etnolinguistici.
1. Strutture Discorsive Riflessive Le Explicaciones de Interés
Questa sezione introduce le "explicaciones de interés" come strumenti analitici per la riflessività sociolinguistica. Queste strutture discorsive riflessive, caratterizzate da un ruolo determinante degli obiettivi, delle necessità e dei problemi dei gruppi coinvolti, favoriscono una migliore comprensione dei ragionamenti degli attori nei conflitti socioculturali e linguistici. I loro pattern tendono ad essere compatibili con le verità e le richieste di rivendicazione dei gruppi, diventando così componenti della realtà in disputa. L'occultamento dei motivi individuali è visto come sintomo di problemi negli intenti esplicativi, secondo Knuuttila (2002), che evidenzia una natura spesso imperfetta di queste spiegazioni, richiedendo maggiore attenzione analitica senza implicare il loro rifiuto. L'analisi delle "explicaciones de interés" richiede una attenta considerazione della soggettività e della sua importanza come risorsa epistemologica per esplorare i significati dei ragionamenti riflessivi.
2. Il Ruolo della Soggettività e della Finzione di Oggettività
La sezione evidenzia l'importanza di considerare la soggettività come risorsa epistemologica nell'analisi della riflessività sociolinguistica. Pur riconoscendo il peso della finzione di oggettività, l'analisi si concentra sulla necessità di valorizzare la soggettività per approfondire la comprensione dei ragionamenti riflessivi. L'analisi della riflessività sociolinguistica presuppone che le operazioni intellettuali di descrizione, giudizio e ragionamento sulle persone, le lingue e le comunità siano intrinsecamente strutturate dalla mediazione, inclusi i mediatori stessi. Nonostante ciò, si sottolinea la scarsità di sforzi metodologici ed epistemologici in linguistica per creare forme alternative di mediazione che aprano gli intenti di mediazione a qualsiasi forma di conoscenza e, di conseguenza, minimizzino o eliminino i possibili pregiudizi del mediatore. Si evidenzia la complessità dell'analisi della riflessività, riconoscendo la mancanza di strumenti analitici adeguati per affrontare tale sfida.
3. Modelli di Mediazione e la Relazione tra Soggetti Mediatore e Conflitto
Il testo approfondisce la dinamica della interrelazione tra soggetti, mediatore e conflitto comunitario. Viene sottolineato che la disponibilità di informazioni e conoscenze sulle lingue, comunità e culture coinvolte è fondamentale. Spesso le ideologie che tipificano le caratteristiche culturali, etniche e linguistiche utilizzano riferimenti valutativi indipendentemente da informazioni sistematiche, ostacolando la comprensione del percorso di sviluppo delle società etnolinguistiche. L’analisi si concentra sulla necessità di strumenti che dinamizzino l'interrelazione soggetti-mediatore-conflitto comunitario. Si discute la difficoltà teorica di comprendere le relazioni tra le diverse mediazioni culturali nella riflessività sociolinguistica. Un approccio proposto (Wartofsky, 1973) suggerisce che sotto ai ragionamenti e alle attività riflessive si celino strutture di informazioni e valori di convivenza. Queste strutture permettono lo sviluppo di due operazioni che creano significato: la scelta o gerarchizzazione dei tratti di una identità etnoculturale e linguistica, e la correlazione di questi tratti con ideologie, etiche e priorità sociopolitiche.
V.Il Ruolo del Linguaggio nel Pensiero e nella Cognizione Sociale
L'analisi di Coseriu sulla relazione tra linguaggio e pensiero viene considerata fondamentale per comprendere il fenomeno riflessivo sociolinguistico. L'interrelazione 'enérgeia-ergon' viene utilizzata per distinguere tra attività significativa e creativa (enérgeia) e prodotti sociali e semiotici (ergon). Si introduce il modello di Vigotskij per descrivere la relazione tra individuo, ambiente e mediazione tramite artefatti, evidenziando il ruolo della mediazione culturale nella costruzione della conoscenza. Si approfondisce il concetto di intenzionalità secondo Searle, distinguendo tra stati intenzionali e condizioni di soddisfazione.
1. L analisi di Coseriu Linguaggio Pensiero e Conoscenza
Questa sezione si concentra sull'analisi di Coseriu sulla relazione tra linguaggio, pensiero e conoscenza, considerata decisiva per chiarire la relazione tra linguaggio e pensiero nel contesto sociolinguistico. L'interrelazione 'enérgeia-ergon' è proposta come strumento analitico per distinguere gli elementi del fenomeno riflessivo sociolinguistico. L'enérgeia, intesa come attività significativa e creativa, include azioni riflessive di interpretazione sociolinguistica come qualificazioni metalinguistiche, tematizzazioni, narrazioni di identità (Ricoeur, 1981), dichiarazioni enfatiche e ragionamenti di diverso ordine intenzionale (Dennett, 1996) sulle condizioni comunitarie, i parlanti e le culture. L'ergon, invece, si riferisce ai prodotti sociali e semiotici che riproducono lo stato e la funzionalità delle comunità, come spazio gestionale e riflessivo. In questo ambito vengono inclusi i generi discorsivi, le politiche pubbliche e i significati che attraversano la politica e le attività riflessive dei cittadini. I prodotti riflessivi sono quindi considerati strumenti adatti ad esprimere informazioni in modi diversi, a seconda delle situazioni.
2. Il Modello di Vigotskij Mediazione e Funzioni Culturali
La sezione introduce il modello di Vigotskij per descrivere la relazione strutturale tra individuo, ambiente e mediazione tramite artefatti. Questo modello, rappresentato da un triangolo, distingue tra funzioni naturali (non mediare) alla base e funzioni culturali (mediate) all'apice, rappresentando la relazione tra soggetto e contesto. Questa visione dell'ergon riflessivo come strumento o artefatto si collega a una teoria della cultura che si costruisce nella mente a partire dall'organizzazione di azioni mediate nella pratica quotidiana (Vigotskij, 1996). Si sottolinea come le funzioni culturali, mediate dagli artefatti, rappresentino la relazione tra soggetto e contesto, evidenziando il ruolo fondamentale della mediazione nella costruzione della conoscenza e nella comprensione delle dinamiche socioculturali. L'approccio di Vigotskij fornisce un quadro teorico per analizzare il ruolo degli artefatti culturali, inclusi i prodotti riflessivi, nella costruzione della conoscenza e nella comprensione delle dinamiche socioculturali.
3. Intenzionalità Cognizione Sociale e Processi di Predizione e Interpretazione
La sezione approfondisce i processi intenzionali di predizione e interpretazione del senso di azioni e decisioni nel contesto sociale. Si fa riferimento a recenti norme legali sulle politiche di apertura della società messicana alla diversità linguistica e culturale, che promuovono l'interpretazione e la predizione della possibilità di estendere l'apprendimento delle lingue indigene nei settori di lingua spagnola e di assegnare alle lingue indigene lo stesso status dello spagnolo. Si evidenzia il rischio legato all'intenzionalità progettata di una politica linguistica dichiarata ma non implementata. La realtà dello scambio comunicativo mostra un'evoluzione nell'assimilazione delle lingue indigene, anche in ambiti privati e familiari. Nonostante le preferenze per il cambiamento linguistico, le predizioni tradizionali del progetto etnolinguistico continuano a favorire il ragionamento che la sopravvivenza delle lingue si basi esclusivamente sull'ethos comunitario. L’analisi si concentra sul modo in cui i parlanti, nel contesto della propria società, eseguono questi processi intenzionali, sottolineando la complessità delle dinamiche sociolinguistiche e l'influenza delle politiche linguistiche sulle comunità.
VI.Sfide e Soluzioni nei Conflitti Etnolinguistici
Il documento affronta le difficoltà teoriche nella comprensione dei conflitti etnolinguistici, in particolare la tendenza alla dicotomizzazione nel pensiero che ostacola la convivenza armonica dei gruppi. Si propone la necessità di un riconoscimento ufficiale di tutti i gruppi linguistici, oltre alla preservazione della diversità linguistica e della dignità di tutti i gruppi. Si esplorano le possibili forme alternative di organizzazione politico-linguistica per conciliare la preservazione della diversità linguistica e la necessità di intercomunicazione. L'analisi si conclude con una riflessione sulla soggettività e la riflessività, mettendo in discussione il dualismo corpo-anima e l'esclusione della cultura popolare nelle scienze sociali.
1. La Dicotomizzazione del Pensiero e il Contatto Linguistico
Questa sezione affronta la tendenza umana alla dicotomizzazione del pensiero come ostacolo alle concezioni del cambiamento, soprattutto nel contesto del contatto linguistico. La dicotomia è presentata come un fattore che impedisce un'organizzazione armonica della convivenza tra i diversi gruppi partecipanti. Il testo sottolinea la necessità di un riconoscimento ufficiale di tutti i collettivi linguistici co-presenti, insieme alla risoluzione della necessità di intercomunicazione. L'impossibilità di una convivenza armonica spinge ad esplorare forme alternative di organizzazione politico-linguistica che permettano di conciliare la preservazione della diversità linguistica e la dignità di tutti i gruppi linguistici storici, con la necessità di una intercomunicazione fluida e un sentimento di solidarietà. Si evidenzia quindi la difficoltà di immaginare soluzioni adeguate ai problemi complessi della convivenza multiculturale e multilingue, in particolare per le comunità urbane e rurali contemporanee.
2. Soluzioni e Strategie per la Gestione dei Conflitti Etnolinguistici
La sezione analizza le difficoltà teoriche nell'individuazione di soluzioni efficaci ai conflitti etnolinguistici. Si riconosce la lacuna presente nella prospettiva sociolinguistica contemporanea, che fatica a proporre soluzioni concrete. Alcuni sforzi si concentrano sull'analisi della possibilità di trasformare i comportamenti individuali e le tutele istituzionali che limitano la gestione comunitaria dei problemi. Con minore visibilità, si evidenziano approcci qualitativi interculturali che mirano a riformare il pensiero (Morin, 1999) e a creare le condizioni per produrre e trasferire conoscenza e informazione sulle domande e sulle necessità comunitarie. L'obiettivo è che la conoscenza e l'informazione siano valide, affidabili e articolate, evitando un trattamento superficiale dei dati. Si evidenzia quindi la necessità di un approccio più olistico e meno dicotomico per affrontare le sfide poste dai conflitti etnolinguistici, combinando analisi quantitative e qualitative per una comprensione più completa.
3. Conclusioni Superare il Dualismo e l Esclusione della Cultura Popolare
La sezione conclusiva riassume le riflessioni sul fenomeno della soggettività e della riflessività, sottolineando come, nonostante la mancanza di cambiamenti paradigmatici dalla terza decade del XX secolo, i progressi accademici attuali sulla produzione della conoscenza umana potrebbero portare a una rivalutazione del dualismo corpo-anima e dell'esclusione della cultura popolare nelle scienze sociali. Si suggerisce che una visione standard della coscienza, che associa la mente o l'anima ad elementi soggettivi, incommensurabili e magici, potrebbe essere superata. L'analisi del caso delle comunità urbane permette di impiegare tradizioni accademiche ed esplorare gli ostacoli concettuali per affrontare le richieste e i conflitti. Si ribadisce quindi la necessità di un approccio integrato, superando le visioni dicotomiche e includendo la cultura popolare per una comprensione più completa e una soluzione più efficace dei conflitti etnolinguistici.
