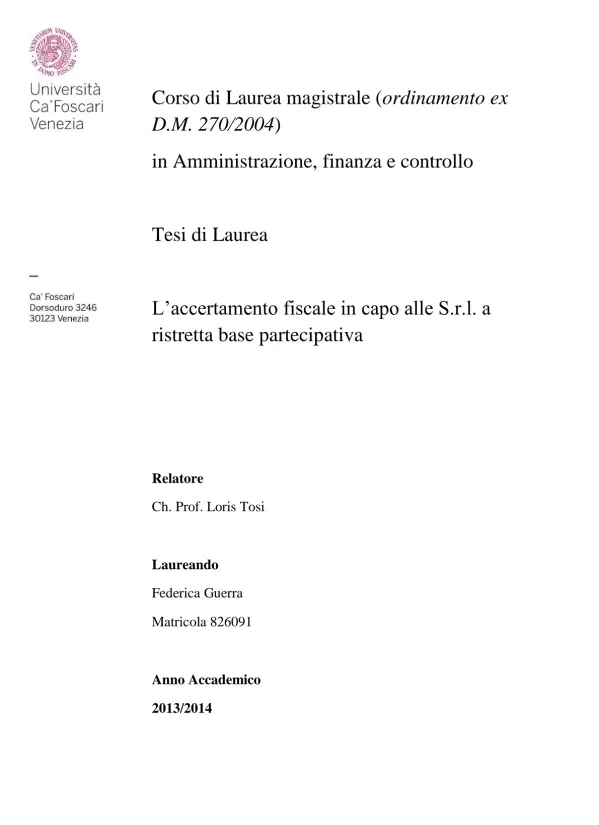
L'accertamento fiscale nelle S.r.l. a ristretta base partecipativa
Informazioni sul documento
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 705.42 KB |
| Specialità | Amministrazione, finanza e controllo |
| Tipo di documento | Tesi di Laurea Magistrale |
Riassunto
I.Società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa
Sono società caratterizzate da una ristretta base sociale, che consente una maggiore conoscenza degli affari societari e una maggiore possibilità di accordi tra i soci. Questo aspetto è rilevante ai fini fiscali in quanto, nelle società a ristretta base partecipativa, si presume che i maggiori utili accertati in capo alla società siano distribuiti ai soci come utili in "nero".
1. Introduzione
Il presente elaborato analizza le S.r.l. a ristretta base partecipativa, ponendo attenzione all'accertamento tributario e alle conseguenze che ne derivano nel caso in cui venga accertato, in capo alla società, un maggior reddito rispetto a quello dichiarato. Le diverse sentenze della Cassazione hanno riconosciuto la legittimità della presunzione di distribuzione, che comporta l'imputazione ai soci dei maggiori utili accertati, superando quella disposizione normativa che prevede, nel caso delle società di capitali, una netta separazione tra la posizione tributaria della società e quella dei soci.
1.2 La nuova S.r.l. centralità del socio e modalità di distribuzione degli utili
Il nostro Paese si caratterizza per la presenza di imprese di piccole e medie dimensione. E' frequente infatti, la costituzione di società di capitali a ristretta base partecipativa o familiare, che hanno permesso spesso l'occultamento di ricavi o la simulazione di costi. L'Amministrazione Finanziaria ha cercato di contrastare questo fenomeno, tentando di individuare i redditi che, accertati in capo alla società di capitali, fossero stati distribuiti, come utili “in nero” ai soci, in contrasto con quanto disposto dalle norme reddituali e in materia di sostituti d'imposta.
2. Società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa
Innanzitutto, è necessario sottolineare che nel nostro ordinamento non esiste una definizione giuridica di questo tipo di società e neppure una limitazione giuridica del numero dei soci o delle relazioni che tra loro intercorrono. Tale concetto è frutto di una elaborazione della dottrina, della giurisprudenza e della pratica amministrativa, le quali hanno fatto ricorso a questa figura, in quanto, ancorché non codificata in nessuna disposizione di legge, riesce a definire l’area soggettiva entro la quale ritenere probabile un accordo occulto tra i soci.
4. La distribuzione degli utili
La distribuzione degli utili nelle società di capitali è disciplinata dall’art. 2478-bis, comma 3, codice civile. Esso stabilisce che in sede di approvazione del bilancio, i soci debbano decidere anche sulla distribuzione degli utili. Questa previsione normativa si basa sul fatto, che la decisione sulla distribuzione degli utili è strettamente collegata all’approvazione bilancio di riferimento.
5. Accertamenti tributari su società e soci
Dal punto di vista fiscale, la tassazione dei dividendi nelle società di capitali, ha subito una evoluzione normativa, passando al nuovo regime in seguito alla riforma attuata con il D.Lgs. n. 344 del 12 dicembre 2003.
6. Presunzioni legali
Il maggior reddito rilevato in sede di verifica fiscale nei confronti della società, si presume distribuito tra i soci sulla base dei rapporti di complicità, solidarietà e reciproco controllo che caratterizzano le compagini sociali ristrette. Questi elementi generano la presunzione di distribuzione, al solo manifestarsi di una pretesa tributaria nei confronti della società partecipata.
7. La tutela dei soci
In queste ipotesi la società è solidamente responsabile con i soci per l’imposta, le sanzioni e gli interessi, legati all’imputazione del reddito.
8. Conclusioni
In queste ipotesi la società è solidamente responsabile con i soci per l’imposta, le sanzioni e gli interessi, legati all’imputazione del reddito.
II.Presunzione di distribuzione dei maggiori utili
La presunzione di distribuzione dei maggiori utili è un principio giuridico che viene applicato nelle società a ristretta base partecipativa. Questa presunzione si basa sul fatto che, in queste società, è più probabile che ci siano accordi occulti tra i soci e che gli utili vengano distribuiti in modo non corretto. La presunzione di distribuzione degli utili non viola il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto non si tratta di una presunzione che trae origine da un'altra presunzione, ma di una presunzione che si fonda su elementi specifici, come la ristrettezza della base sociale e i rapporti di solidarietà e di reciproco controllo che caratterizzano i soci.
III.Accertamento fiscale nelle società a ristretta base partecipativa
Nelle società a ristretta base partecipativa, l'accertamento fiscale viene effettuato nei confronti della società stessa. Tuttavia, il maggior reddito accertato viene imputato ai soci, sulla base della presunzione di distribuzione degli utili. È possibile per il socio dimostrare che non ha percepito gli utili che gli vengono attribuiti, fornendo prova contraria, come ad esempio l'assenza di poteri di controllo o di effettiva gestione in ambito societario.
IV.Elusione fiscale e presunzione di distribuzione degli utili
La presunzione di distribuzione degli utili non opera nel caso delle società ad azionariato diffuso, in quanto si ritiene che in queste società non si possano verificare accordi tra i soci con carattere di complicità. Tuttavia, la presunzione opera nei casi in cui vengono rilevati ricavi "occulti", a meno che il socio sia in grado di dimostrare l'esistenza di componenti negativi di reddito non contabilizzati, ma correlati ai maggiori ricavi oggetto dell'accertamento.
V.Sospensione del procedimento di accertamento
Nel caso in cui una società, a seguito di un accertamento e della conseguente rilevazione di maggiori ricavi e/o costi inesistenti, presenti comunque un risultato negativo, il socio può richiedere la sospensione del procedimento di accertamento sulla base dell'art. 295 del Codice di procedura civile. Questo articolo stabilisce che la sospensione necessaria del processo deve essere disposta se la decisione della controversia dipende dalla definizione di un'altra causa, esistendo tra di esse un vincolo di consequenzialità.
VI.Accertamento nei confronti della società e dei soci
L'art. 58 del D.P.R. n. 600/1973 prevede che, nel caso di esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni in forma associativa, l'ufficio competente all'accertamento nei confronti della società effettua la definizione anche del reddito attribuito ai soci, con unico atto e in loro contraddittorio.
1.2 La nuova S.r.l. centralità del socio e modalità di distribuzione degli utili
In Italia l’Istituto giuridico delle Società a responsabilità limitata nasce dal codice del 1942. Sino a quel momento i codici di commercio avevano sempre suddiviso le società commerciali in società collettive, accomandite e/o anonime.
Considerando che il recesso comporta il rimborso della partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, si desume che l’eventuale ampliamento delle ipotesi di uscita dalla compagine sociale “ristretta” comporterebbe lo scioglimento per incapienza patrimoniale.
1.6 La distribuzione degli utili nelle società di capitali
Dal punto di vista fiscale, la tassazione dei dividendi nelle società di capitali, ha subito una evoluzione normativa, passando al nuovo regime in seguito alla riforma attuata con il D.Lgs. n. 344 del 12 dicembre 2003.
Il sistema precedente prevedeva la tassazione dei redditi prodotti dalle società di capitali, con riferimento ad un determinato periodo d’imposta, secondo il principio della “competenza”. Tali redditi erano assoggettati all’Irpeg, mentre i soci erano tassati mediante l’imposta personale progressiva, solo nel momento in cui avessero percepiti dei dividendi.
2. Accertamento nei confronti della società e dei soci
Infatti, nel caso di accertamento di un maggiore reddito in capo ad una società di capitali a ristretta base partecipativa, esso viene imputato “pro quota” ai soci. Questo “ribaltamento” non viene eseguito in applicazione di una disposizione di legge specifica, ma in forza di una presunzione. Si tratta di una presunzione “semplice”, definita dall’art. 2729 codice civile, ben diversa dalla presunzione legale che caratterizza il regime tributario di trasparenza tipico delle società di persone.
2.1 La presunzione di distribuzione in capo ai soci
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 3896 del 15 febbraio 2008 sostiene che “nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria ovvero a base familiare, pur non sussistendo una presunzione relativa di distribuzione degli utili tra i soci in base ai rapporti di partecipazione, e dovendo perciò tale distribuzione essere specificamente provata dall’Amministrazione finanziaria, tuttavia, in caso di ricorso dei presupposti di cui all’art. 39 comma 2 del D.P.R. n. 600 del 1973 (risultanze extraliberatorie concordi, gravi, precise e concordanti), l’Amministrazione finanziaria può presumere, in base a presunzioni semplici, la distribuzione dei maggiori utili ai soci.
VII.Grande trasparenza
È un'opzione che possono esercitare solo le società che sono partecipate unicamente da altri soggetti di cui all'art. 73 primo comma lettera a) del Tuir e a condizione che ciascuno di essi detenga una percentuale di diritto di voto compresa tra il 10% e il 50%. Con l'esercizio dell'opzione i redditi o le perdite della società partecipata vengono imputati pro quota alle società partecipanti.
1.2 La nuova S.r.l. centralità del socio e modalità di distribuzione degli utili
In Italia l'istituto giuridico delle Società a responsabilità limitata nasce dal codice del 1942. Fino a quel momento i codici di commercio avevano sempre suddiviso le società commerciali in società collettive, accomandite e/o anonime. I lavori preparatori del codice del 1942 si basavano sulle esperienze dei paesi a capitalismo più avanzato, nei quali spiccavano i modelli societari che, pur inquadrandosi nell'ambito delle società di capitali, consentivano l'utilizzo di forme e strutture più snelle per realtà imprenditoriali di piccole dimensioni.
Si trattava di un tipo di società più simile alle società personali che a quelle di capitali, pur essendo caratterizzato dal fatto che il socio doveva rispondere con tutto il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali.
In questo modo il legislatore aveva delineato un nuovo modello societario caratterizzato da una compagine sociale ristretta, nel quale i soci potevano essere maggiormente coinvolti nell'amministrazione della società, pur riconoscendogli una responsabilità limitata.
La finalità era quella di determinare la previsione di “classi” di azioni.
La stessa disciplina di recesso del socio presuppone compagini sociali ristrette.
Il legislatore, infatti, nel regolare tale istituto ha voluto porre in una posizione di centralità l'aspetto personale del socio e non quello patrimoniale.
Tale fattispecie è disciplinata dall'art. 2473 cod. civ., il quale al primo comma individua otto specifiche cause di recesso che presentano il carattere della inderogabilità.
Considerando che il recesso comporta il rimborso della partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, si desume che l'eventuale ampliamento delle ipotesi di uscita dalla compagine sociale “ristretta” comporterebbe lo scioglimento per incapienza patrimoniale.
La rilevanza della persona del socio si desume anche dall'abbandono del metodo collegiale e dall'assunzione delle decisioni con modalità diverse.
Infine, l'amministrazione, prevede la possibilità di optare per un sistema di tipo personalistico quale è il sistema di amministrazione disgiunta o congiunta che presuppone un legame fiduciario, che generalmente si può instaurare solo tra un numero ristretto di soci.
La distribuzione degli utili nelle società di capitali è disciplinata dall'art. 2478-bis, comma 3, codice civile. Esso stabilisce che in sede di approvazione del bilancio, i soci debbano decidere anche sulla distribuzione degli utili.
Questa previsione normativa si basa sul fatto, che la decisione sulla distribuzione degli utili è strettamente collegata all'approvazione bilancio di riferimento.
La legge ha inteso ribadire da un lato, il principio generale tipico delle società di capitali, per cui il diritto agli utili sorge soltanto in seguito ad una decisione dei soci, atteggiandosi fino a quel momento come una mera aspettativa e dall'altra, che nelle società a responsabilità limitata la decisione sulla distribuzione degli utili rientra nell'ambito delle competenze inderogabili attribuite alla collettività dei soci.
La norma si limita a disciplinare il potere di decidere se distribuire gli utili ed il loro ammontare, ma non interviene sulle modalità con le quali debbano essere distribuiti.
La distribuzione ai soci deve essere proporzionale alla loro percentuale di partecipazione al capitale sociale e deve avvenire rispetto dei limiti legali e statutari.
Per quanto riguarda i limiti legali si richiama quanto disposto per la società per azioni all'art. 2433 cod. civ., secondo il quale è vietato distribuire dividendi se non sono state reintegrate le perdite del capitale sociale.
Relativamente ai limiti statutari è ammissibile che l'atto costitutivo possa incidere sul potere dispositivo dei soci, sia introducendo un limite alla distribuzione degli utili o prevedendone un “obbligo” di distribuzione dell’utile stesso.
La violazione di questi limiti, oltre a comportare una responsabilità civile (art. 2476 cod. civ.) e penale (art. 2627 cod. civ.) a carico degli amministratori, determina l'invalidità della decisione presa dai soci.
1.3 La Grande trasparenza
Innanzitutto, è necessario sottolineare che nel nostro ordinamento non esiste una definizione giuridica di questo tipo di società e neppure una limitazione giuridica del numero dei soci o delle relazioni che tra loro intercorrono.
Tale concetto è frutto di una elaborazione della dottrina, della giurisprudenza e della pratica amministrativa, le quali hanno fatto ricorso a questa figura, in quanto, ancorché non codificata in nessuna disposizione di legge, riesce a definire l’area soggettiva entro la quale ritenere probabile un accordo occulto tra i soci.
Solitamente si fa riferimento al concetto di “ristrettezza” della base societaria per individuare la formazione di un’unica volontà, tipica di un gruppo ridotto di soci o legato da altri vincoli, quali quelli familiari.
Questo vincolo, in presenza di illeciti tributari della società, fa venir meno la netta separazione che esiste tra soci e società di capitali, in base alla quale l’imputazione del reddito avviene solo su delibera.
Dal punto di vista fiscale, la tassazione dei dividendi nelle società di capitali, ha subito una evoluzione normativa, passando al nuovo regime in seguito alla riforma attuata con il D.Lgs. n. 344 del 12 dicembre 2003.
Il sistema precedente prevedeva la tassazione dei redditi prodotti dalle società di capitali, con riferimento ad un determinato periodo d’imposta, secondo il principio della “competenza”.
Tali redditi erano assoggettati all’Irpeg, mentre i soci erano tassati mediante l’imposta personale progressiva, solo nel momento in cui avessero percepiti dei dividendi.
Infatti, a seguito della distribuzione degli stessi da parte della società partecipata, secondo il criterio della trasparenza fiscale si applica l’imponibilità dei dividendi integrabili, in quanto prevista solo in misura parziale e classificata tra i redditi di capitale.
VIII.Piccola trasparenza
Secondo quanto disposto dall'art. 116 del Tuir, i redditi non vengono tassati in capo alla società, ma vengono imputati ai soci, secondo quanto previsto per le società di persone. Il “regime della trasparenza” è applicabile solo se sussistono determinate condizioni e deve essere frutto di una precisa scelta effettuata dalla società stessa, attraverso la compilazione di un modello che deve essere inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
1.2 Nuova S.r.l. centralità del socio e modalità di distribuzione degli utili
Centralità del socio
- Importanza delle società di capitali ristrette base partecipativa
- Legislazione che mira ad evitare l'occultamento dei ricavi
- Il sistema collegiale viene abbandonato per le decisioni importanti
- È possibile optare per un sistema di amministrazione disgiunta o congiunta che prevede un legame fiduciario
Distribuzione degli utili
Disciplinata dall'art. 2478-bis, comma 3, codice civile
Decisione sulla distribuzione degli utili in sede di approvazione del bilancio
La distribuzione deve essere proporzionale alla percentuale di partecipazione al capitale sociale
Limiti legali e statutari
Limiti legali: art. 2433 cod. civ. prevede che gli utili possono essere distribuiti solo dopo il pagamento delle perdite e che non siano state effettuate ripartizioni in conto capitale
Limiti statutari: è possibile incidere sul potere dispositivo dei soci, introducendo un limite alla distribuzione degli utili o prevedendone un "obbligo" di distribuzione
Piccola trasparenza
Definizione
- Concetto elaborato dalla dottrina, giurisprudenza e pratica amministrativa
- Mancanza di una definizione giuridica o di una limitazione legale del numero di soci
Concetto di "ristrettezza"
- Individuazione di un'unica volontà, tipica di un gruppo ristretto di soci o legati da altri vincoli
- In caso di illeciti tributari viene meno la separazione tra soci e società di capitali
Tassazione
- Evoluzione normativa della tassazione dei dividendi nelle società di capitali
- Introduzione del nuovo regime in seguito alla riforma attuata con il D.Lgs. n. 344 del 12 dicembre 2003
- Passaggio da imposta di competenza a prelievo definitivo, con tassazione solo in capo alla società che ha prodotto l'utile
- Tassazione dei dividendi percepiti dai soci in misura parziale, al 49,72%
Regime della trasparenza
- Introdotto con il D.P.R. n. 917/1986, artt. 115 e 116
- Estensione alle società di capitali della tassazione prevista per le società di persone
- Trasferimento della tassazione del reddito prodotto dalla società in capo ai soci
- Scelta opzionale da parte della società stessa
Società di capitali a ristretta base partecipativa
Presunzione di distribuzione dei dividendi
- In caso di accertamento di un maggiore reddito in capo a una società di capitali a ristretta base partecipativa, esso viene imputato "pro quota" ai soci
- Presunzione "semplice", diversa dalla presunzione legale che caratterizza il regime tributario di trasparenza
- La presunzione di distribuzione dei dividendi non viola il divieto di presunzione di secondo grado
- Presupposto di legittimità: ristrettezza della base sociale e vincolo di solidarietà e di reciproco controllo tra i soci
- Il maggiore reddito rilevato in sede di verifica fiscale viene presuntivamente distribuito tra i soci
- Possibilità per il socio di fornire prova contraria, dimostrando di non aver mai avuto poteri di controllo o di effettiva gestione in ambito societario
- Consentita anche la dimostrazione che i rapporti con chi gestiva realmente la società non erano tali da rendere possibile la conoscenza dell'esistenza di somme mai documentate nella contabilità societaria
