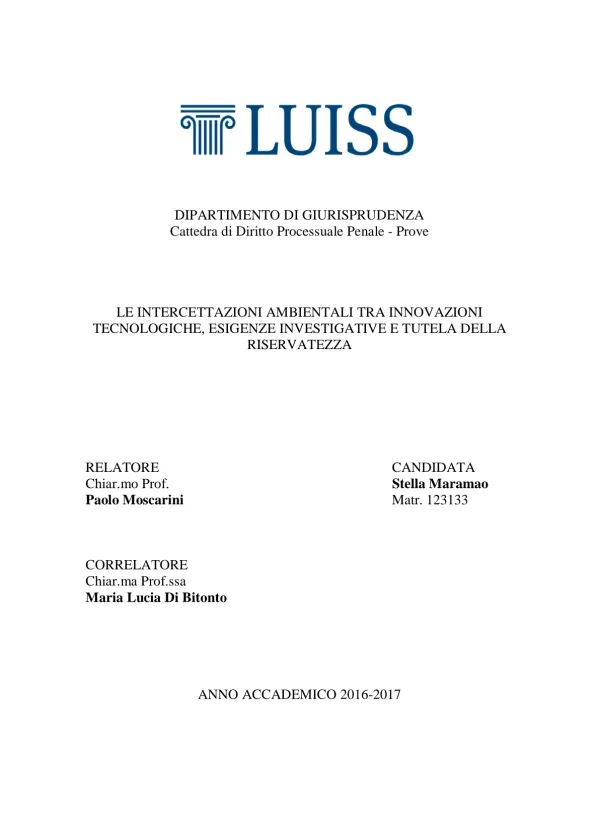
Intercettazioni Ambientali: Tutela e Innovazione
Informazioni sul documento
| Autore | Stella Maramao |
| instructor | Paolo Moscarini |
| Scuola | Dipartimento di Giurisprudenza |
| Specialità | Diritto Processuale Penale |
| Tipo di documento | Tesi di Laurea |
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 1.01 MB |
Riassunto
I.L evoluzione tecnologica e le intercettazioni nel codice di procedura penale italiano
Il documento analizza la giurisprudenza italiana in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali, evidenziando il conflitto tra le esigenze di giustizia e il diritto alla riservatezza, garantito dalla Costituzione. Si discute l'adeguamento delle norme del Codice di procedura penale (c.p.p.), in particolare gli artt. 266, 267, 268, 270 e 271, all'evoluzione tecnologica delle tecniche di captazione clandestina, inclusi microfoni, microspie e videoregistrazioni. L'analisi si concentra sulla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) riguardo alla libertà di domicilio e all'interpretazione dell'art. 14 Cost., evidenziando la necessità di un bilanciamento tra prove atipiche e garanzie individuali. Viene inoltre affrontata la questione della pubblicazione delle intercettazioni e le relative implicazioni per il diritto di cronaca e la tutela dei soggetti coinvolti, compresi i terzi estranei al procedimento. L'importanza del principio di legalità e della proporzionalità delle misure di sorveglianza è sottolineata alla luce della giurisprudenza della CEDU. Infine, si evidenzia la necessità di una riforma legislativa per chiarire le lacune normative e garantire una maggiore tutela del diritto alla privacy.
1. L evoluzione tecnologica e l inadeguatezza del codice di rito
Il documento inizia citando la dissenting opinion del giudice Brandeis nel caso Olmstead vs. United States (1928), che sottolineava la necessità di un'evoluzione delle categorie giuridiche di pari passo con l'evoluzione tecnologica. Si evidenzia la mancanza, nel codice di rito italiano, di previsioni specifiche sulle modalità di effettuazione delle intercettazioni ambientali, con il conseguente tentativo di adattare la normativa sulle intercettazioni telefoniche a situazioni diverse, come i dialoghi tra presenti. Questa pratica, considerata illegittima in quanto non si possono accostare fattispecie così differenti, evidenzia il divario tra l'evoluzione tecnologica e il quadro normativo. La mancanza di una disciplina specifica per le intercettazioni ambientali crea incertezze interpretative e possibili violazioni del diritto alla riservatezza. Il testo anticipa inoltre la discussione sulla disparità di trattamento tra cittadini comuni e soggetti costituzionalmente protetti riguardo all'utilizzo delle intercettazioni, sottolineando l'assoluta intangibilità della sfera comunicativa del Capo dello Stato, come stabilito da una sentenza della Corte Costituzionale.
2. Registrazione fonografica di colloqui tra presenti e il concetto di intercettazione
Le Sezioni Unite hanno stabilito che la registrazione fonografica di un colloquio tra presenti, o ascoltato a distanza tramite un dispositivo su un partecipante al dialogo, non costituisce intercettazione, nemmeno se clandestina. Si tratta di memorizzazione di un fatto storico, e l'autore può utilizzarla come prova (art. 234 c.p.p.). La formazione del documento non rientra nel concetto di intercettazione, e il suo utilizzo processuale non intacca il diritto alla segretezza delle comunicazioni, ma solo l'interesse alla riservatezza, che, pur meritevole di tutela, non attiva la riserva di giurisdizione dell'art. 15 Cost. Un'opinione minoritaria, tuttavia, definisce questa prova come "prova nana", con un valore probatorio limitato alla probabilità. Il testo prosegue confrontando l'applicazione dell'art. 192 co. 2 con l'art. 267 c.p.p. riguardo ai decreti autorizzativi delle intercettazioni, evidenziando la diversa severità richiesta nella valutazione del materiale probatorio a seconda che si tratti di una sentenza o di un atto investigativo.
3. Limiti e necessità delle intercettazioni l extrema ratio e la motivazione
Il documento sottolinea che l'ipotesi dell'art. 416 c.p. (associazione a delinquere) non giustifica da sola la proliferazione di intercettazioni a catena. È necessaria una specifica motivazione per ogni soggetto intercettato, indicando l'indispensabilità delle intercettazioni per il proseguimento delle indagini. L'intercettazione è considerata un'extrema ratio, e la sua necessità deve essere motivata per ogni soggetto coinvolto. Si evidenzia la difficoltà nel dimostrare gli elementi che giustificano le intercettazioni, e il rischio di una proliferazione incontrollata se non si seguono procedure rigorose e motivate. Segue una breve discussione sulla controversa qualificazione giuridica dei bagni pubblici e la discrepanza tra garanzia costituzionale e tutela penale, con riferimento alla definizione di “privata dimora” e all'esclusione del carcere da tale definizione.
4. Modalità di esecuzione delle intercettazioni telefoniche e ambientali
Il documento descrive le modalità di esecuzione delle intercettazioni telefoniche, che prevedono la comunicazione del numero all'ente gestore, e quelle ambientali, più complesse e con modalità diverse (microspie, microfoni, registratori). Le intercettazioni domiciliari, spesso eseguite clandestinamente, sono considerate illegittime da alcuni, in quanto i microfoni spia non rientrerebbero tra gli "impianti di pubblico servizio o in dotazione della polizia giudiziaria" (art. 268 co. 3 c.p.p.). Sentenze costituzionali hanno criticato la giurisprudenza che aveva ritenuto legittima la collocazione di microspie in abitazioni private, evidenziando la valenza essenzialmente negativa della libertà di domicilio e la necessità di una duplice riserva (di legge e di giurisdizione) per interferire con questo diritto. Il monopolio del pubblico ministero nella richiesta di intercettazioni e la conseguente limitazione del diritto di difesa vengono evidenziati come potenziali violazioni del principio di parità delle parti e del diritto di difesa (art. 24 co. 2 Cost.).
5. Procedimento per le intercettazioni richiesta autorizzazione e proroga
Il procedimento per le intercettazioni inizia con la richiesta del pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari, che deve decidere sull'autorizzazione. La richiesta deve contenere dettagli sulle ipotesi di reato (artt. 266 e 266-bis c.p.p.), gravi indizi di reato e l'assoluta indispensabilità delle intercettazioni. Se l'intercettazione riguarda luoghi di privata dimora (art. 614 c.p.p.), il luogo deve essere specificato. Il rigetto della richiesta è un decreto non motivato e non impugnabile (art. 267 c.p.p.), ma il pubblico ministero può rinnovare l'istanza. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 267 c.p.p. per la mancanza di impugnazione del decreto di rigetto è stata dichiarata infondata. L'avvicendamento di diversi giudici in una stessa operazione di intercettazione non costituisce violazione del principio del giudice naturale (art. 25 co. 1 Cost.). L'analisi delle intercettazioni urgenti sottolinea la necessità di una convalida tempestiva, pena l'inutilizzabilità dei risultati (art. 267 co. 2 e art. 271 co. 1 c.p.p.). Anche la proroga delle intercettazioni è soggetta a decreto motivato del giudice, che deve valutare la necessità di comprimere ulteriormente la sfera di riservatezza (art. 267 co. 1).
II.La qualificazione giuridica delle intercettazioni luoghi e modalità
Il testo approfondisce la distinzione tra intercettazioni in luoghi pubblici e privati, analizzando il concetto di privata dimora (art. 614 c.p.) e la sua applicazione in contesti come il carcere. Si discute la liceità delle intercettazioni effettuate mediante microspie e la giurisprudenza che ne ha definito i limiti, con particolare attenzione alle sentenze della Corte Costituzionale in materia di videoregistrazioni in privata dimora. Si analizzano le diverse modalità di esecuzione delle intercettazioni ambientali, distinguendo tra captazione di comportamenti comunicativi e mere condotte, e si esaminano le implicazioni per l'utilizzo delle prove nel processo. Il ruolo del pubblico ministero nella richiesta di autorizzazione alle intercettazioni e le limitazioni per la difesa sono analizzate nel contesto dell'art. 24 Cost. (diritto di difesa) e del principio di parità delle parti.
1. Luoghi di intercettazione privata dimora e luoghi pubblici
Il documento analizza la distinzione tra intercettazioni in luoghi pubblici e privati, ponendo particolare attenzione al concetto di 'privata dimora' come definito dall'articolo 614 del codice penale. Si evidenzia come la giurisprudenza richieda una stabilità del rapporto tra il luogo e la persona per qualificare uno spazio come privata dimora, escludendo, ad esempio, i bagni pubblici. L'interpretazione del concetto di privata dimora è ulteriormente approfondita riguardo al caso specifico del carcere: la Cassazione ha escluso che la sala colloqui e le celle possano essere considerate luoghi di privata dimora, consentendo quindi le intercettazioni anche senza un fondato motivo di ritenere che all'interno si stia svolgendo attività criminosa (salva la possibilità di ricorrere all'art. 39 del Regolamento sull'ordinamento penitenziario). Questa distinzione tra luoghi pubblici e privati è fondamentale per determinare la legittimità delle intercettazioni e la conseguente applicabilità delle norme del codice di procedura penale in materia di intercettazioni ambientali. La protezione offerta dal concetto di 'privata dimora' è massima, mentre quella in luoghi pubblici è più blanda.
2. Modalità di intercettazione e loro legittimità microspie e videoregistrazioni
La sezione approfondisce le modalità di esecuzione delle intercettazioni ambientali, distinguendo tra l'utilizzo di microspie, potenti microfoni e piccoli apparecchi di registrazione. Le intercettazioni domiciliari, spesso effettuate introducendosi clandestinamente nell'abitazione altrui, vengono discusse alla luce della loro potenziale illegittimità. Si discute infatti se i microfoni spia possano essere inclusi tra gli "impianti di pubblico servizio o in dotazione della polizia giudiziaria" (art. 268 co. 3 c.p.p.), sollevando dubbi sulla loro legittimità. Il testo riporta come sentenze costituzionali abbiano criticato la precedente giurisprudenza che aveva ritenuto legittima la collocazione di microspie in luoghi di privata dimora, evidenziando come la Corte Costituzionale abbia affermato che la libertà di domicilio ha una valenza essenzialmente negativa, e che il modo in cui si acquisisce la prova non può essere irrilevante quando tale acquisizione interferisce con un diritto inviolabile, soggetto a duplice riserva di legge e di giurisdizione. L'analisi si concentra quindi sull'importanza del bilanciamento tra esigenze investigative e tutela della libertà di domicilio.
3. Il monopolio del pubblico ministero e le limitazioni per la difesa
Il documento evidenzia il monopolio del pubblico ministero nella richiesta di intercettazioni, impedendo al difensore dell'indagato e della persona offesa di avanzare analoghe istanze (art. 158). La difesa può solo richiedere al pubblico ministero informazioni ex art. 367 c.p.p., senza alcuna obbligazione di risposta da parte dell'accusa. Questa situazione è considerata una potenziale lesione del principio di parità delle parti e del diritto di difesa (art. 24 co. 2 Cost.). Per migliorare la situazione, si propone una riforma che attribuisca al giudice per le indagini preliminari la facoltà di soddisfare i bisogni di prova della difesa. Nel frattempo, si potrebbe estendere la procedura prevista dall'art. 1 c.p.p. La sezione prosegue descrivendo il procedimento per le intercettazioni: la richiesta del pubblico ministero, l'autorizzazione (o il rigetto) del giudice per le indagini preliminari, e la necessità di una motivazione dettagliata, con specifica indicazione del luogo in caso di intercettazioni in luoghi di privata dimora (art. 614 c.p.p.). Il rigetto della domanda, tramite un decreto non motivato e non impugnabile, è discusso nel contesto della sua compatibilità con gli artt. 101 co. 2 e 112 Cost.
4. Intercettazioni private e responsabilità penale
La normativa vigente non consente ai privati di effettuare intercettazioni ambientali. Se un privato effettua una intercettazione, non si applicano gli artt. 266-271 c.p.p., rendendo la captazione illegittima. Il privato potrebbe incorrere nel reato di cognizione illecita di comunicazione (art. 617 c.p.) o di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.) se l'intercettazione invade il domicilio altrui. Tuttavia, secondo Cordero, la condotta illecita non implica necessariamente l'inammissibilità della prova, suggerendo che le intercettazioni private potrebbero essere utilizzabili se effettuate per uno dei reati previsti dagli artt. 266 e 266-bis. Il testo poi descrive le eccezioni previste dall'art. 226 disp. att. c.p.p., che consente controlli preventivi su conversazioni, su iniziativa del Ministro dell'Interno, per la prevenzione di specifici reati. I risultati di queste intercettazioni non sono utilizzabili nel processo penale, eccetto che per fini investigativi. La giurisprudenza, basandosi sul principio di non dispersione delle prove, ammette l'utilizzo di elementi probatori da intercettazioni legittime anche in procedimenti diversi da quello per cui erano state autorizzate, se il reato è inerente alla criminalità organizzata.
III.L utilizzo delle intercettazioni come prova e le garanzie procedurali
Questo capitolo si focalizza sulle garanzie procedurali relative all'utilizzo delle intercettazioni come prova nel processo penale. Si esamina l'obbligo di registrazione e verbalizzazione delle conversazioni (art. 271 c.p.p.), le procedure di stralcio e distruzione del materiale irrilevante, e le sanzioni per la violazione di tali obblighi, inclusa l'inutilizzabilità delle prove. Viene discussa la consultabilità dei registri delle intercettazioni (art. 267 c.p.p.) e il diritto di accesso della difesa al materiale probatorio (art. 268 c.p.p.), anche in relazione al principio del contraddittorio. Si analizza l'inutilizzabilità delle intercettazioni in caso di mancata convalida o di vizi procedurali. Si approfondisce il tema della notitia criminis ricavata dalle intercettazioni e la sua utilizzabilità nel processo, anche in caso di mutamento del titolo di reato. L'analisi considera anche l'utilizzo di strumenti tecnologici sempre più sofisticati per le intercettazioni e le sfide che ne derivano per la legislazione.
1. Obbligo di registrazione e verbalizzazione inutilizzabilità delle prove
Il documento analizza l'obbligo di registrazione e verbalizzazione previsto per tutte le forme di intercettazione (art. 271 co. 1 c.p.p.), con sanzione di inutilizzabilità in caso di mancato rispetto. Per i colloqui a voce, la registrazione deve avvenire su nastro o supporto digitale; per i flussi informatici, nell'archivio del sistema di intercettazione. Sono previste procedure di stralcio e distruzione dei colloqui di soggetti estranei alle indagini per tutelare la privacy. Si discute anche la proposta di una registrazione selettiva, limitata ai soli soggetti indicati nel decreto, ma questa soluzione appare difficilmente realizzabile. L'inutilizzabilità delle intercettazioni, sancita dall'art. 270 c.p.p., sembra riferirsi all'ambito probatorio, pur senza esclusione esplicita. Il testo evidenzia l'obbligo per la polizia giudiziaria di riferire senza ritardo ogni reato di cui abbiano avuto notizia nell'esercizio delle loro funzioni, sottolineando che la notizia di reato non richiede fondamento probatorio e la sua iscrizione non equivale all'utilizzo di prove. La Corte Costituzionale ha chiarito che l'art. 270 c.p.p. non ostacola l'iscrizione di notizie di reato ricavate da intercettazioni, ma ne vieta solo l'utilizzabilità come prova in procedimenti diversi.
2. Registri delle intercettazioni e loro funzione garantistica
Il nuovo codice ha eliminato l'obbligo di iscrizione delle intercettazioni in un registro pubblico (art. 266-ter co. 4 c.p.p. abrogato). L'art. 267 c.p.p. impone invece la tenuta di un registro riservato presso l'ufficio del pubblico ministero, con annotazione cronologica dei decreti e delle operazioni. Tuttavia, la limitata accessibilità del registro (solo agli addetti all'ufficio) ne riduce la funzione garantistica, rendendo difficile l'applicazione della sanzione di inutilizzabilità per le intercettazioni non iscritte (art. 271 c.p.p.). La Corte Costituzionale ha stabilito, ai sensi dell'art. 268 co. 4 c.p.p., l'obbligo per il pubblico ministero, su richiesta di parte, di rendere conoscibile il mezzo di ricerca della prova, anche prima del deposito. Questo garantisce il diritto di accesso della difesa alle registrazioni, anche in mancanza di deposito, per estrarne copia e verificarne la correttezza e l'efficacia probatoria, consentendo di esercitare i rimedi processuali contro eventuali provvedimenti cautelari. La sezione sottolinea l'importanza di questo accesso per evitare il rischio di condanna basata su fonti spurie.
3. Utilizzabilità delle intercettazioni come prova e principio del contraddittorio
Il testo discute l'utilizzabilità delle intercettazioni come prova, focalizzandosi sull'art. 270 c.p.p. e la sua apparente estensione all'ambito probatorio. Si evidenzia l'obbligo di riferire senza ritardo ogni reato appreso durante le intercettazioni, indipendentemente dal fondamento probatorio, e che l'iscrizione della notizia di reato non equivale all'utilizzo di prove. La Corte Costituzionale ha ritenuto che l'art. 270 c.p.p. non impedisca l'iscrizione di notitia criminis ricavate dalle intercettazioni, vietando solo l'utilizzabilità delle prove in altri procedimenti. Viene analizzata la questione della prova derivante da dichiarazioni rese durante le intercettazioni inconsapevoli, considerate fonte di prova senza necessità di ulteriori riscontri, a differenza delle dichiarazioni rese in sede giudiziaria. Si evidenzia il ruolo del giudice nel vaglio delle frasi intercettate per assicurarne la valenza probatoria, anche in presenza di terzi estranei, e la necessità di elementi di conferma dell'attendibilità in caso di conversazioni poco chiare o ambigue. La flessibilità del sistema probatorio e l'introduzione di nuove tecnologie di captazione sono menzionate come fattori che richiedono un costante aggiornamento del quadro normativo.
4. Il problema del mutamento del titolo di reato e l inutilizzabilità delle prove
Il documento analizza una problematica legata all'utilizzabilità delle intercettazioni in caso di mutamento del titolo di reato durante il procedimento. Si evidenzia che il semplice cambio di imputazione non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni. L’inutilizzabilità deriva piuttosto dal mancato rispetto dei requisiti previsti per le captazioni, ovvero dalla mancanza di una corretta motivazione riguardo agli indizi e all'indispensabilità dell'intercettazione per quel determinato reato. La giurisprudenza, in linea con questa interpretazione, ha ritenuto utilizzabili i risultati delle captazioni anche se il reato scoperto non coincide con quello originariamente addebitato. Si confrontano le dichiarazioni rese davanti all'autorità giudiziaria, che necessitano di riscontri, con le dichiarazioni intercettate inconsapevolmente, che costituiscono di per sé fonte di prova. L’analisi evidenzia il ruolo del giudice nel vaglio delle frasi intercettate per assicurare la valenza probatoria, anche in presenza di terzi estranei al procedimento, e il bilanciamento tra esigenze probatorie e tutela della privacy.
IV.Intercettazioni e categorie protette immunità e limiti
La sezione tratta le limitazioni all'utilizzo delle intercettazioni nei confronti di soggetti costituzionalmente protetti, come parlamentari, Presidente del Consiglio, Presidente della Repubblica e giudici costituzionali. Si esamina l'immunità prevista per il Capo dello Stato, facendo riferimento a specifiche sentenze della Corte Costituzionale. Si analizza la normativa che regola le intercettazioni relative alla ricerca di latitanti (art. 295 c.p.p.) e il dibattito sulla loro utilizzabilità come prova. Si considera l'impatto delle nuove tecnologie di sorveglianza sulle garanzie costituzionali e si evidenzia la necessità di un bilanciamento tra esigenze investigative e diritto alla riservatezza.
V.Proposte di riforma e conclusioni
Il documento conclude con la necessità di una riforma della legislazione sulle intercettazioni, al fine di ridurre i casi di ammissibilità, aumentare le garanzie a tutela dei difensori, definire una disciplina chiara per le videoriprese, garantire l'utilizzabilità delle intercettazioni per la ricerca dei latitanti, e ridurre al minimo la divulgazione di informazioni irrilevanti. Si sottolinea l'importanza del rispetto del contraddittorio e della tutela della riservatezza, anche per i terzi estranei al processo. Le preoccupazioni del Garante per la Privacy riguardo alla trasmissione di intercettazioni irrilevanti nel processo sono menzionate come ulteriore argomento a supporto della necessità di una riforma legislativa che migliori la protezione dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione tecnologica. Il documento evidenzia come l’attuale giurisprudenza, pur con orientamenti talvolta discordanti, cerchi di trovare un equilibrio tra le esigenze investigative e il rispetto delle garanzie individuali, con particolare riferimento alla libertà di domicilio e al diritto alla riservatezza.
1. Necessità di una riforma per ridurre l ammissibilità delle intercettazioni
Il documento conclude sottolineando la necessità di una riforma che limiti i casi di ammissibilità delle intercettazioni, inasprendo le sanzioni per la loro illegittima pubblicazione. Si evidenzia la necessità di interventi per aumentare le garanzie a tutela dei difensori, per dettare una disciplina specifica per le videoriprese e per garantire il valore probatorio delle intercettazioni per la ricerca del latitante. Per tutelare la riservatezza, si suggerisce di ridurre il numero di soggetti a conoscenza del contenuto delle intercettazioni e dei verbali, di segretare gli atti estranei all'attività investigativa e di disporre lo stralcio e la distruzione del materiale irrilevante prima del deposito o della diffusione. L'obiettivo è quello di ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy, soprattutto per i soggetti estranei al processo. L'appello del Garante per la privacy, Antonello Soro, al premier Renzi nel 2015, che auspicava il rispetto delle esigenze di riservatezza dei cittadini, è citato a sostegno della necessità di una riforma che tenga conto sia delle esigenze investigative che della protezione della privacy.
2. Tutela della riservatezza e contrasto alla divulgazione di informazioni irrilevanti
Il documento evidenzia il rischio di compressione del diritto alla riservatezza a causa della indiscriminata divulgazione di notizie relative agli atti di indagine, la cui veridicità deve ancora essere accertata. Si sottolinea l'importanza del diritto all'informazione in uno Stato democratico, ma si critica la divulgazione da parte dei mass media di dettagli irrilevanti e strettamente privati, che ledono non solo gli indagati ma anche soggetti terzi coinvolti nel processo in modo fortuito. Si propone una normativa ad hoc per evitare la pubblicazione di fatti privati privi di interesse pubblico, lesivi del diritto alla riservatezza. Si critica la prassi, ammessa dal Consiglio Superiore della Magistratura, di effettuare lo stralcio delle conversazioni irrilevanti nell'udienza dibattimentale invece che durante le indagini preliminari (art. 268 co. 6 e 7 c.p.p.), una prassi ritenuta lesiva della riservatezza. Si suggerisce che lo stralcio venga eseguito nei tempi e modi previsti dalla legge per eliminare anticipatamente le intercettazioni irrilevanti o illegittime, evitando la divulgazione del loro contenuto e proponendo una sanzione di inutilizzabilità per il mancato rispetto dei termini.
3. Aggiornamento del regime giuridico delle intercettazioni proposte concrete
Il documento propone un aggiornamento del regime giuridico delle intercettazioni, suggerendo l'inserimento nel catalogo delle prove di tipologie attualmente non previste, una migliore regolamentazione delle modalità di esecuzione delle operazioni da parte del pubblico ministero e dei suoi ausiliari e una scelta accurata degli operatori tecnici che forniscono gli apparati per le intercettazioni ambientali. Si sottolinea il carattere lacunoso di alcune disposizioni, che genera incertezze e situazioni potenzialmente lesive del diritto alla privacy. Si evidenzia la necessità di una disciplina più precisa per le videoriprese, il valore probatorio delle intercettazioni per la ricerca del latitante e la segretazione degli atti estranei all'attività investigativa. La necessità di una riforma è ulteriormente sottolineata dalla descrizione di due proposte di legge presentate in passato (una nel 2013, l’altra tramite emendamento al decreto n. 7 del 2015), che, pur non approvate, evidenziano la consapevolezza del problema e le diverse possibili soluzioni legislative. L’analisi delle intercettazioni “a cornetta sollevata”, considerate utilizzabili in quanto la segretezza di una conversazione dipende anche dall’imprudenza degli interlocutori e non solo dall’azione della polizia, chiude l'analisi delle proposte di riforma.
