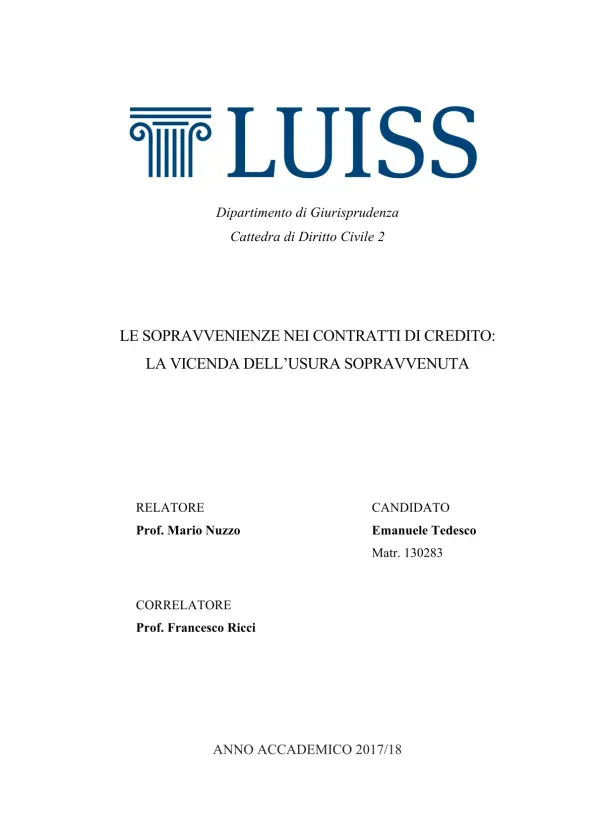
Usura Sopravvenuta: Rimedi
Informazioni sul documento
| Autore | Emanuele Tedesco |
| instructor | Prof. Mario Nuzzo |
| Scuola | Dipartimento di Giurisprudenza |
| Specialità | Diritto Civile |
| Tipo di documento | Tesi di Laurea |
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 1.22 MB |
Riassunto
I.Usura Sopravvenuta Definizione e Parametri Rilevanti
Il documento analizza la complessa questione dell'usura sopravvenuta, definita come il superamento del tasso soglia (calcolato a partire dal TEGM e soggetto a variazioni periodiche) in un contratto di credito inizialmente lecito. Si evidenzia la distinzione tra interessi corrispettivi e interessi moratori, cruciali per determinare l'applicazione del giudizio di usura. L'analisi si concentra sui contratti di mutuo e sull'importanza del TEG nel determinare la liceità degli interessi. L'articolo 1815 del Codice Civile e la sua (ormai) inapplicabilità nel caso di usura sopravvenuta vengono discussi nel dettaglio.
1. Definizione di Usura Sopravvenuta e il Ruolo del Tasso Soglia
La sezione introduce il concetto di usura sopravvenuta, un'ipotesi in cui un contratto di credito, inizialmente lecito, diventa usurario a causa di una successiva riduzione del tasso-soglia. Questo tasso-soglia è calcolato a partire dal TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio), determinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è soggetto a variazioni periodiche in base all'andamento dei tassi di mercato. La modifica al ribasso del TEGM e, di conseguenza, del tasso-soglia, può trasformare un TEG (Tasso Effettivo Globale) originariamente lecito in un tasso usurario. È importante notare che queste variazioni, a differenza delle sopravvenienze normative, sono considerate sopravvenienze di mercato, derivando da modifiche di politica monetaria. Si sottolinea l'importanza di distinguere tra questo tipo di usura e altre fattispecie, ad esempio, quando la banca agisce in giudizio per inadempienza del cliente e applica interessi maggiorati ai sensi dell'articolo 1284 del Codice Civile. In questi casi, il superamento della soglia di usura è una conseguenza diretta dell'applicazione della legge, non configurando un'usura sopravvenuta.
2. Il Giudizio di Usurarietà e la Distinzione tra Interessi Corrispettivi e Moratori
In caso di controversia sulla natura usuraria degli interessi, il giudizio di usurarietà deve essere condotto considerando se il cliente sia o meno inadempiente. Questa distinzione è fondamentale per evitare paragoni disomogenei tra il TEG (che include gli interessi moratori) e il TEGM (che li esclude in situazioni non patologiche). L'analisi sottolinea l'importanza di mantenere giuridicamente distinti gli interessi corrispettivi (nella fase fisiologica del rapporto) e gli interessi moratori (nella fase patologica). La distinzione è fondamentale per una corretta valutazione dell'applicazione delle norme sull'usura. Il testo poi introduce una riflessione sulla natura della liceità degli interessi pattuiti in caso di usura sopravvenuta, evidenziando come, a differenza dell'usura originaria (penalmente rilevante), non si tratti di sanzionare una previsione illegittima, bensì di riportare il contratto entro i confini della legalità, nel rispetto della volontà delle parti. Viene citata la sentenza della Cassazione n. 14899/2000, che secondo la relazione governativa, crea incertezza giuridica sulla legittimità delle pattuizioni di interessi nei mutui a tasso fisso, aprendo alla possibilità di un'«usurarietà sopravvenuta» anche per contratti stipulati prima della legge n. 108 del 1996.
3. Nullità Sopravvenuta e Meccanismi di Integrazione Cogente
La sezione approfondisce la questione della nullità sopravvenuta nel contesto dell'usura sopravvenuta. Si discute la tesi della nullità sopravvenuta, mostrando come questa sia infondata sia dal punto di vista strutturale che sistematico. Dal punto di vista strutturale, il meccanismo di integrazione cogente (articoli 1419, secondo comma, e 1339 del Codice Civile) presuppone una norma imperativa che si sostituisca alla volontà negoziale difforme. Tuttavia, nel caso di sforamento del tasso soglia, tale norma non si trova né nell'articolo 1815, secondo comma, del Codice Civile (per la sua inapplicabilità) né nelle determinazioni ministeriali del TEGM (perché rappresentano solo un frammento della fattispecie rilevante). Sistematicamente, la nullità sanziona vizi genetici del contratto; postulare una nullità sopravvenuta significherebbe estendere la nullità oltre il momento genetico del contratto, incidendo non sul contratto-atto, ma sul contratto-rapporto e sui suoi effetti. Si conclude che, pur essendo l'originaria stipula valida, il superamento del tasso soglia comporta la cessazione ex nunc degli effetti della clausola sugli interessi, escludendo il diritto agli interessi per la banca-mutuante. Il ricorso all'articolo 1815, secondo comma, Codice Civile, è ritenuto eccessivo, in quanto non si tratta di sanzionare un illecito, ma di riportare il contratto alla legalità rispettando la volontà delle parti.
II.Sopravvenienze e Rilevanza Giuridica
Il testo affronta il tema delle sopravvenienze nel contratto, focalizzandosi sulla loro rilevanza giuridica. Non ogni evento sopravvenuto è giuridicamente rilevante; l'articolo 1467 del Codice Civile, pur riferendosi all'ipotesi specifica di eccessiva onerosità sopravvenuta, definisce i presupposti generali per la rilevanza delle sopravvenienze, tenendo conto dell'alea normale del contratto. L'analisi distingue tra contratto-atto e contratto-rapporto, evidenziando come le sopravvenienze incidano sul secondo. Si discute anche del concetto di alea normale del contratto e di come questo influenzi la valutazione dell'eccessiva onerosità.
1. Rilevanza Giuridica delle Sopravvenienze Contrattuali
La sezione si concentra sulla rilevanza giuridica delle sopravvenienze contrattuali, chiarendo che non ogni evento sopravvenuto al contratto ha rilevanza giuridica. Affinché una sopravvenienza abbia rilevanza, non basta che incida sul rapporto contrattuale, ma deve alterarne in modo sostanziale l'equilibrio. L'articolo 1467 del codice civile, pur focalizzandosi sull'ipotesi specifica dell'eccessiva onerosità sopravvenuta, fissa i presupposti generali di rilevanza delle sopravvenienze. L'alterazione dell'equilibrio contrattuale deve determinare un'eccessiva onerosità di una delle prestazioni e non deve rientrare nell'alea normale del contratto. Questa valutazione dell'eccessiva onerosità non può essere astratta, ma deve considerare la fattispecie concreta del contratto. La ratio della rilevanza delle sopravvenienze è quella di mantenere l'onere economico assunto dalle parti entro i limiti di quanto originariamente accettato, tenendo conto del rischio rientrante nell'alea normale. La durata del contratto incide inevitabilmente sull'aumento del rischio assunto dalle parti, influenzando la valutazione dell'eccessiva onerosità. Nei contratti di durata, il tempo rilevante per la valutazione è quello in cui la parte svantaggiata lamenta il sopravvenuto aggravio.
2. Il Concetto di Alea Normale e la Distinzione Contratto Atto Contratto Rapporto
Il concetto di 'alea normale' del contratto indica il criterio legale di distribuzione del rischio contrattuale, rappresentando la tipologia e la misura del rischio implicitamente assunto da una parte. L'alea normale costituisce il limite applicativo della risoluzione di cui all'articolo 1467 del codice civile e rappresenta l'elemento di collegamento dell'operazione contrattuale con il contesto di mercato. Questa considerazione sull'alea normale è rilevante anche al di fuori dell'ambito specifico di applicazione dell'articolo 1467. Il problema delle sopravvenienze si pone in merito al contratto-rapporto e non al contratto-atto. L'ordinamento non distingue tra contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita; ciò che conta è la sfasatura temporale tra conclusione ed esecuzione. È riduttivo limitare l'ambito di applicazione di rimedi atipichi solo a contratti di durata, anche se statisticamente sono questi i contratti più esposti al rischio di sopravvenienze e per i quali i rimedi codificati appaiono spesso insoddisfacenti. In sostanza, ogni contratto può essere colpito da sopravvenienze, indipendentemente dalla sua durata.
3. Effetti Restitutori e Retroattività della Risoluzione
L'effetto ripristinatorio in caso di risoluzione del contratto per sopravvenienza è un meccanismo a due tempi: prima lo scioglimento del contratto rende sine titulo le attribuzioni patrimoniali, poi il ripristino vero e proprio deriva dai principi generali sulle restituzioni. Per le obbligazioni di facere già adempiute si applica la disciplina dell'arricchimento senza giusta causa (articolo 2041 cod. civ.), mentre per quelle di dare si applicano le norme sulla condictio indebiti. Gli effetti restitutori non sono automatici, ma oggetto di autonoma domanda. Non tutti i contratti rientrano nelle categorie a esecuzione continuata o periodica. Nei contratti unilateralmente di durata, la risoluzione per alterazione del nesso sinallagmatico è retroattiva fin dalla conclusione del contratto, generando obblighi restitutori per il contraente che ha già ricevuto la prestazione. Questo vale per i contratti di mutuo o di credito, dove la risoluzione per eccessiva onerosità ha sempre portata retroattiva. Il rimedio risolutorio è inadeguato per contratti di lunga durata, definiti 'di relazione', che instaurano rapporti prolungati nel tempo e finalizzati a operazioni complesse e difficilmente riconvertibili. Esempi sono i contratti di appalto per opere infrastrutturali complesse.
III.Rimedi in Caso di Usura Sopravvenuta
Il documento esplora i rimedi disponibili in caso di usura sopravvenuta. Si confrontano i rimedi ablativi (come la risoluzione del contratto) con quelli manutentivi (come la rinegoziazione del contratto). Si sottolinea l'inadeguatezza della risoluzione, specie nei contratti di lunga durata come i mutui, a causa delle conseguenze economiche per il mutuatario. L’importanza della buona fede e dell’abuso del diritto nell’applicazione dei rimedi viene evidenziata, così come il ruolo del giudice nella riduzione ad equità del contratto. La clausola rebus sic stantibus viene richiamata nel contesto della possibilità di riequilibrio contrattuale.
1. Rimedi Ablativi vs. Manutentivi in Caso di Usura Sopravvenuta
La sezione analizza i possibili rimedi in caso di usura sopravvenuta, distinguendo tra rimedi ablativi e manutentivi del contratto. I rimedi ablativi mirano allo scioglimento del contratto, mentre quelli manutentivi cercano di mantenere in vita il rapporto, modificandone le condizioni. Si evidenzia come la risoluzione del contratto, un rimedio ablativo, sia spesso inadeguata, soprattutto nei contratti di durata come i mutui, a causa delle sue conseguenze negative per il mutuatario, che potrebbe essere costretto a restituire l'intero finanziamento. Questa inadeguatezza è particolarmente evidente nei contratti di relazione, caratterizzati da rapporti di lunga durata e finalizzati a operazioni complesse. L'articolo evidenzia come, in questi casi, la risoluzione sia inefficiente anche da un punto di vista economico, in quanto non consente la traslazione del rischio sul soggetto maggiormente in grado di assorbirlo o distribuirlo. Al contrario, si suggerisce che sia più efficiente mantenere in vita il rapporto contrattuale, apportando le necessarie modifiche per ricondurlo ad equità. La sezione sottolinea come la scelta del rimedio debba considerare non solo l'efficienza, ma anche l'equità, particolarmente nei contratti di mutuo, spesso connessi all'acquisto della prima casa.
2. La Rinegoziazione come Rimedio Manutentivo e il Ruolo della Buona Fede
La sezione si concentra sulla rinegoziazione come rimedio manutentivo per l'usura sopravvenuta, evidenziando le condizioni più favorevoli rispetto al passato, grazie alla disciplina consumeristica e agli obblighi informativi a carico delle banche. Questi obblighi, che includono elementi valutativi, costituiscono una vera e propria attività di consulenza per il cliente. La rinegoziazione può essere sia volontaria che obbligatoria. Si discute poi dell'opportunità di una rinegoziazione rispetto alla risoluzione del contratto, soprattutto nei casi di mutui per la prima casa, dove la risoluzione potrebbe pregiudicare gravemente il cliente. La sezione considera anche il ruolo della buona fede, evidenziando il suo ruolo correttivo ex post e la sua funzione di limite interno ad ogni situazione giuridica soggettiva. La buona fede, pur non essendo uno strumento autonomo di giudizio equitativo, contribuisce a riequilibrare il contratto secondo equità. L'applicazione della clausola generale di buona fede non è un'applicazione diretta della legge, ma piuttosto diritto giurisprudenziale, basato su regole del costume. Il documento accenna all'orientamento giurisprudenziale che vede nell'abuso del diritto, sanzionato tramite la clausola generale di buona fede, uno strumento per riequilibrare il contratto in caso di esercizio di un diritto contrattuale in modo sproporzionato rispetto agli interessi della controparte.
3. Ruolo del Giudice Riduzione ad Equità e Limiti all Intervento Giudiziale
La sezione discute il ruolo del giudice e i suoi poteri nell'applicazione dei rimedi in caso di usura sopravvenuta. Si analizza la riduzione ad equità come diritto potestativo attribuito alla parte convenuta in giudizio per la risoluzione del contratto. Tradizionalmente, la parte svantaggiata non può pretendere una modifica equa del contratto, ma l'obiettivo è quello di evitare la frustrazione dell'affidamento della parte che ha diritto alla prestazione. Si approfondisce la natura dell'offerta di reductio ad aequitatem, definita come un negozio unilaterale recettizio di diritto sostanziale. Si discute il rapporto tra le parti e i poteri del giudice, sottolineando che l'offerta di riduzione ad equità deve essere effettivamente tale, anche perché la parte colpita dalla sopravvenienza potrebbe rifiutarla per fini dilatori. Il giudice, in sede processuale, ha il potere di valutare l'equità dell'offerta e di determinare la modificazione equa del contratto, senza mortificare l'interesse della parte svantaggiata. Anche in sede stragiudiziale, la parte che riceve un'offerta equa può rinegoziare le condizioni contrattuali. L'infruttuoso esito delle trattative non è una violazione dell'obbligo di rinegoziazione, se le parti hanno agito con diligenza. In assenza di clausole specifiche, si applica il principio generale di buona fede.
IV.Rinegoziazione e Ruolo della Buona Fede
L'analisi si concentra sul ruolo della rinegoziazione, sia volontaria che obbligatoria, come rimedio principale per affrontare l'usura sopravvenuta. Si discute della necessità di considerare le specifiche esigenze del cliente-mutuatario, soprattutto nei casi di mutui per la prima casa. Si evidenzia come la buona fede agisca come limite interno a ogni situazione giuridica soggettiva, concorrendo alla conformazione del contratto e orientandone l'interpretazione ed esecuzione (articolo 1374, 1366 e 1375 del Codice Civile). L’influenza della legislazione consumeristica e delle direttive europee sulla rinegoziazione viene analizzata, considerando la possibilità di estinzione anticipata del mutuo.
1. La Rinegoziazione Un Rimedio Preferenziale
Questa sezione del documento pone l'accento sulla rinegoziazione come rimedio principale per affrontare l'usura sopravvenuta, soprattutto nei contratti di mutuo. Si argomenta che, rispetto alla risoluzione del contratto, la rinegoziazione è un approccio più efficiente ed equo, soprattutto quando si considerano le esigenze del cliente-mutuatario. La risoluzione, infatti, imporrebbe al mutuatario la restituzione immediata dell'intero finanziamento, creando una situazione potenzialmente peggiore di quella iniziale. Nel caso dei mutui per l'acquisto della prima casa, la risoluzione potrebbe compromettere la possibilità stessa di mantenere la proprietà dell'immobile. L'analisi economica sottolinea l'inefficienza della risoluzione, in quanto non consente di trasferire il rischio della sopravvenienza sul soggetto più adatto ad assumerlo. Mantenere in vita il contratto, con le necessarie modifiche, risulta quindi più efficiente. Il testo evidenzia come le condizioni per una rinegoziazione volontaria siano attualmente più favorevoli rispetto al passato, grazie all'impulso della disciplina consumeristica e agli obblighi informativi a carico delle banche che si traducono in una vera e propria attività di consulenza per il cliente. Si mette in luce come la rinegoziazione sia funzionale a garantire il conseguimento dell'utilità che il cliente-mutuatario intende realizzare con il contratto.
2. Rinegoziazione Volontaria ed Obbligatoria Aspetti Pratici e Limiti
La sezione distingue tra rinegoziazione volontaria e obbligatoria, sottolineando che, anche se le Sezioni Unite negano una generale ammissibilità della revisione giudiziale in caso di inadempimento dell'obbligo di rinegoziazione, ciò non esclude un intervento giudiziale in casi particolari. Questo intervento sarebbe ammissibile quando è possibile fare riferimento a parametri precisi ai quali le parti devono attenersi nella rinegoziazione, trasformandola in un mero strumento applicativo per l'adeguamento del contratto. Un ulteriore argomento a favore di questo approccio è la teoria dell'abuso del diritto, secondo cui il giudice può controllare e modificare lo statuto negoziale per garantire il giusto equilibrio tra gli interessi delle parti e reprimere eventuali abusi nell'esercizio di un diritto contrattuale. L’applicazione della buona fede in questo contesto è fondamentale: il documento evidenzia che un intervento giudiziale basato sui valori di mercato sarebbe inammissibile, perché negherebbe rilevanza alla contrattazione privata e all'equilibrio raggiunto dalle parti. La buona fede, quindi, serve a riequilibrare il contratto, ma non è uno strumento autonomo di giudizio equitativo. Il successo di una rinegoziazione dipende dalla diligenza delle parti nel predisporre clausole di hardship che disciplinino modalità e tempi dell'attuazione. In caso contrario, si fa riferimento al principio generale di buona fede.
3. Il Ruolo della Buona Fede e la Tutela del Cliente Mutuatario
La sezione approfondisce il ruolo della buona fede nel contesto della rinegoziazione e della tutela del cliente-mutuatario. Si evidenzia che la buona fede non è sufficiente a bloccare la pretesa di interessi divenuti usurari, ma opera solo in relazione a fatti concreti. L'attuale tendenza di alcuni interpreti a voler limitare l'ingerenza giudiziale nel contratto viene criticata, in quanto la funzione della buona fede è quella di rendere effettiva la tutela dei diritti e di individuare il rimedio più adeguato agli interessi delle parti. Si considera poi la situazione di debolezza del cliente-mutuatario, che non sempre deriva da asimmetria informativa o alterazione dei meccanismi concorrenziali. Nei finanziamenti per l'acquisto della prima casa, la soggezione del cliente è data dalla natura del suo bisogno, rendendo necessario offrire strumenti che tengano conto delle specifiche esigenze del contratto di finanziamento. Il documento conclude evidenziando l'importanza di un approccio che privilegi la manutenzione del contratto, attraverso la rinegoziazione, piuttosto che la risoluzione, per tutelare efficacemente gli interessi del cliente-mutuatario, soprattutto nei contratti di mutuo.
V.Il Ruolo del Giudice e la Disciplina Generale
Il documento conclude analizzando il ruolo del giudice nella gestione delle sopravvenienze e dell'usura sopravvenuta. Si sottolinea l'importanza di ricorrere alla disciplina generale del contratto, tenendo conto delle clausole generali e dei principi costituzionali. L'intervento giudiziale deve mirare a riportare il contratto entro i binari legali, nel rispetto della volontà delle parti, evitando una semplice applicazione sanzionatoria. Si esamina criticamente la giurisprudenza in materia, evidenziando la necessità di una valutazione caso per caso, con attenzione all’equilibrio tra gli interessi delle parti e l’applicazione di parametri obiettivi.
1. Il Ruolo del Giudice nell Interpretazione e nell Integrazione del Contratto
Questa sezione analizza il ruolo del giudice nella risoluzione delle controversie legate all'usura sopravvenuta, sottolineando l'importanza della disciplina generale del contratto e delle clausole generali connesse ai principi costituzionali. Il richiamo alla disciplina generale non è un semplice inciso, ma indica la necessità di individuare una soluzione compatibile con eventuali discipline puntuali esistenti. Secondo l'impostazione delle Sezioni Unite, la buona fede non è sufficiente a bloccare la pretesa di interessi divenuti usurari, ma opera in relazione a fatti concreti. Questa interpretazione viene criticata, in quanto riduce la buona fede a un ruolo marginale, probabilmente per evitare un'eccessiva ingerenza giudiziale nel contratto. Tuttavia, la funzione della buona fede è quella di garantire la tutela dei diritti e individuare il rimedio più adeguato agli interessi delle parti. La sentenza delle Sezioni Unite, definita da alcuni come 'lasca', è considerata insufficiente a risolvere definitivamente il problema dell'usura sopravvenuta, a causa di affermazioni contraddittorie e di un ambito di applicazione limitato (contratti a tasso fisso stipulati prima del 1996).
2. L Integrazione Giudiziale del Contratto e i Limiti dell Equità
Il documento esplora la possibilità di un intervento giudiziale integrativo del contratto in caso di inadempimento dell'obbligo di rinegoziazione, sostenendo che tale intervento è ammissibile quando si possono utilizzare parametri precisi, già previsti dalle parti per la rinegoziazione. In questi casi, la rinegoziazione diventa un mero strumento applicativo per l'adeguamento del contratto. La teoria dell'abuso del diritto (articolo 1375 Codice Civile) rafforza questa tesi: il giudice può controllare e modificare il contratto per garantire un giusto equilibrio tra gli interessi contrapposti, anche se un diritto è legittimamente attribuito ex contractu. Si evidenzia che l'esercizio di un diritto non è sempre legittimo in ogni modalità. Il giudice, quindi, può integrare o modificare il regolamento contrattuale per reprimere gli abusi di diritto. Tuttavia, non è possibile dare una risposta generale, dovendo valutare caso per caso l'esistenza di parametri sufficientemente obiettivi. Un intervento giudiziale basato sui valori di mercato non è ammissibile, perché ciò negherebbe rilievo alla contrattazione privata e all'equilibrio raggiunto dalle parti.
3. Buona Fede e Disciplina Generale Una Sintesi Conclusiva
In conclusione, la sezione ribadisce l'importanza della disciplina generale del contratto, che include la regolamentazione delle clausole generali e la loro connessione con i principi costituzionali, per risolvere il problema dell'usura sopravvenuta. L'obiettivo non è sanzionare un illecito, ma individuare rimedi che riportino il contratto alla normalità, rispettando la volontà delle parti. La buona fede, pur non essendo uno strumento sufficiente a bloccare la pretesa di interessi usurari, opera in relazione a fatti concreti. L'interpretazione della buona fede, quindi, non deve essere riduttiva, ma deve garantire una tutela effettiva dei diritti e individuare il rimedio più adeguato agli interessi delle parti. Il riferimento alla disciplina generale permette di considerare anche gli articoli 1374, 1366 e 1375 del Codice Civile, che sottolineano il dovere di solidarietà e la necessità di salvaguardare l'interesse dell'altra parte contrattuale. L’analisi critica della giurisprudenza, in particolare la sentenza delle Sezioni Unite, evidenzia la necessità di un approccio più completo e meno rigido nella gestione dell'usura sopravvenuta.
