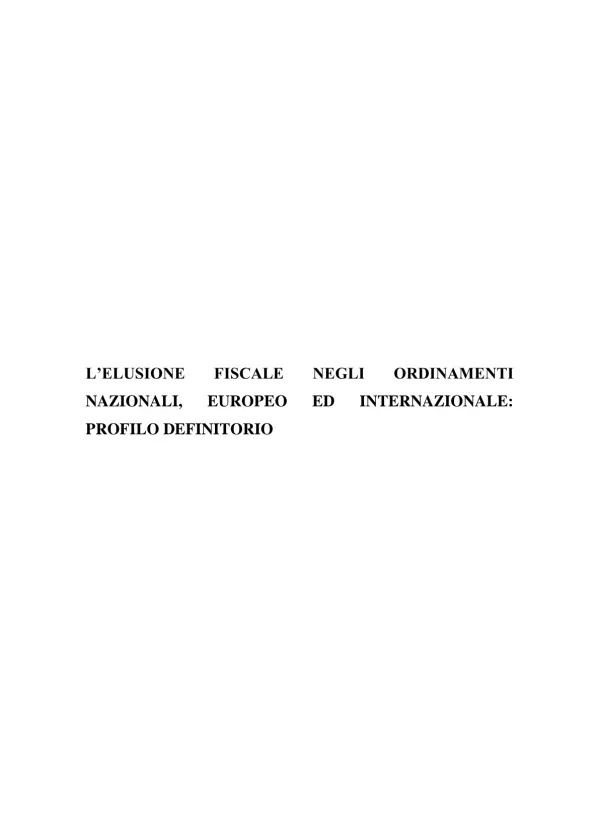
Elusione Fiscale: Italia e UE
Informazioni sul documento
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 2.22 MB |
Riassunto
I.L Interpretazione della Legge Tributaria e l Elusone Fiscale La Scuola di Becker
Il documento analizza l'evoluzione del rapporto tra interpretazione della legge tributaria e elusione fiscale, partendo dagli studi di Enno Becker (1869-1940), insigne giurista tedesco del primo dopoguerra. Becker, basandosi sull'Abgabenordnung (poi art. 9 della RAO del 1919), sosteneva che l'interpretazione della legge dovesse considerare lo scopo, il significato economico e lo sviluppo dei rapporti, al fine di tassare l'equivalente economico e contrastare efficacemente l'elusione fiscale. Questo approccio, recepito dalla dottrina e giurisprudenza tedesche fino agli anni '50, mirava alla massimizzazione del gettito fiscale, anche se non a qualunque costo, bilanciando l'obiettivo di ‘procacciare denaro’ con i principi di certezza del diritto.
1. Il Contesto Storico e la Figura di Enno Becker
Il capitolo introduce il tema del rapporto tra elusione fiscale e interpretazione della legge tributaria, contestualizzandolo storicamente nel periodo del primo dopoguerra tedesco, caratterizzato da un profondo dissesto finanziario. In questo scenario di crisi economica post-bellica, emerge la figura di Enno Becker (1869-1940), presidente di sezione della Cassazione Fiscale del Regno e coautore della codificazione tributaria concretizzatasi nella RAO del 1919. La sua influenza è stata determinante nello sviluppo del pensiero giuridico in materia di elusione. Becker, partendo dall'articolo 9 della RAO (precedentemente paragrafo 4 dell’Abgabenordnung), che prescriveva di considerare “il relativo scopo, il significato economico, lo sviluppo dei rapporti” nell’interpretazione della legge, ha proposto un'interpretazione estensiva delle norme tributarie al fine di contrastare efficacemente l’elusione fiscale. Questo approccio innovativo si basava sulla tassazione dell’equivalente economico, svincolandosi da un'applicazione meramente formalistica della legge.
2. L Interpretazione Estensiva e la Tassazione dell Equivalente Economico
Becker sosteneva che l'interprete, una volta individuato il fenomeno economico imponibile secondo la norma tributaria, dovesse estendere l’applicazione di quest’ultima a tutto ciò che si configurasse come “economicamente equivalente”. Questo significava che i concetti giuridici utilizzati nella norma tributaria, anche se provenienti da altri rami del diritto (in particolare il diritto civile), dovevano essere intesi in maniera autonoma, focalizzandosi sull’effetto economico prodotto e non sulla qualificazione giuridica civilistica della fattispecie. L'autore evidenziava l'importanza di considerare lo scopo, inteso come funzione economica, per cui il diritto tributario si avvale di istituti di diritto privato. L'approccio di Becker, incentrato sulla considerazione economica della fattispecie, è stato ampiamente recepito dalla dottrina e giurisprudenza tedesche, influenzando il modo di intendere l’elusione fiscale e l’interpretazione delle norme tributarie, sebbene tale orientamento sia mutato verso la metà degli anni '50. L'obiettivo principale era la massimizzazione del gettito fiscale dello Stato in un contesto di profonda crisi economica, ma sempre nel rispetto dei principi giuridici fondamentali.
3. Limiti dell Approccio di Becker e il Ruolo dell Ermeneutica
Il testo prosegue evidenziando i limiti dell'approccio di Becker, in particolare l'utilizzo esclusivo dell’ermeneutica per contrastare l'elusione fiscale. Si sottolinea come, se tramite l'interpretazione estensiva è possibile ricondurre la fattispecie elusiva all'ambito di applicazione della norma elusa, non si può parlare di elusione in senso proprio. Da qui la celebre affermazione di Hensel: “l’elusione inizia là dove finisce l’interpretazione”. L'efficacia dell'ermeneutica è dunque limitata dal rispetto dei principi fondamentali di certezza del diritto e riserva di legge. In molti casi, lo strumento interpretativo si rivela insufficiente quando la condotta elusiva porta all'applicazione di una norma diversa da quella che sarebbe applicabile in situazioni normali. Senza una disposizione ad hoc, l'applicazione dell'ermeneutica per disapplicare la norma formalmente applicabile a favore di quella sostanzialmente corretta risulta impossibile. L'analisi evidenzia la necessità di strumenti più incisivi per contrastare le forme più sofisticate di elusione fiscale, che vanno oltre le possibilità di una semplice interpretazione estensiva delle norme.
II.Limiti dell Ermeneutica e Nuovi Strumenti Anti Elusone
L'utilizzo esclusivo dell'ermeneutica per contrastare l'elusione fiscale presenta limiti. Hensel affermava che ‘l'elusione inizia là dove finisce l'interpretazione’. Il rispetto dei principi di certezza del diritto e riserva di legge (art. 23 Cost.) limita l'efficacia dell'interpretazione estensiva. La riqualificazione dei negozi giuridici, come nel caso della sentenza Orsi Mangelli (1979) che riguardava una donazione di titoli di Stato seguita da una permuta di immobili con il fine di eludere l’imposta sulle donazioni, è stata uno strumento utilizzato, ma anche contestato per potenziali conflitti con la riserva di legge.
III. 1344 c
La nullità del negozio per frode alla legge (art. 1344 c.c.) è stata proposta come strumento anti-elusione. La dottrina degli anni '70-'80 ne sosteneva l'applicazione nel diritto tributario, sanzionando con la nullità i negozi elusivi. Tuttavia, l'interpretazione dell'avverbio ‘fraudolentemente’ è stata dibattuta: alcuni ritenevano che richiedesse un elemento di dolo penale, confondendo elusione ed evasione fiscale. Il SECIT (Servizio Centrale degli Ispettori Tributari), con la delibera n. 105 del 1994, ha invece chiarito che l'abuso dello strumento negoziale è sufficiente, senza necessità di artifici o raggiri tipici del reato.
1. La Frode alla Legge art. 1344 c.c. come Strumento Antielusione
Questa sezione esplora l'utilizzo dell'articolo 1344 del codice civile, relativo alla frode alla legge, come strumento per contrastare l'elusione fiscale. Tra gli anni '70 e '80, una parte rilevante della dottrina sosteneva la possibilità di applicare questo istituto generale anche nel settore tributario, dichiarando nulli i negozi giuridici utilizzati per eludere una norma impositiva. L'applicazione di tale norma, comportando la nullità del negozio, lo rimuoverebbe radicalmente dal traffico giuridico, rendendolo privo di effetti, a differenza di un semplice disconoscimento da parte dell'Agenzia delle Entrate o di una riqualificazione in un altro negozio. La norma impositiva, in questo contesto, dovrebbe essere considerata imperativa, ovvero una norma cogente che non consente deroghe per tutelare interessi di carattere generale o di rilevanza pubblicistica. Si evidenzia che la sanzione della nullità avrebbe un impatto più significativo rispetto a semplici riqualificazioni, garantendo una maggiore deterrenza all'elusione.
2. Dibattito sull Interpretazione dell Avverbio Fraudolentemente
Un punto cruciale del dibattito riguarda l'interpretazione dell'avverbio "fraudolentemente" nell'articolo 1344 c.c. Alcuni interpretavano questo termine in senso penalistico, richiedendo la presenza di artifici e raggiri, e quindi la prova del dolo del contribuente, assimilando l'elusione all'evasione fiscale. Questa interpretazione, però, è criticata in quanto il ricorso ad artifici o raggiri è estraneo alle modalità con cui il contribuente realizza un'operazione elusiva. L'elusione fiscale, infatti, si caratterizza per l'utilizzo di strumenti legali che, pur rispettando la lettera della legge, ne tradiscono lo spirito. Al contrario, nell'evasione fiscale, il contribuente cerca di occultare un presupposto impositivo o di ridurne artificiosamente l'entità, ricorrendo a mezzi fraudolenti. L'interpretazione penalistica dell'avverbio “fraudolentemente” rischia quindi di confondere i due fenomeni. Il SECIT (Servizio Centrale degli Ispettori Tributari) ha invece escluso che l’avverbio “fraudolentemente” richieda artifici o raggiri in senso penalistico, ritenendo sufficiente la connotazione complessiva dell’operazione come abuso dello strumento negoziale.
3. Il Ruolo del SECIT e la Delibera n. 105 del 1994
Il Servizio Centrale degli Ispettori Tributari (SECIT), con la delibera n. 105 del 1994, ha analizzato l'articolo 10 della legge n. 408/1990, affermando che l'avverbio "fraudolentemente" non introduce nella fattispecie alcun elemento riconducibile all'accezione penalistica di artificio o raggiro. Questa posizione del SECIT, che svolgeva compiti di studio e controllo dei fenomeni fiscali, ha contribuito a chiarire l'interpretazione dell'istituto della frode alla legge nel contesto tributario, escludendo la necessità di un dolo specifico di matrice penale. L'interpretazione del SECIT privilegia una lettura più ampia, concentrandosi sull'abuso dello strumento negoziale come elemento sufficiente a configurare la frode alla legge nel campo tributario. Questa interpretazione è coerente con la necessità di contrastare l'elusione fiscale senza necessariamente ricorrere a strumenti di natura penale, semplificando l'accertamento e concentrandosi sull’effetto economico dell’operazione.
IV. 37 bis D
L'art. 37-bis del D.P.R. 600/1973, norma antielusiva, è stato oggetto di critiche per la sua indeterminatezza e per aver portato la giurisprudenza, a partire dal 2008, a sopravvalutare la mancanza di valide ragioni economiche come unico criterio per l'accertamento dei comportamenti elusivi, rischiando di confondere elusione e legittimo risparmio d'imposta. La relazione governativa di accompagnamento dell’art. 37-bis riconosceva invece il diritto al legittimo risparmio d'imposta.
1. L articolo 37 bis del D.P.R. 600 1973 Criticità Interpretative
La sezione analizza le criticità interpretative sorte attorno all'articolo 37-bis del D.P.R. 600/1973, norma volta a contrastare l'elusione fiscale. Il testo evidenzia come la giurisprudenza successiva al 2008 abbia sopravvalutato l'aspetto della mancanza di valide ragioni economiche, svalutando altri elementi costitutivi dell'elusione fiscale. Questa interpretazione restrittiva ha portato a contestazioni di elusione anche in casi di legittimo risparmio d'imposta, creando incertezza e difficoltà per i contribuenti. L'articolo, nella sua formulazione, non riusciva a definire con chiarezza il confine tra elusione fiscale e pianificazione fiscale lecita, generando un'eccessiva discrezionalità nell'applicazione della norma. La relazione governativa che accompagnava l'articolo 37-bis, al contrario, sottolineava esplicitamente il diritto del contribuente a perseguire un legittimo risparmio d'imposta scegliendo tra opzioni fiscalmente più vantaggiose, purché non si trattasse di manipolazioni o stratagemmi volti a eludere il sistema fiscale. Questo contrasto tra la lettera della legge e l’interpretazione giurisprudenziale ne ha compromesso l’efficacia e l’equità.
2. Il Concetto di Valide Ragioni Economiche
Un punto focale della discussione è il concetto di "valide ragioni economiche" nell'ambito dell'elusione fiscale. Il testo evidenzia la complessità nel definire e provare la presenza o l'assenza di tali ragioni. Si analizzano due possibili interpretazioni: 1) le valide ragioni economiche come elemento costitutivo dell'abuso del diritto, con l'onere della prova a carico dell'amministrazione finanziaria; e 2) le valide ragioni economiche come scriminante, con l'onere della prova a carico del contribuente. La giurisprudenza sembra considerare la mancanza di valide ragioni economiche come un indizio, e quindi una presunzione, della presenza di uno scopo elusivo, andando ad appesantire l’onere probatorio dell’amministrazione finanziaria. Questo aspetto rende complesso l'accertamento dell'elusione, in quanto il Fisco potrebbe non avere accesso a tutte le informazioni necessarie per valutare la presenza di valide ragioni economiche, rimanendo spesso esterno alle operazioni compiute dal contribuente. Si propone una distinzione tra “valide ragioni economiche” (aspetto soggettivo) e “sostanza economica” (aspetto oggettivo), alleggerendo l’onere della prova per il Fisco, concentrandosi sull’aspetto oggettivo e sulla prova, da parte del contribuente, di valide ragioni economiche.
3. La Necessità di un Confine Chiaro tra Elusione e Legittimo Risparmio d Imposta
La sezione conclude sottolineando la necessità di una chiara distinzione tra elusione fiscale e legittimo risparmio d'imposta. L'interpretazione giurisprudenziale dell'articolo 37-bis, che ha sopravvalutato la mancanza di valide ragioni economiche, ha creato un'incertezza inaccettabile, permettendo di contestare come elusive anche operazioni che miravano ad un risparmio d'imposta pienamente lecito. Questa situazione va contro il principio costituzionale di capacità contributiva e la relazione governativa che accompagnava l’art. 37-bis. Il documento evidenzia dunque l’importanza di una maggiore precisione nella definizione dei parametri per distinguere tra un legittimo risparmio fiscale e condotte elusive. La scelta del contribuente tra opzioni fiscalmente diverse deve essere rispettata, salvo che si configuri un abuso del diritto. Questo dimostra la necessità di una legislazione più chiara e precisa per evitare interpretazioni eccessivamente restrittive e garantire la certezza del diritto.
V. 23 2014 e il Nuovo Art
La legge delega n. 23/2014 ha introdotto il nuovo art. 10-bis, unificando le disposizioni antielusive sotto il principio generale del divieto di abuso del diritto. L'art. 10-bis distingue tra abuso/elusione e legittimo risparmio d'imposta, quest’ultimo definito come la scelta del contribuente tra diverse opzioni fiscalmente meno onerose. L'elemento soggettivo – lo scopo elusivo – è stato ridefinito, ponendo l'accento sulla essenzialità, non solo sulla prevalenza, dello scopo abusivo, per evitare la discrezionalità eccessiva nell'accertamento. L'interpello preventivo è stato introdotto per garantire maggiore certezza del diritto.
1. La Legge Delega n. 23 2014 e l obiettivo di unificazione delle norme antielusive
La sezione introduce la Legge Delega n. 23/2014, focalizzandosi sull'articolo 5, rubricato “Disciplina dell’abuso del diritto ed elusione fiscale”. L'obiettivo principale della delega era quello di superare le incertezze interpretative derivanti dall'articolo 37-bis del D.P.R. 600/1973, recependo le indicazioni della Raccomandazione della Commissione europea del 2012 sulla pianificazione fiscale aggressiva e la giurisprudenza comunitaria e interna. La legge delega mirava a unificare le disposizioni antielusive sotto il principio generale del divieto di abuso del diritto, con l'intento di creare un quadro normativo più coerente e certo. È importante notare che la Raccomandazione del 2012, inizialmente un atto di soft law non giuridicamente vincolante, ha acquisito piena forza legale grazie alla legge delega, rendendo obbligatoria la sua osservanza per il legislatore delegato. La nuova formulazione normativa, dunque, nasce dalla necessità di maggiore chiarezza e uniformità nella lotta all'elusione fiscale, cercando di armonizzare la legislazione italiana con gli standard europei.
2. Il Nuovo Articolo 10 bis e la Distinzione tra Elusione e Legittimo Risparmio d Imposta
Il nuovo articolo 10-bis, frutto della legge delega, introduce una definizione di abuso del diritto che si basa sulla distinzione tra abuso/elusione e legittimo risparmio d'imposta. Riprendendo la relazione governativa all'art. 37-bis del D.P.R. 600/1973, il legittimo risparmio d'imposta è definito come la scelta del contribuente tra diverse opzioni offerte dalla legge, comportanti un diverso carico fiscale. L'articolo 10-bis stabilisce che sono abusive le operazioni che “realizzano essenzialmente” vantaggi fiscali indebiti, introducendo un elemento di maggiore precisione rispetto al precedente art. 37-bis, ma mantenendo una certa elasticità interpretativa. Si evidenzia un possibile conflitto tra l'articolo 10-bis e la giurisprudenza comunitaria, che considera fondamentale l'elemento soggettivo (lo scopo elusivo) nella qualificazione di un comportamento come abusivo. La scelta di focalizzarsi sulla essenzialità dello scopo elusivo, anziché sulla sua mera prevalenza, intende ridurre la discrezionalità dell’amministrazione finanziaria nell’accertamento, limitando così il rischio di contestazioni infondate.
3. L Interpello Preventivo e la Certezza del Diritto
La sezione descrive l'introduzione dell'interpello preventivo (art. 11 legge n. 212/2000) come strumento per ridurre l'indeterminatezza insita nell'utilizzo di una clausola generale anti-abuso. Questo istituto consente al contribuente di chiedere all'amministrazione finanziaria un parere preventivo sulla natura elusiva o meno delle operazioni che intende realizzare, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi o dell'assolvimento di altri obblighi tributari. L’introduzione dell’interpello preventivo viene vista favorevolmente in quanto strumento idoneo a garantire maggiore certezza del diritto nei rapporti tra Fisco e contribuente, riducendo la discrezionalità e l’incertezza che derivano da una norma antielusiva generale. Si riconosce però che l’adozione di una clausola generale anti-abuso comporta un grado di indeterminatezza, e che l’obiettivo del legislatore dovrebbe essere quello di ridurre tale indeterminatezza il più possibile. L’interpello preventivo si pone proprio come strumento per questo obiettivo.
VI.L Abuso del Diritto nell Ordinamento Comunitario Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE
Il documento analizza la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE sull'abuso del diritto, distinguendo tra abuso in senso lato (sfruttamento di asimmetrie tra normative nazionali e libertà comunitarie) e abuso in senso stretto (aggiramento di norme comunitarie). Casi come Van Binsbergen (1974), Halifax, Cadbury Schweppes, e Thin Cap Group Litigation sono esaminati per illustrare l'evoluzione del concetto di abuso, evidenziando l’importanza della prova di elementi oggettivi (uso distorto di strumenti giuridici privi di sostanza economica) e dell’elemento soggettivo (scopo essenziale o unico di ottenere un vantaggio fiscale indebito). La sentenza Kofoed (e la successiva Zwijnenburg) evidenzia i limiti dell’applicazione diretta del principio di divieto di abuso del diritto in assenza di specifica disposizione nazionale di trasposizione.
1. Il Principio del Divieto di Abuso del Diritto nell Ordinamento Comunitario
Questa sezione del documento analizza il principio del divieto di abuso del diritto nell'ordinamento comunitario, come elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Si evidenzia come questo principio, pur non essendo espressamente previsto in specifiche disposizioni del diritto dell'Unione Europea, sia stato riconosciuto dalla Corte come un principio generale. La Corte ha affermato l'esistenza di un divieto di aggirare le norme degli Stati membri attraverso l'esercizio delle libertà riconosciute dai Trattati europei, un principio che giustifica, nei limiti necessari, una compressione di tali libertà per contrastare condotte abusive. La sentenza Van Binsbergen del 1974, relativa alla libera prestazione di servizi, viene citata come esempio iniziale di questo principio, in cui la Corte ha escluso la possibilità di utilizzare la libera circolazione dei servizi per evitare l'applicazione delle regole professionali dello Stato di origine. Il documento sottolinea che il contrasto alle pratiche abusive costituisce una ragione imperativa di interesse generale, tale da giustificare restrizioni alle libertà fondamentali previste dai Trattati.
2. Abuso in Senso Stretto e Abuso in Senso Lato
Il testo distingue tra due accezioni di abuso del diritto: in senso stretto e in senso lato. L’abuso in senso lato riguarda principalmente la fiscalità non armonizzata, dove il contribuente sfrutta le asimmetrie tra la normativa nazionale e le libertà comunitarie, invocando una libertà fondamentale garantita dal Trattato per ottenere un vantaggio fiscale in contrasto con la ratio della norma comunitaria primaria. In questo caso, il vantaggio fiscale è qualificato come indebito per la contrarietà alla ratio della norma comunitaria. L’abuso in senso stretto, invece, riguarda l’aggiramento di norme comunitarie di diritto derivato. Il legislatore comunitario, consapevole del rischio di elusione delle direttive, ha inserito misure self-protective che autorizzano gli Stati membri a negare i benefici previsti in caso di abuso, senza però definire l’istituto dell’abuso. La direttiva “anti-elusione” del 2016 segna un’inversione di tendenza, fornendo una definizione più puntuale del concetto di abuso.
3. Analisi di Casi Giurisprudenziali della Corte di Giustizia UE
La sezione analizza alcuni casi giurisprudenziali della Corte di Giustizia UE, tra cui Halifax, Cadbury Schweppes, e Thin Cap Group Litigation, per illustrare l'evoluzione del concetto di abuso del diritto e i suoi elementi costitutivi. La sentenza Halifax, riguardante l’IVA, e la sentenza Cadbury Schweppes, che si riferisce ad una libertà fondamentale garantita dal Trattato, evidenziano l'importanza di definire con chiarezza l'elemento oggettivo dell'abuso, ossia l’ottenimento di un vantaggio fiscale indebito e l’uso distorto di strumenti giuridici (costruzioni di puro artificio). La Corte ha riconosciuto il diritto dei contribuenti a perseguire un legittimo risparmio d'imposta, ma ha anche ribadito la possibilità di contrastare comportamenti abusivi, anche se questo implica la restrizione di una libertà fondamentale. L’analisi dei casi giurisprudenziali mostra l’evoluzione del pensiero giurisprudenziale, dalla prova generica dello sviamento della finalità di una norma a una più precisa definizione dell’elemento oggettivo come ottenimento di un vantaggio fiscale indebito, pur riconoscendo la legittimità del risparmio d’imposta se non abusivo. La sentenza Kofoed e la successiva Zwijnenburg confermano la necessità di norme interne per contrastare l’abuso del diritto comunitario.
