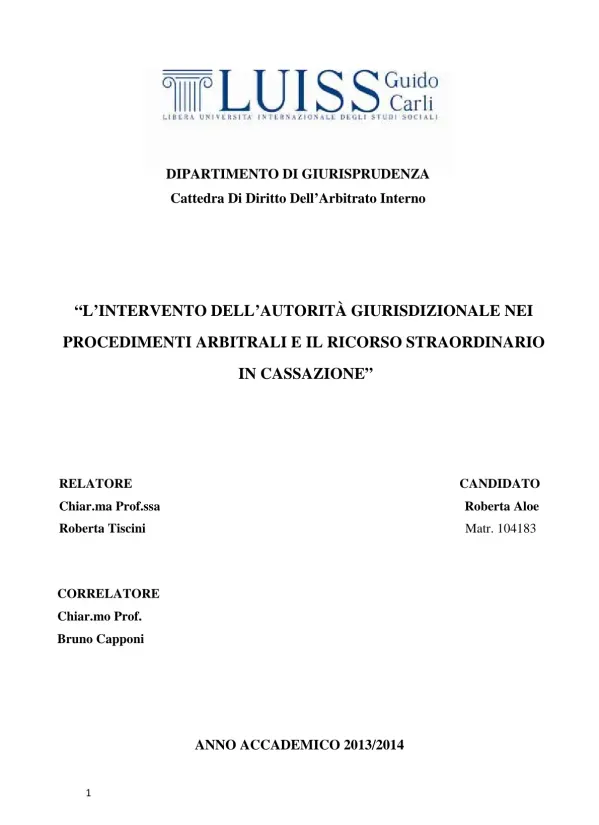
Ricorso Straordinario Arbitrato
Informazioni sul documento
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 0.91 MB |
Riassunto
I.Invalidità del Lodo Arbitrale
Il documento analizza le cause di invalidità del lodo arbitrale (art. 808 ter c.p.c.), focalizzandosi sui vizi del procedimento che ledono la volontà delle parti. Si evidenziano due eccezioni in cui prevale la volontà del legislatore: scelta dell'arbitro in deroga all'art. 812 c.p.c. e decisioni extra compromissum. La violazione del principio del contraddittorio non è di per sé un vizio, ma si considera il suo effettivo rispetto. L'oggetto della controversia deve essere determinato nel compromesso per evitare la nullità della convenzione arbitrale.
1. Motivi di Invalidità del Lodo Irrituale art. 808 ter c.p.c.
Il documento inizia analizzando i motivi di invalidità del lodo irrituale, come tipizzati dal secondo comma dell'art. 808 ter c.p.c. Questi motivi si concentrano essenzialmente su vizi procedurali derivanti dalla violazione della volontà delle parti coinvolte nel procedimento arbitrale. Un aspetto chiave è l'eccezione alla regola: la volontà del legislatore prevale su quella delle parti solo in due casi specifici. Il primo è la scelta dell'arbitro in contrasto con quanto previsto dall'art. 812 c.p.c. Il secondo riguarda le decisioni extra compromissum, ovvero decisioni prese al di fuori dell'ambito del compromesso. In quest'ultima ipotesi, la nullità può essere fatta valere unicamente se l'eccezione è sollevata durante il procedimento arbitrale. Un punto importante è che la violazione del principio del contraddittorio non è considerata un vizio procedurale in sé, in quanto ciò che conta è il suo effettivo rispetto, indipendentemente dal rispetto formale delle norme che lo disciplinano. La possibilità di una convenzione arbitrale generica è esclusa; per evitare la nullità, la convenzione deve indicare specificatamente l'oggetto della controversia. Questo oggetto deve essere chiaramente definito nel compromesso, con riferimento al contratto in caso di controversie contrattuali, o ai rapporti non contrattuali specifici per controversie future di natura non contrattuale. La convenzione non necessita di indicare gli arbitri, il loro numero o il metodo di nomina; in caso di mancanza di tali indicazioni, subentrano i meccanismi suppletivi previsti dalla legge. Rimane facoltà delle parti indicare la sede dell'arbitrato (art. 816 c.p.c.), le norme da seguire, la lingua (art. 816 bis c.p.c.), il termine per il lodo (art. 820 c.p.c.) e la possibilità di un lodo secondo equità (art. 822 c.p.c.).
2. Requisiti Essenziali della Convenzione Arbitrale e Nullità
Un elemento fondamentale per la validità della convenzione arbitrale è la precisa individuazione dell'oggetto della controversia. Una convenzione generica è nulla. La definizione dell'oggetto deve essere chiara e inequivocabile, fatta risalire al contratto di riferimento nel caso di controversie contrattuali, oppure ai specifici rapporti non contrattuali in caso di controversie future extracontrattuali. Al contrario, l'indicazione degli arbitri, del loro numero o delle modalità di nomina non è un requisito essenziale della convenzione; in assenza di tali indicazioni, la legge interviene con meccanismi suppletivi. Le parti hanno comunque la facoltà di specificare altri aspetti del procedimento arbitrale, come la sede (art. 816 c.p.c.), le norme applicabili, la lingua (art. 816 bis c.p.c.), il termine per la pronuncia del lodo (art. 820 c.p.c.), e la possibilità di un lodo basato sull'equità (art. 822 c.p.c.). La mancanza di questi dettagli non inficia la validità della convenzione, ma semplicemente attiva i meccanismi di integrazione legislativa. L'analisi si concentra sulla necessità di chiarezza e precisione nell'indicazione dell'oggetto del contendere, evidenziando il rischio di nullità in caso di ambiguità o genericità. Questo aspetto è cruciale per la validità dell'intero procedimento arbitrale, in quanto una definizione imprecisa dell'oggetto della controversia compromette la stessa base su cui si fonda il procedimento arbitrale stesso. Il documento sottolinea quindi l'importanza di una redazione accurata e precisa della convenzione arbitrale al fine di evitarne la nullità.
II.Disponibilità dei Diritti e Giurisdizione Arbitrale
Si discute la disponibilità dei diritti e i limiti alla giurisdizione arbitrale. La questione principale è: perché i giudici possono trattare controversie su diritti indisponibili, mentre gli arbitri no? Il documento ripercorre l'evoluzione giurisprudenziale, partendo dalla sentenza del 2 maggio 1958 n. 35, fino all'orientamento delle Sezioni Unite che riconosce la natura giurisdizionale dell'arbitrato, equiparando il lodo a una sentenza dello Stato. Si analizza il rapporto tra arbitrato e Costituzione, evidenziando l'importanza dell'autonomia delle parti e la necessità di evitare un'ingiustificata compressione del diritto di azione.
1. Limiti alla Giurisdizione Arbitrale e Disponibilità dei Diritti
La sezione inizia ponendo una domanda cruciale: perché i giudici ordinari possono decidere su controversie riguardanti diritti indisponibili, mentre agli arbitri tale competenza è preclusa? Questa differenza evidenzia i limiti intrinseci della giurisdizione arbitrale rispetto alla giurisdizione statale. Si introduce il concetto di 'disponibilità dei diritti', che definisce quali diritti possono essere oggetto di arbitrato. Il testo poi analizza l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, partendo dalla sentenza della Corte di Cassazione del 2 maggio 1958 n. 35. Sebbene questa sentenza non chiarisca esplicitamente il rapporto tra l'istituto arbitrale e la Costituzione, essa afferma la riserva statale della potestà normativa sull'amministrazione della giustizia. La sentenza, pur mostrando una certa avversione all'arbitrato, riconosce la statualità della giurisdizione e collega il diritto di azione al potere di disposizione delle parti. La possibilità di sottrarre controversie alla giurisdizione statale è quindi subordinata all'autonomia delle parti. Si evidenzia una contrapposizione tra l'efficacia dell'atto arbitrale e la sua natura, un tema che sarà ripreso e approfondito nella parte successiva del documento. Autori come Punzi, Luiso e Falazzari sono citati in relazione a diverse interpretazioni della riserva di giurisdizione e della compatibilità dell’arbitrato con la Costituzione, mostrando un dibattito dottrinale complesso che si è poi evoluto con la giurisprudenza successiva. L'analisi pone le basi per la comprensione dei vincoli e delle limitazioni che il sistema giuridico impone all'arbitrato, in particolare riguardo alla natura dei diritti che possono essere sottoposti a tale forma di risoluzione delle controversie.
2. Evoluzione Giurisprudenziale e Natura Giurisdizionale dell Arbitrato
La sezione prosegue analizzando l'evoluzione della giurisprudenza in materia di arbitrato, mostrando come il riconoscimento dell'efficacia di sentenza al lodo (art. 824 bis c.p.c.) abbia modificato significativamente la percezione della natura dell'arbitrato. Si evidenzia la distinzione fondamentale tra l'efficacia dell'atto arbitrale e la sua natura, che costituisce un punto nodale per la risoluzione dei conflitti tra arbitrato e giustizia statale. Il documento fa riferimento ad altre sentenze della Corte Costituzionale, a contributi dottrinali e alle posizioni di diversi autori, sottolineando il dibattito sulla legittimità costituzionale dell'attribuzione al lodo di efficacia di sentenza. Si cita l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha inaugurato un nuovo orientamento, riconoscendo la natura giurisdizionale dell'arbitrato e equiparando il lodo a una sentenza pronunciata dai giudici statali. Il superamento delle preoccupazioni circa la costituzionalità di tale equiparazione si basa sulla distinzione tra natura dell'atto e gli effetti prodotti, considerando le garanzie costituzionali assicurate. Questo cambiamento di prospettiva sposta l'attenzione dal dibattito sulla legittimità costituzionale dell'arbitrato alla necessità di garantire che la scelta arbitrale non abbia ricadute negative sui diritti delle parti. Si delinea quindi un passaggio fondamentale nella giurisprudenza italiana, con il riconoscimento dell'arbitrato come una forma di giustizia alternativa, ma sostanzialmente equiparabile a quella statale, in termini di effetti e garanzie.
3. L Art. 819 ter c.p.c. e la Traslatio Iudicii
La sezione analizza l'articolo 819 ter c.p.c. e il suo rapporto con l'istituto della traslatio iudicii. Si esamina la giurisprudenza precedente alla riforma del 1994, che stabiliva la competenza esclusiva del giudice ordinario in caso di cause connesse tra giudice e arbitro, impedendo la coesistenza di pronunce contrastanti. Si sottolinea come questo sistema fosse spesso utilizzato impropriamente per sottrarre controversie alla cognizione degli arbitri. La riforma del 1994, con l'art. 819 bis (poi trasmigrato nell'art. 819 ter), ha modificato questa regola, stabilendo che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione con una causa pendente davanti al giudice ordinario. La scelta arbitrale è interpretata come una rinuncia alla tutela giurisdizionale statale, rendendo così irrilevante la connessione con cause pendenti presso i giudici ordinari. Vengono citati contributi dottrinali di Zino, Acone e Gasperini, che esprimono opinioni diverse sull'interpretazione della Corte Costituzionale in merito alla traslatio iudicii nell'ambito dei rapporti tra giudice e arbitro. Il dibattito si concentra sul bilanciamento tra il principio di effettività della giurisdizione e la volontà delle parti di avvalersi della giustizia privata. La sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2013, dichiarando illegittimo parte dell’art. 819 ter c.p.c., evidenzia la necessità di tutelare l'effettività della giurisdizione, anche in presenza di errori delle parti nella scelta del giudice o dell'arbitro competente.
III.Rapporti tra Arbitro e Giudice Ordinario
Il documento approfondisce i complessi rapporti tra arbitro e giudice ordinario, analizzando gli effetti della riforma del 2006 (D.lgs. 40/2006) e l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 223/2013). Si discute la questione della traslatio iudicii e l'applicazione dell'art. 50 c.p.c. all'arbitrato. La giurisprudenza, dopo la riforma, ha affermato la natura giurisdizionale dell'arbitrato, superando precedenti dubbi di costituzionalità. Si esaminano le conseguenze della pendenza di cause connesse tra giudice e arbitro, in particolare la competenza degli arbitri in presenza di una causa pendente davanti al giudice ordinario. La sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2013 è fondamentale, dichiarando illegittimo l'art. 819 ter c.p.c. in parte per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.
1. La Giurisprudenza Precedente alla Riforma del 1994 e la Vis Attrac tiva
Prima della riforma del 1994, la giurisprudenza stabiliva una 'vis attractiva' della competenza del giudice ordinario nei casi di pendenza di cause connesse tra giudice e arbitro rituale. Si riteneva inammissibile la coesistenza di pronunce contrastanti su cause connesse, emesse sia dal giudice ordinario che dall'arbitro. Questo sistema, però, era spesso utilizzato impropriamente, creando cause ad hoc per sottrarre la cognizione agli arbitri. Il documento evidenzia la problematicità di questo approccio, sottolineando l'uso strumentale del sistema per eludere la competenza dell'arbitro. La coesistenza di due sentenze su una stessa controversia creava incertezza e inefficacia nel sistema giudiziario. La giurisprudenza, nel tentativo di garantire la coerenza del sistema giudiziario, privilegiava la competenza del giudice ordinario, anche in presenza di un accordo arbitrale. Questa situazione di incertezza e potenziale conflitto tra giurisdizioni ha portato alla necessità di una riforma legislativa, finalizzata a chiarire la competenza e a garantire l'effettività dell'arbitrato. La riforma si proponeva di evitare l'elusione della giurisdizione arbitrale attraverso la creazione di cause ad hoc connesse a procedimenti già pendenti davanti al giudice ordinario. L'obiettivo era quello di definire con chiarezza i confini tra la competenza del giudice ordinario e quella dell'arbitro, evitando conflitti e inefficienze nel sistema giudiziario.
2. La Riforma del 1994 e l Art. 819 ter c.p.c. Competenza dell Arbitro e Connessione tra Cause
La riforma del 1994, con l'introduzione dell'art. 819 bis (poi integrato nell'art. 819 ter), ha modificato radicalmente l'approccio ai rapporti tra giudice ordinario e arbitro. La nuova regola stabilisce che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia arbitrale e una causa pendente davanti al giudice ordinario. Il documento chiarisce che l'effetto della stipula del patto compromissorio è quello di rinunciare alla tutela giurisdizionale ordinaria. Quindi, nessun giudice ordinario può conoscere la causa oggetto di compromesso, anche se connessa a un'altra causa pendente presso lo stesso giudice. Si evidenzia che non si tratta di spostare la competenza da un giudice all'altro, ma di una scelta consapevole delle parti di ricorrere alla giustizia privata, rinunciando alla giurisdizione statale. Questo principio fondamentale elimina la possibilità di conflitti di competenza tra arbitro e giudice ordinario, chiarendo la supremazia dell'accordo arbitrale in presenza di una causa connessa pendente presso la giurisdizione ordinaria. L'art. 819 ter c.p.c. costituisce quindi un cardine della nuova disciplina, che mira a garantire l'effettività dell'arbitrato, evitando interferenze da parte dei giudici ordinari. Questo cambiamento implica una maggiore autonomia del procedimento arbitrale rispetto al sistema giudiziario ordinario.
3. L Intervento della Corte Costituzionale Sentenza n. 223 2013 e la Natura Giurisdizionale dell Arbitrato
La sezione analizza l'intervento della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 223 del 2013, che ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 819 ter, comma 2, c.p.c. nella parte in cui escludeva l'applicabilità, nei rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti alle previsioni dell'art. 50 c.p.c. Questa sentenza, quindi, ha avuto un impatto significativo sull'interpretazione dei rapporti tra arbitrato e giudice ordinario, rafforzando la natura giurisdizionale dell'arbitrato. La Corte di Cassazione, sulla scia di questa pronuncia, ha affermato senza esitazioni la natura giurisdizionale del fenomeno arbitrale, equiparando il lodo a una sentenza pronunciata dai giudici statali. Si sottolinea come questo orientamento sia stato raggiunto dopo aver superato le preoccupazioni relative ai possibili dubbi di costituzionalità. La distinzione tra la natura degli atti arbitrali e gli effetti prodotti, nel rispetto delle garanzie costituzionali, è stata fondamentale per superare le precedenti resistenze all'equiparazione tra lodo e sentenza. La sentenza n. 223/2013 della Corte Costituzionale, sollecitata dal Tribunale di Catania e da un arbitro di Bologna, ha evidenziato l’importanza del principio di effettività della giurisdizione, affermando che l'errore di una parte nello scegliere tra giudice e arbitro non deve mai pregiudicare la tutela del diritto sostanziale. Questa pronuncia ha quindi contribuito a definire in modo più preciso il rapporto tra arbitrato e giurisdizione statale, ribadendo l'importanza del rispetto della volontà delle parti e l'effettività della tutela giurisdizionale.
IV.Controllo Giurisdizionale sull Arbitrato e Ricorso in Cassazione
L'analisi si concentra sul controllo giurisdizionale sull'arbitrato, con particolare attenzione al ricorso in Cassazione. Si esaminano le diverse tipologie di ricorsi (ordinario e straordinario), la decorrenza dei termini e l'importanza della forma del provvedimento. Si discute l'estensione del controllo della Corte sulle decisioni dei giudici speciali e l'evoluzione giurisprudenziale in materia di impugnazione dei provvedimenti decisori. Viene anche affrontato il tema della disapplicazione delle norme in contrasto con la Costituzione (art. 111 Cost.) e il ruolo del giudice nell'interpretazione delle norme legislative. La nomofilachia della Corte di Cassazione è un elemento centrale.
1. Il Controllo Giurisdizionale sull Arbitrato Evoluzione Giurisprudenziale e Ruolo della Corte Costituzionale
Questa sezione del documento analizza il controllo giurisdizionale sull'arbitrato, focalizzandosi sul ruolo della Corte Costituzionale e sull'evoluzione della giurisprudenza in materia. Si parte dalla sentenza del 2 maggio 1958 n. 35, che, pur non definendo il rapporto tra arbitrato e Costituzione, riconosce la statualità della giurisdizione e pone in relazione il diritto di azione con l'autonomia delle parti. L'evoluzione successiva porta al riconoscimento dell'efficacia del lodo arbitrale come sentenza (art. 824 bis c.p.c.), risolvendo il contrasto tra efficacia e natura dell'atto tramite una distinzione tra natura degli atti ed effetti prodotti. Il documento evidenzia il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla compatibilità dell'arbitrato con la Costituzione, citando autori come Punzi, Luiso e Falazzari. L’analisi approfondisce poi l’influenza della riforma del 2006 (D.lgs. 40/2006) e del successivo intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 223 del 2013. Questa sentenza dichiara illegittimo, in parte, l'art. 819 ter c.p.c. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., mettendo in luce la necessità di garantire l’effettività della giurisdizione, anche in caso di errore nella scelta del giudice o dell’arbitro competente. L'analisi si concentra sulla natura giurisdizionale dell'arbitrato, riconoscendo al lodo la stessa efficacia di una sentenza statale, nel rispetto delle garanzie costituzionali. Il ruolo della Corte Costituzionale nel plasmare l’interpretazione dei rapporti tra arbitrato e giustizia ordinaria è, quindi, centrale.
2. Ricorso in Cassazione Tipologie Termini e Forma del Provvedimento
La sezione approfondisce il tema del ricorso in Cassazione avverso i provvedimenti arbitrali, distinguendo tra ricorso ordinario e straordinario. Si analizza la decorrenza dei termini per il ricorso straordinario, evidenziando le diverse interpretazioni giurisprudenziali sulla decorrenza del termine breve (art. 325 c.p.c.) a seconda che l'ordinanza sia pronunciata in udienza o fuori udienza. L’importanza della forma del provvedimento nell’ambito del ricorso in Cassazione è sottolineata, con particolare attenzione al ruolo della forma “sentenza” e alla sua influenza sulle regole procedurali applicate (artt. 286, 326 e 327 c.p.c.). Il documento evidenzia come, in assenza di una previsione legislativa esplicita, la Corte di Cassazione, sulla base della valutazione della forma del provvedimento, qualifica il ricorso come ordinario. Questo processo decisionale è, però, soggetto alla condizione che la legge non escluda l’impugnazione. La natura camerale o non contenziosa del procedimento non è determinante. L'analisi approfondisce il dibattito giurisprudenziale sull’accesso in Cassazione, evidenziando le differenti posizioni dottrinali in merito alla tutela dei diritti e alla ragionevole durata del processo. Si citano diverse sentenze della Corte di Cassazione, mostrando come la giurisprudenza sia in continua evoluzione, cercando di bilanciare l’esigenza di efficienza con la tutela dei diritti delle parti coinvolte. Si parla anche dell’art. 111, comma 7, Cost. e del suo impatto sull'ammissibilità del ricorso in Cassazione.
3. Controllo sulla Motivazione e Funzione Nomofilattica della Corte di Cassazione
La sezione si concentra sul controllo sulla motivazione delle sentenze e sulla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione. Si esaminano le diverse interpretazioni giurisprudenziali sulla possibilità di un vaglio sulla motivazione, distinguendo tra il controllo di merito e il controllo sulla correttezza metodologica del giudice di merito. Il documento evidenzia le tensioni tra l'esigenza di ridurre il carico di lavoro della Corte di Cassazione e la necessità di garantire la tutela dei diritti delle parti. Si evidenzia come la limitazione del ricorso in Cassazione non trovi piena giustificazione nella necessità di sanare una discrasia tra il sistema civile e quello penale, in quanto differenze ragionevoli sono ammissibili. Si sottolinea l’importanza dell'articolo 111, comma 7, della Costituzione, e la garanzia costituzionale di un ricorso in Cassazione avverso i provvedimenti decisori non altrimenti impugnabili. Il D.lgs. 40 del 2006, volto a migliorare l’esercizio della funzione nomofilattica, è analizzato, così come le successive riforme legislative (es. L. 83/2012) e il dibattito dottrinale (es. Bianchi d’Espinosa, Garbagnati, Di Iasi, Merone) sulle modifiche introdotte. L'analisi si conclude evidenziando la difficoltà di individuare un rimedio efficace per conciliare l'efficienza del sistema giudiziario con la tutela dei diritti delle parti e la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione.
V.Nomina e Ricusazione degli Arbitri
Il documento tratta la nomina degli arbitri e i meccanismi di ricusazione, analizzando le norme che regolano l'intervento dell'autorità giurisdizionale (artt. 813 ter e 814 c.p.c.). Si sottolineano i meccanismi integrativo-suppletivi previsti per evitare l'ostruzionismo delle parti e garantire l'avvio dell'arbitrato. La tutela dell'imparzialità e dell'indipendenza dell'arbitro è fondamentale, come evidenziato dall'art. 815 c.p.c. (ricusazione dell'arbitro). L'art. 810 c.p.c. e il suo ruolo nella nomina degli arbitri sono analizzati.
1. Nomina degli Arbitri e Intervento dell Autorità Giurisdizionale
La sezione analizza il processo di nomina degli arbitri e l'intervento dell'autorità giudiziaria, evidenziando come le norme legislative regolino aspetti cruciali per garantire sia la funzionalità del giudizio che la tutela delle parti. L'intervento dell'autorità giudiziaria si intensifica nella fase di nomina e costituzione dell'organo arbitrale, con un controllo sull'imparzialità e indipendenza dell'arbitro, sui suoi diritti e obblighi, e sulla sua responsabilità verso le parti. Si esaminano interventi legislativi volti a regolare i rapporti tra le parti e gli arbitri (artt. 813 ter e 814 c.p.c.), e meccanismi di tutela di una parte contro l'ostruzionismo dell'altra, come i meccanismi integrativo-suppletivi di nomina (art. 810 c.p.c.) in caso di inerzia di una parte, o la ricusazione dell'arbitro per sospetto di parzialità (art. 815 c.p.c.). Il documento sottolinea l'importanza di questi meccanismi per garantire l'effettività della scelta arbitrale, evitando che l'inerzia di una parte possa bloccare l'intero procedimento. Si evidenzia come la tutela offerta sia equiparata, ma non identica, a quella giurisdizionale, riconoscendo una matrice non del tutto 'autosufficiente', e quindi la possibile necessità di un intervento dell'autorità giudiziaria anche in ambiti regolati dall'autonomia privata. L'intervento del giudice è visto come una garanzia dell'autonomia negoziale piuttosto che una sua mortificazione, con la tutela dei diritti assicurata tramite il ricorso straordinario in Cassazione in caso di provvedimento giudiziale non impugnabile.
2. Riforma del 2006 e il Ruolo del Presidente del Tribunale nella Nomina degli Arbitri Art. 810 c.p.c.
La sezione approfondisce il ruolo del Presidente del Tribunale nella nomina degli arbitri, in particolare in relazione all'art. 810 c.p.c. e alla riforma del 2006. Si discute la natura del procedimento, oscillante tra una visione processualistica (procedimento contenzioso su diritti soggettivi) e una contrattualistica (intervento di giurisdizione volontaria per integrare la volontà delle parti). La giurisprudenza maggioritaria tende a qualificare l'attività del Presidente del Tribunale come contenziosa, con il provvedimento avente efficacia di giudicato e quindi impugnabile in Cassazione. Il documento analizza la sentenza 15586/2009 della Corte di Cassazione, che indaga sulla natura del procedimento, chiedendosi se esso riguardi l'accertamento di un diritto soggettivo di credito o la sua quantificazione. La peculiarità delle convenzioni arbitrali, spesso incomplete nella determinazione quantitativa del compenso, spinge il legislatore a prevedere la possibilità che gli arbitri si rivolgano al Presidente del Tribunale in caso di mancato accordo sulle pretese di compenso. Si tratta di una clausola che si inserisce automaticamente nel contratto d'arbitrato in assenza di specifiche clausole. Il documento evidenzia la natura contenziosa del procedimento, comparandolo con quello monitorio o ordinario, e sottolinea come la scelta della non-contenziosità contrasterebbe con l'obbligatorietà della difesa tecnica. Sebbene la giurisprudenza successiva si sia adeguata all'orientamento delle Sezioni Unite, restano alcune decisioni di segno contrario. L’analisi si concentra sulla giurisprudenza relativa all’art. 810 c.p.c., evidenziando i conflitti interpretativi e l’evoluzione della posizione della Corte di Cassazione.
3. Ricusazione dell Arbitro Motivi e Procedimento
Questa parte esamina i motivi di ricusazione dell'arbitro, confrontandoli con le previsioni dell'art. 51 c.p.c. Si analizza il numero 4 dell'art. 51 c.p.c. e la sua evoluzione nella disciplina dell'arbitrato, evidenziando il superamento di una precedente formulazione che dava luogo a problemi interpretativi. La nuova normativa prevede specifici rapporti (consulenza, prestazione d'opera retribuita, altri rapporti patrimoniali) che possono compromettere l'indipendenza dell'arbitro, sostituendo una formulazione più generica. Il numero 6, che prevede incompatibilità derivanti da consulenza, assistenza o difesa in una precedente fase della vicenda o da deposizione testimoniale, è analizzato in rapporto al numero 4 dell'art. 51 c.p.c., sottolineando l'esclusione della consulenza tecnica d'ufficio. Si discute il dovere morale e professionale di astensione dell'arbitro, evidenziando come il suo mancato rispetto non abbia conseguenze giuridiche salvo in caso di violazione del regolamento dell'istituzione arbitrale. Il procedimento di ricusazione è esaminato anche riguardo alle spese, con una discussione sulla loro allocazione in caso di accoglimento o rigetto dell'istanza, evidenziando che l'ordinanza sulle spese è decisoria ma non definitiva, e che le stesse saranno allocate a favore della parte definitivamente vittoriosa. La ricorribilità in Cassazione dell'ordinanza che decide sull'istanza di ricusazione è discussa, evidenziando la contrapposizione tra chi la ritiene ammissibile e chi la ritiene inammissibile, in relazione alla decisorietà e definitività del provvedimento. Il documento evidenzia la complessità del tema, le differenti interpretazioni e l’evoluzione della giurisprudenza, citando sentenze della Cassazione (es. 2010 n. 23056).
VI.Liquidazione dei Compensi degli Arbitri
Si analizza il procedimento di liquidazione dei compensi degli arbitri (art. 814, secondo comma c.p.c.), discutendo la sua natura (contenziosa o volontaria) e la possibilità di ricorso in Cassazione. Le Sezioni Unite del 2009 hanno contribuito a chiarire la natura contenziosa di questo procedimento, affermando che il provvedimento del Presidente del Tribunale ha efficacia di giudicato ed è impugnabile in Cassazione. L’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 814 c.p.c. è fondamentale per capire il regime di impugnazione.
1. La Determinazione del Compenso degli Arbitri Natura Contenziosa o Volontaria
La sezione si concentra sulla liquidazione dei compensi degli arbitri, analizzando la natura del procedimento previsto dall'art. 814, secondo comma, c.p.c. Si evidenzia il dibattito dottrinale e giurisprudenziale (precedente al 2009) sulla natura del procedimento, contrapponendo una tesi processualistica (procedimento contenzioso su diritti soggettivi con vocazione al giudicato) a una contrattualistica (intervento di giurisdizione volontaria per integrare la volontà delle parti). La giurisprudenza maggioritaria, prima dell'intervento delle Sezioni Unite del 2009, considerava l'attività del presidente del tribunale come contenziosa, con il relativo provvedimento dotato di efficacia di giudicato e quindi impugnabile in Cassazione. La peculiarità delle convenzioni d'arbitrato, spesso silenti sulla determinazione quantitativa del compenso, porta il legislatore a prevedere questo procedimento speciale. L'analisi approfondisce le diverse interpretazioni sulla natura del procedimento, evidenziando il conflitto tra le tesi processualistica e contrattualistica. La tesi processualistica sosteneva la natura contenziosa del procedimento, con la conseguente possibilità di ricorso in Cassazione, mentre la tesi contrattualistica lo considerava un intervento di giurisdizione volontaria. La prevalenza dell’indirizzo giurisprudenziale maggioritario, che lo qualificava come contenzioso, si basava sulla natura del provvedimento come atto che assume efficacia di giudicato. L’obiettivo è comprendere se la liquidazione del compenso riguardi l'accertamento di un diritto soggettivo di credito o la semplice determinazione del suo ammontare.
2. L Intervento delle Sezioni Unite Sentenza 15586 2009 e la Natura Contenziosa del Procedimento
La sezione analizza la sentenza delle Sezioni Unite 15586/2009, che ha avuto un impatto decisivo sulla questione della liquidazione dei compensi arbitrali. La Corte, individuando la finalità e la natura del procedimento ex art. 814, secondo comma, c.p.c., ha indagato se esso abbia ad oggetto l'accertamento di un diritto soggettivo di credito o la semplice determinazione del suo ammontare. Data la frequente mancanza di clausole specifiche nelle convenzioni d'arbitrato per la determinazione del compenso, il legislatore ha previsto questo meccanismo speciale, considerato una clausola implicita nel contratto d'arbitrato (art. 1339 c.c.) se non diversamente stabilito (artt. 1346 e 1349 c.c.). La sentenza delle Sezioni Unite evidenzia come alternative al procedimento speciale ci siano il procedimento monitorio o il processo ordinario, con i quali il procedimento ex art. 814 c.p.c. condivide natura e ampiezza. La Corte ha quindi affermato la natura contenziosa del procedimento, rifiutando l'interpretazione che lo considerava di volontaria giurisdizione. Questa conclusione si basa sul fatto che la determinazione del quantum in un procedimento ordinario non ne modifica la natura contenziosa, e che un procedimento avente come oggetto una somma non contestata è comunque contenzioso. Il confronto con la liquidazione di altre prestazioni professionali, e l’obbligatorietà della difesa tecnica, rafforza questa posizione. La sentenza delle Sezioni Unite ha quindi contribuito a chiarire la natura del procedimento di liquidazione dei compensi arbitrali, ponendo fine alle precedenti incertezze interpretative e consolidando la giurisprudenza in materia.
3. La Giurisprudenza Successiva e le Questioni Rimaste Aperte
La sezione esamina la giurisprudenza successiva alla sentenza delle Sezioni Unite 15586/2009, evidenziando come le pronunce si siano adeguate alle argomentazioni espresse dalla Corte, ma che non mancano comunque decisioni di segno contrario. Si evidenzia la difficoltà di un'uniformità di interpretazione, a fronte della complessità della materia. Il documento sottolinea come la questione della natura del procedimento (contenzioso o di volontaria giurisdizione) abbia influenzato anche le decisioni in materia di ricusazione dell’arbitro, con l’esclusione di un precedente criterio basato sulla “compenetrazione reciproca delle attività professionali” e la sua sostituzione con la previsione di specifici rapporti (consulenza, prestazione d’opera retribuita, altri rapporti patrimoniali) che compromettono l’indipendenza dell’arbitro (art. 51 c.p.c.). La disciplina delle spese del procedimento è analizzata, con particolare attenzione all'allocazione delle stesse in caso di accoglimento o rigetto dell'istanza, evidenziando la natura decisoria ma non definitiva dell'ordinanza sulle spese. Infine, la questione della ricorribilità in Cassazione dell'ordinanza che decide sull'istanza di ricusazione è nuovamente affrontata, con un'analisi delle tesi contrapposte in merito alla decisorietà e definitività del provvedimento, e un riferimento alla giurisprudenza di legittimità che predilige un approccio più cauto in merito all'ammissibilità del ricorso in Cassazione per tale tipo di provvedimento.
VII.Esecutorietà del Lodo Arbitrale
Infine, il documento tratta l'esecutorietà del lodo arbitrale (art. 824 bis e 825 c.p.c.), analizzando le modalità per ottenere l'efficacia esecutiva e le eventuali problematiche legate alla formazione progressiva della convenzione arbitrale. Il ruolo del procedimento monitorio e le questioni relative alla necessità del deposito dell’atto contenente la convenzione arbitrale sono discussi. La necessità di trovare un bilanciamento tra la funzione nomofilattica della Cassazione e l'eccesso di lavoro viene sottolineata.
1. L Esecutorietà del Lodo Il Ruolo dell Art. 824 bis e 825 c.p.c.
La sezione affronta il tema dell'esecutorietà del lodo arbitrale, analizzando il ruolo degli artt. 824 bis e 825 c.p.c. Si introduce il concetto di efficacia esecutiva del lodo, evidenziando che l'art. 825 c.p.c. rappresenta l'unico strumento normativo per conferirgli tale efficacia. Viene discussa l'ipotesi di un controllo pieno della Corte d'appello in sede di impugnazione per nullità, con la conseguente acquisizione dell'efficacia esecutiva con il solo rigetto dell'impugnazione. Tuttavia, si evidenzia che il procedimento d'impugnazione è a critica vincolata e non contempla la regolarità formale tra i vizi. Inoltre, un rigetto dell’impugnazione potrebbe andare contro gli interessi della parte che impugna. Si osserva come l'art. 824 bis sembri indicare il procedimento dell'art. 825 c.p.c. come l'unico possibile per ottenere l'efficacia esecutiva, con la Corte d'appello che, in questa ottica, risulterebbe priva di competenza. L'analisi si focalizza quindi sulla procedura prevista dall'ordinamento per rendere esecutivo il lodo arbitrale, evidenziando la centralità dell'art. 825 c.p.c. e le sue implicazioni in termini di controllo giurisdizionale e di garanzie per le parti. La sezione introduce le problematiche legate all'ottenimento dell'efficacia esecutiva del lodo, ponendo le basi per una successiva analisi più dettagliata delle procedure e delle possibili criticità.
2. Il Procedimento Monitorio e la Formazione Progressiva della Convenzione
La sezione esplora la possibilità di ricorrere a un procedimento monitorio per ottenere l'esecuzione di un lodo non ancora esecutivo, escludendo problemi se non legati a ragioni di economia processuale. Si sottolinea come questa via possa essere necessaria per evitare la vanificazione dei risultati conseguiti con il lodo, in particolare nel caso di formazione progressiva della convenzione arbitrale. La nuova disciplina, infatti, richiede il deposito dell'atto contenente la convenzione arbitrale per ottenere il decreto di esecutorietà, rendendo problematica l'ottenimento dell'omologazione in caso di formazione procedimentale del lodo. In quest'ultimo caso, mancherebbe un compromesso o una clausola compromissoria, anche se la forma scritta ad substantiam potrebbe non essere violata in virtù di uno scambio di memorie tra le parti. La mancanza dell'atto contenente la convenzione arbitrale preclude l'ottenimento dell'omologazione e quindi dell'efficacia esecutiva del lodo, una soluzione considerata inaccettabile. L’analisi si focalizza quindi sulle possibili soluzioni alternative per garantire l’esecuzione del lodo in situazioni particolari, come la formazione progressiva della convenzione, dove potrebbero mancare gli elementi formali tradizionali. Si evidenzia la necessità di conciliare l’esigenza di efficienza processuale con la tutela dei diritti delle parti.
3. Il Precedente Giurisprudenziale e l Effettività della Tutela Giurisdizionale
La sezione conclude l'analisi dell'esecutorietà del lodo con una riflessione sul ruolo del precedente giurisprudenziale e sull'effettività della tutela giurisdizionale. Si osserva come il richiamo al precedente, pur non essendo vincolante nel sistema italiano, venga spesso utilizzato dalla Corte di Cassazione, più come direttiva di tendenza che come regola vincolante, in un'ottica di decongestionamento del lavoro giudiziario. Si fa riferimento a una recente sentenza della Corte che, pur in presenza di elementi che potrebbero giustificare una decisione opposta, ha fatto leva sul precedente per rendere razionale la propria decisione, negando in questo modo tutela ai ricorrenti. Il documento sottolinea la tensione tra la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione e l'eccesso di lavoro, evidenziando come l'introduzione di nuovi filtri in Cassazione, se correttamente intesi, non dovrebbero porre problemi di costituzionalità. L'analisi si concentra sulla difficoltà di bilanciare diversi valori, come l'efficienza del sistema giudiziario, la tutela dei diritti e l'uniformità di interpretazione della legge, evidenziando come il richiamo all'effettività della tutela giurisdizionale spesso non sia sufficiente a sanare scelte legislative che mirano ad altri obiettivi. La necessità di trovare un equilibrio tra questi aspetti è, quindi, sottolineata, evidenziando la difficoltà di un’applicazione uniforme del diritto e la necessità di una tutela effettiva dei diritti delle parti.
