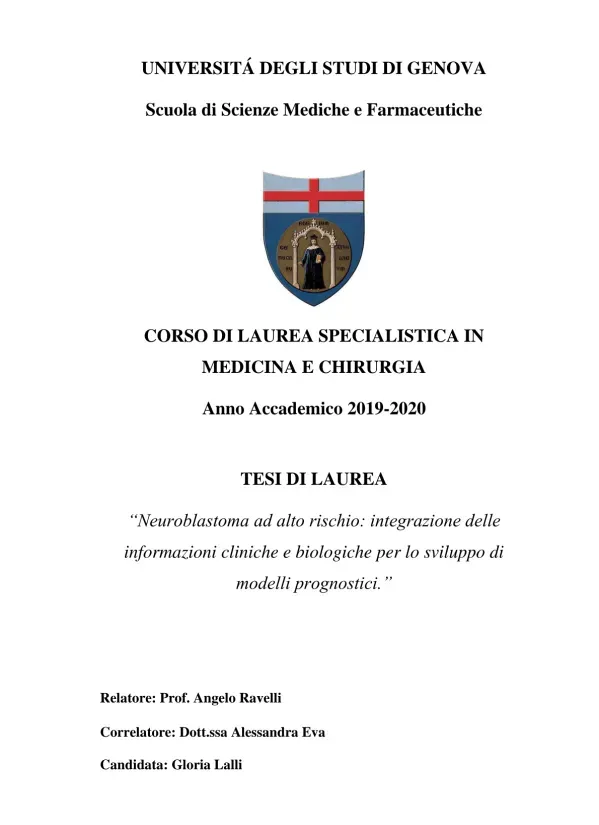
Neuroblastoma: Diagnosi e Terapia
Informazioni sul documento
| Scuola | Università Degli Studi Di Genova, Scuola Di Scienze Mediche E Farmaceutiche |
| Specialità | Medicina E Chirurgia |
| Anno di pubblicazione | 2020 |
| Tipo di documento | Tesi Di Laurea |
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 1.34 MB |
Riassunto
I.Incidenza e Fattori di Rischio del Neuroblastoma Pediatrico
Il neuroblastoma è un tumore pediatrico che colpisce prevalentemente bambini sotto i 5 anni, con un'età mediana alla diagnosi di 18 mesi. Circa il 90% dei casi si verifica prima dei 10 anni. Sebbene l'eziologia della maggior parte dei neuroblastomi rimanga sconosciuta, fattori prenatali come l'esposizione a fumo, alcol, pesticidi e farmaci materni sono stati ipotizzati come potenziali fattori predisponenti, sebbene con un'influenza minore rispetto alle neoplasie dell'adulto. L'assunzione di acido folico in gravidanza sembra invece avere un effetto protettivo. Una storia familiare di neuroblastoma periferico è presente in circa l'1% dei pazienti, suggerendo un ruolo della predisposizione genetica. Mutazioni germinali nei geni ALK e PHOX2B, coinvolti nello sviluppo della cresta neurale, sono associate a forme ereditarie, così come alcune sindromi genetiche come la sindrome di Turner, la malattia di Hirschsprung, la sindrome di Beckwith-Wiedemann e la neurofibromatosi di tipo 1. Le metastasi sono più comuni nei bambini sotto i 18 mesi, interessando frequentemente linfonodi, fegato e cute.
1. Incidenza del Neuroblastoma
Il neuroblastoma colpisce principalmente bambini di età inferiore ai 10 anni, con la maggior parte dei casi diagnosticati nel periodo perinatale o comunque prima dei 5 anni di età. L'età mediana alla diagnosi è di 18 mesi. È importante notare che il 90% dei casi si manifesta prima dei 10 anni di vita, mentre la forma della malattia negli adolescenti e nei giovani adulti è rara, rappresentando meno del 5% dei casi totali. Questa differenza di incidenza tra fasce d'età evidenzia la natura prevalentemente pediatrica di questo tumore. La maggiore incidenza nei maschi rispetto alle femmine rimane un aspetto da approfondire, in quanto le basi genetiche ed epigenetiche di questa preponderanza non sono ancora completamente comprese.
2. Fattori Ambientali e Predisposizione Genetica
L'eziologia del neuroblastoma rimane in gran parte sconosciuta, sebbene l'età precoce alla diagnosi suggerisca un ruolo potenziale di fattori prenatali. L'esposizione prenatale a sostanze chimiche come droghe, fumo, alcol, pesticidi, idrocarburi e farmaci assunti dalla madre potrebbe essere coinvolta nello sviluppo del tumore, ma con un impatto molto meno significativo rispetto a quanto osservato nelle neoplasie dell'adulto. In contrasto, l'assunzione di acido folico in gravidanza sembra offrire un effetto protettivo, probabilmente grazie al suo ruolo nello sviluppo neuronale. Per quanto riguarda la predisposizione genetica, circa l'1% dei pazienti presenta una storia familiare di neuroblastoma periferico, indicando un possibile componente ereditario nella patogenesi della malattia.
3. Mutazioni Genetiche e Sindromi Associate
Le forme ereditarie di neuroblastoma sono spesso associate a mutazioni germinali in geni specifici, in particolare ALK e PHOX2B. Questi geni svolgono un ruolo chiave nello sviluppo della cresta neurale, un tessuto embriologico fondamentale per la formazione del sistema nervoso simpatico. Inoltre, alcune sindromi genetiche che compromettono lo sviluppo della cresta neurale sono state associate ad un aumentato rischio di neuroblastoma. Tra queste si includono la sindrome di Turner, la malattia di Hirschsprung, la sindrome di Beckwith-Wiedemann e la neurofibromatosi di tipo 1. L'identificazione di queste mutazioni e sindromi fornisce informazioni cruciali per la comprensione dei meccanismi alla base del neuroblastoma ereditario e per la gestione delle famiglie a rischio. La presenza di queste mutazioni non implica necessariamente lo sviluppo del neuroblastoma, ma aumenta la probabilità di insorgenza della patologia.
4. Metastasi e Sindromi Paraneoplastiche
Sebbene meno frequente, il riscontro di metastasi a linfonodi, fegato e cute è più comune nei bambini di età inferiore ai 18 mesi. Il coinvolgimento di polmoni e sistema nervoso centrale all'esordio è estremamente raro. In casi rari, l'insorgenza del neuroblastoma può essere associata a sindromi paraneoplastiche. Queste comprendono l'iperproduzione di metaboliti catecolaminici, con conseguente ipertensione arteriosa e cefalea, o l'ipersecrezione di peptide intestinale vasoattivo, che porta a diarrea acquosa profusa. Queste manifestazioni cliniche, seppur poco frequenti (meno dell'1% dei casi per la diarrea), sottolineano la complessità del neuroblastoma e la necessità di un approccio diagnostico completo.
II.Diagnostica del Neuroblastoma
La diagnosi di neuroblastoma si basa su esami ematochimici, tra cui il dosaggio dei metaboliti urinari delle catecolamine (acido omovanillico, HVA e vanilmandelico, VMA), altamente sensibili e specifici. L'analisi istologica, secondo la classificazione INPC, è fondamentale per la stratificazione del rischio prognostico. Tecniche come l'array-CGH e la FISH vengono utilizzate per analizzare le mutazioni e le alterazioni genomiche, tra cui l'amplificazione di MYCN e la delezione 11q, importanti per la prognosi. Lo stadio 4S, caratterizzato da metastasi limitate in bambini sotto l'anno, presenta la possibilità di regressione spontanea.
1. Esami Ematochimici e Dosaggio dei Metaboliti Urinari
Oltre agli esami ematochimici di routine (emocromo, funzionalità epatica e renale, profilo coagulativo, LDH e ferritina), il dosaggio dei metaboliti urinari delle catecolamine (acido omovanillico, HVA e vanilmandelico, VMA) è fondamentale per la diagnosi di neuroblastoma. Questo test, eseguito sul campione di urina del mattino, presenta un'elevata sensibilità e specificità. Livelli significativamente aumentati di questi metaboliti si riscontrano in circa il 90% dei pazienti affetti da neuroblastoma, e le loro quantità relative sono correlate al grado di differenziazione delle cellule tumorali. Livelli elevati sono associati ad una prognosi meno favorevole. In casi rari, un aumento dei livelli di noradrenalina o adrenalina secreti dal tumore può causare ipertensione arteriosa.
2. Analisi Istologica e Classificazione INPC
L'analisi istologica del tumore, integrata con le caratteristiche genetico-molecolari, è essenziale per la stratificazione del rischio prognostico. La classificazione istologica universalmente riconosciuta è l'International Neuroblastoma Pathology Classification (INPC). Questa classificazione permette di identificare quattro categorie principali di tumori neuroblastici periferici (TNP) e, per alcune di queste, anche sottotipi, in base alle caratteristiche morfologiche delle cellule tumorali e del tessuto stromale. L'INPC rappresenta uno strumento fondamentale per la standardizzazione della diagnosi e per la scelta del trattamento più appropriato.
3. Analisi Genetica Array CGH e FISH
Per l'analisi delle mutazioni e delle alterazioni genomiche si utilizzano tecniche avanzate come l'array-based Comparative Genomic Hybridization (array-CGH) e la Fluorescence In Situ Hybridization (FISH). L'array-CGH permette un'analisi ad alta risoluzione dell'intero genoma, confrontando il DNA del paziente con quello di un individuo sano di controllo, consentendo di rilevare anomalie numeriche e strutturali dei cromosomi. La FISH, invece, è utilizzata per l'analisi di specifiche sequenze di DNA o geni. Entrambe le tecniche sono cruciali per l'identificazione di alterazioni genomiche che possono influenzare la prognosi e la scelta del trattamento, permettendo di personalizzare l'approccio terapeutico.
4. Stadiazione e Stadio 4S
Oltre ai classici stadi utilizzati a livello internazionale per la classificazione delle neoplasie maligne, il neuroblastoma presenta uno stadio particolare, lo stadio 4S. Questo stadio include pazienti di età inferiore a 1 anno con metastasi limitate alla cute, al fegato o al midollo osseo. La peculiarità dello stadio 4S è la possibilità di una regressione spontanea del tumore, un fenomeno i cui meccanismi non sono ancora completamente chiari. Molti di questi tumori regrediscono prima ancora di manifestare sintomatologia clinica, rendendo la diagnosi precoce particolarmente importante.
III.Trattamento e Prognosi del Neuroblastoma
Il trattamento del neuroblastoma varia in base al rischio: i casi a basso rischio possono essere gestiti con osservazione o interventi minimi, mentre quelli ad alto rischio richiedono chemioterapia, eventualmente con acido cis-retinoico per migliorare la sopravvivenza libera da eventi, chirurgia, e immunoterapia. L'immunoterapia, sebbene efficace, può causare effetti avversi come dolore neuropatico, febbre e neutropenia. La Sindrome Opsoclono Mioclono (OMS), associata al neuroblastoma, richiede un trattamento immunosoppressivo. I controlli post-trattamento sono più frequenti nei primi due anni a causa del maggior rischio di recidiva.
1. Trattamento in base al rischio
L'approccio terapeutico al neuroblastoma varia significativamente in base alla stratificazione del rischio. I pazienti con malattia a basso rischio presentano eccellenti tassi di sopravvivenza con una semplice osservazione o con interventi terapeutici limitati. Per i pazienti con malattia a rischio intermedio, il trattamento principale prevede chirurgia e chemioterapia, con un tasso di sopravvivenza migliorato negli ultimi anni. In alcuni casi, l'utilizzo di marcatori biologici consente di ridurre ulteriormente l'intensità della terapia in specifici gruppi di bambini. Nei casi ad alto rischio, invece, si ricorre a terapie più aggressive e multimodali.
2. Chemioterapia e Terapia di Differenziazione
La chemioterapia mieloablativa, spesso seguita da trapianto di cellule staminali emopoietiche (TCSEa), è un pilastro del trattamento del neuroblastoma ad alto rischio. Nonostante l'efficacia, circa il 50% dei pazienti presenta una recidiva mesi o anni dopo il trapianto. Per questo motivo, l'aggiunta di acido cis-retinoico, un farmaco somministrato per via orale, ha dimostrato un miglioramento della sopravvivenza libera da eventi (event-free survival). L'acido cis-retinoico riduce la proliferazione cellulare e induce la differenziazione delle cellule del neuroblastoma, contribuendo a migliorare l'outcome terapeutico.
3. Immunoterapia ed Effetti Avversi
L'immunoterapia rappresenta un'opzione terapeutica importante nel neuroblastoma ad alto rischio. Tuttavia, è spesso associata a diversi effetti avversi, tra cui dolore neuropatico, febbre, diarrea, neutropenia, reazioni cutanee e allergiche, e tossicità epatica. La somministrazione contemporanea di IL-2 può essere mal tollerata in alcuni pazienti, richiedendo l'interruzione del trattamento in base alla gravità degli effetti collaterali. La gestione degli effetti avversi è quindi un aspetto cruciale nella terapia immunologica del neuroblastoma.
4. Altre opzioni terapeutiche e gestione della recidiva
Oltre alla chemioterapia e all'immunoterapia, le opzioni terapeutiche per il neuroblastoma includono il trattamento sintomatico con corticosteroidi ad alte dosi, interventi neurochirurgici (laminectomia o laminotomia) e la gestione della Sindrome Opsoclono Mioclono (OMS), una sindrome autoimmune debilitante che richiede un trattamento immunosoppressivo con farmaci come corticotropina, steroidi ad alte dosi, ciclofosfamide, γ-globulina endovenosa, Rituximab, micofenolato o, nei casi più gravi, plasmaferesi. Ogni segno o sintomo indicativo di recidiva deve essere valutato con visita medica, dosaggio delle catecolamine urinarie, esami ematochimici, e uno staging completo con TC/RM, scintigrafia 123I-mIBG e valutazione osteomidollare. I controlli sono più ravvicinati nei primi due anni post-terapia, periodo a più alto rischio di recidiva.
IV.Patogenesi Molecolare e Biomarcatori
Il neuroblastoma origina dalle cellule della cresta neurale durante l'embriogenesi. L'ipossia nel microambiente tumorale gioca un ruolo chiave nella proliferazione e nella metastatizzazione. Studi recenti hanno evidenziato l'importanza degli RNA non codificanti, come i microRNA (miRNA), nella regolazione dello sviluppo e della differenziazione della cresta neurale. Alterazioni nei miRNA, come miR-17-92 e miR-21, sono implicati nella tumorigenesi e nella progressione della malattia. LIN28B, sovraespresso nel neuroblastoma ad alto rischio, inibisce l'azione oncosoppressiva dei miRNA let-7, promuovendo l'espressione di MYCN. L'analisi del profilo di espressione dei miRNA esosomiali, ottenuta tramite biopsie liquide, potrebbe aiutare a predire la risposta alla chemioterapia. L'amplificazione di MYCN e la delezione 11q sono fattori prognostici negativi, spesso escludendosi a vicenda. La ricerca di nuovi biomarcatori, rilevabili con metodi minimamente invasivi, è fondamentale per una diagnosi precoce e una terapia mirata.
1. Origine e Ruolo dell Ipossia
Il neuroblastoma, un tumore del periodo evolutivo, origina dal sistema nervoso simpatico periferico, a livello dei gangli simpatici o della midollare del surrene. Durante l'embriogenesi, cellule della cresta neurale migrano verso l'aorta dorsale, differenziandosi in cellule progenitrici del sistema nervoso simpatico. L'ipossia, ovvero una bassa concentrazione di ossigeno, sembra svolgere un ruolo significativo nello sviluppo del tumore, influenzando la differenziazione, la sopravvivenza e la diffusione metastatica delle cellule tumorali. La condizione ipossica del microambiente tumorale altera la regolazione di diversi processi cellulari, aumentando l'aggressività del tumore e la resistenza alla terapia. La giovane età di insorgenza del neuroblastoma, spesso con storia familiare e presenza di siti primari multipli (es. neuroblastoma surrenale bilaterale), suggerisce una complessa interazione tra fattori genetici e ambientali, sebbene quest'ultimi non sembrino avere un ruolo determinante.
2. Ruolo degli RNA non codificanti e dei microRNA
Studi recenti hanno evidenziato il ruolo degli RNA non codificanti, come i microRNA (miRNA), i long non-coding RNA (lncRNA) e i Piwi-interacting RNA (piRNA), nella regolazione trascrizionale delle cellule staminali e nello sviluppo della cresta neurale. Molti miRNA sono alterati nei neuroblastomi aggressivi, inibendo l'attività di p53 e promuovendo la migrazione delle cellule tumorali, contribuendo alla formazione di metastasi. Tra i miRNA meglio studiati con specificità per il neuroblastoma ci sono miR-17-92 e miR-21, direttamente coinvolti nella tumorigenesi, nello sviluppo di metastasi e nella regolazione della differenziazione cellulare. Il profilo di espressione dei miRNA negli esosomi del plasma potrebbe rappresentare un valido strumento diagnostico e prognostico.
3. Alterazioni genetiche e Biomarcatori ALK PHOX2B MYCN e LIN28B
Mutazioni germinali nei geni ALK e PHOX2B sono associate a forme ereditarie di neuroblastoma. ALK, un oncogene, è mutato anche in alcuni tumori dell'adulto. Le mutazioni a carico di ALK sono state le prime mutazioni oncogeniche a causare un tumore pediatrico familiare. L'amplificazione di MYCN, riscontrata in circa il 20% dei tumori, è associata a perdita cromosomica segmentale del braccio corto distale del cromosoma 1 (1p) e a scarsa sopravvivenza. LIN28B, spesso sovraespresso nel neuroblastoma ad alto rischio, modula i microRNA della famiglia let-7, influenzando l'espressione di MYCN e la differenziazione cellulare. Un'elevata espressione di LIN28B è un fattore di rischio indipendente per esiti avversi. Questi geni e i loro prodotti rappresentano potenziali biomarcatori per la stratificazione del rischio e per la personalizzazione del trattamento.
4. Biopsie liquide miRNA esosomiali e prospettive future
L'analisi del profilo di espressione dei miRNA negli esosomi del plasma di bambini con neuroblastoma ad alto rischio potrebbe discriminare tra pazienti con buona o cattiva risposta alla chemioterapia d'induzione, aprendo nuove prospettive diagnostiche. Tecniche come l'array-CGH consentono di analizzare l'intero genoma del tumore, identificando anomalie genomiche e aberrazioni che causano malattie genetiche o alterazioni nelle cellule tumorali. Una diagnosi precoce, supportata da biomarcatori sensibili e specifici rilevabili con metodi minimamente invasivi, è fondamentale per indirizzare i pazienti pediatrici al trattamento più idoneo. L'individuazione di profili genetici di rischio individuali permette una migliore comprensione della patologia e un approccio terapeutico più mirato.
V.Studio sui MicroRNA e Aberrazioni Cromosomiche
Uno studio ha analizzato i profili di espressione dei miRNA esosomiali e le aberrazioni cromosomiche in pazienti con neuroblastoma ad alto rischio, utilizzando tecniche come l'array-CGH per identificare biomarcatori predittivi dell'outcome e della risposta alla terapia. L'analisi ha coinvolto specificamente bambini con tumori in stadio 4 e stadio 3 con amplificazione di MYCN, selezionando solo campioni con elevata cellularità tumorale per l'estrazione di DNA e miRNA. Il sistema XTENS 2 è stato utilizzato per analizzare e gestire i dati eterogenei, consentendo interrogazioni complesse. L'analisi ha evidenziato l'importanza di miRNA come miR-106b e miR-146b, e la correlazione con alterazioni cromosomiche, in particolare a livello del cromosoma 8 e 11, nella predizione della recidiva.
1. Obiettivi dello Studio e Selezione dei Pazienti
Lo studio si propone di identificare biomarcatori predittivi dell'andamento clinico dei pazienti affetti da neuroblastoma ad alto rischio e della loro risposta alla terapia. L'analisi si concentra sui profili di espressione dei microRNA (miRNA), ottenuti da biopsie liquide, in relazione alle alterazioni cromosomiche delle cellule tumorali. Sono stati selezionati pazienti pediatrici con tumori in stadio 4 e stadio 3 con amplificazione di MYCN. Per garantire la qualità dell'analisi array-CGH, sono stati inclusi solo i pazienti con materiale bioptico idoneo all'esordio della malattia (cellularità tumorale ≥ 60%), da cui è stato estratto DNA di qualità adeguata. Per gli stessi pazienti, sono stati utilizzati prelievi di sangue per l'estrazione dei miRNA esosomiali, sia prima che dopo la chemioterapia. Questo approccio multi-modalità mira a ottenere una comprensione più completa dei meccanismi molecolari alla base del neuroblastoma.
2. Metodi di Estrazione e Analisi dei MicroRNA Esosomiali
I miRNA esosomiali sono stati isolati dal sangue utilizzando l'exoRNeasy Siero/Plasma Midi Kit (QIAGEN). Il processo prevede la centrifugazione del plasma per rimuovere i detriti cellulari, la miscelazione del surnatante con un tampone per il legame delle microvescicole su un filtro, il lavaggio e l'aggiunta di un reagente di lisi per l'eluizione del contenuto degli esosomi. Successivamente, viene effettuata la purificazione dei miRNA. La qualità e la quantità del materiale estratto sono state determinate con lo strumento Agilent Bioanalyzer 2100 (Agilent Technologies). Questa metodologia garantisce l'estrazione di miRNA di alta qualità per le successive analisi, fondamentali per la comprensione del ruolo dei miRNA nella progressione del neuroblastoma.
3. Analisi dei Dati e Piattaforma XTENS 2
Per l'analisi dei dati, è stata utilizzata la piattaforma web XTENS 2, sviluppata in collaborazione tra l'Istituto Giannina Gaslini e il Dipartimento DIBRIS dell'Università di Genova. Questa piattaforma consente di strutturare, integrare, interrogare e condividere dati eterogenei in campo biomedicale. L'interfaccia grafica intuitiva permette di effettuare interrogazioni su singoli dati o su caratteristiche di più dati in parallelo. Nel contesto di questo studio, XTENS 2 è stata impiegata per l'analisi integrata dei profili di espressione dei miRNA esosomiali e delle aberrazioni cromosomiche, identificate mediante CGH. L'analisi dei dati è stata condotta utilizzando un approccio basato sugli alberi decisionali, facilitando l'estrazione di regole di classificazione esplicite e la loro traduzione in applicazioni cliniche.
4. Risultati preliminari e implicazioni cliniche
L'analisi ha individuato alcune correlazioni tra l'espressione di specifici miRNA e lo stato di alcuni cromosomi, in relazione all'outcome dei pazienti. Ad esempio, un livello di espressione di miR-106 superiore a 0,491, in assenza di alterazioni al cromosoma 8, è associato a sopravvivenza. Al contrario, alterazioni al cromosoma 8 (principalmente delezioni) modificano la prognosi in base al livello di espressione di miR-146b. Analogamente, l'espressione di miRNA-155 influenza la probabilità di recidiva in relazione alle alterazioni del cromosoma 11. Questi risultati preliminari suggeriscono che i miRNA e le aberrazioni cromosomiche potrebbero rappresentare biomarcatori utili per la predizione dell'andamento clinico dei pazienti e della risposta alla terapia. Sono necessari ulteriori studi per validare questi risultati e per approfondire il ruolo di questi biomarcatori nella pratica clinica.
