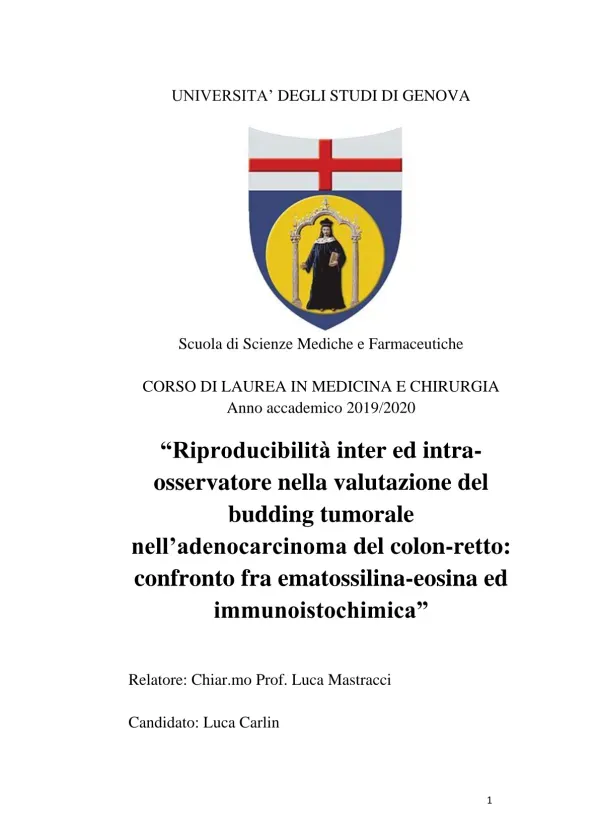
Budding tumorale: Riproducibilità in CCR
Informazioni sul documento
| Scuola | Università degli Studi di Genova, Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche |
| Specialità | Medicina e Chirurgia |
| Anno di pubblicazione | 2019/2020 |
| city | Genova |
| Tipo di documento | Tesi di Laurea |
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 1.51 MB |
Riassunto
I.Fattori di Rischio del Carcinoma Colorettale
Il carcinoma colorettale (CCR) è un importante problema di salute pubblica. Tra i principali fattori di rischio legati allo stile di vita si annoverano il consumo di carni rosse lavorate, ricche di sostanze cancerogene come ammine eterocicliche e idrocarburi policiclici aromatici, e una dieta ipercalorica che favorisce la crescita tumorale. Anche il consumo di latticini è oggetto di studio, con ipotesi su meccanismi di protezione o di promozione del CCR a seconda delle modalità di assunzione. La maggior parte dei CCR sono sporadici, mentre una parte significativa è familiare o ereditaria, legata a specifiche anomalie genetiche come quelle associate alle sindromi HNPCC, FAP, e altre.
1. Fattori Dietetici e Stili di Vita
Il documento evidenzia il ruolo significativo dei fattori dietetici e dello stile di vita nello sviluppo del carcinoma colorettale (CCR). In particolare, si sottolinea l'associazione tra il consumo di carni rosse lavorate e un aumentato rischio di CCR. Questi prodotti contengono diverse sostanze cancerogene, tra cui ammine eterocicliche, idrocarburi policiclici aromatici e N-nitrosammine, che espongono il tratto gastrointestinale a un maggiore rischio. Un'altra area di attenzione è rappresentata dalle diete ipercaloriche, che influenzano negativamente l'omeostasi del corpo e incrementano i livelli circolanti di macronutrienti e fattori di crescita (glucosio, acidi grassi liberi, insulina e IGF1). Questi fattori promuovono la crescita tumorale attraverso meccanismi che includono l'aumento della proliferazione cellulare, l'inibizione dell'apoptosi, l'attivazione dei recettori PPAR, l'induzione dello stress ossidativo e uno stato infiammatorio cronico. L'effetto del consumo di latticini è più complesso e ancora oggetto di studio, ma vengono presentate ipotesi che coinvolgono il legame del calcio con acidi grassi e acidi biliari secondari, e l'interazione del calcio con vie di segnalazione intracellulari, portando a differenti effetti su cellule normali e tumorali.
2. Fattori Genetici e Familiari
Un'ampia parte del documento si concentra sui fattori genetici e familiari associati al CCR. Si evidenzia che la maggior parte dei casi di carcinoma colorettale (circa il 60-70%) sono sporadici, ovvero non presentano una chiara predisposizione genetica. Questi casi si verificano generalmente in pazienti di età superiore ai 50 anni, senza storia familiare di CCR precoce. Tuttavia, una percentuale significativa (25-30%) dei CCR sono familiari, sviluppandosi in contesti con storia familiare di CCR precoce o con più parenti di primo grado affetti. In queste situazioni, si ipotizza la trasmissione di geni predisponenti, combinata con la condivisione di fattori ambientali. Infine, una piccola frazione (2-5%) dei casi è definita ereditaria, associata a specifiche anomalie genetiche responsabili di sindromi come HNPCC (sindrome di Lynch), FAP (poliposi adenomatosa familiare), AFAP, APCI 1307K, sindrome di Peutz-Jeghers, MAP (poliposi associata a MYH), poliposi giovanile e poliposi ereditaria. La comprensione di queste basi genetiche è cruciale, poiché molti geni coinvolti nelle forme ereditarie sono implicati anche nelle forme sporadiche della malattia.
II.Patogenesi Molecolare del Carcinoma Colorettale Vie di Segnalazione e Alterazioni Genetiche
La patogenesi del CCR coinvolge una complessa interazione di eventi molecolari, spesso studiati attraverso l'analisi dei geni coinvolti nelle forme ereditarie. L'attivazione della via di segnalazione Wingless/Wnt, frequentemente a causa di mutazioni del gene APC, e della via MAPK, spesso a causa di mutazioni di KRAS, sono cruciali. Mutazioni del gene CTNNB1 (β-catenina) rappresentano un'altra via di attivazione della via Wnt. La perdita di eterozigosi in geni oncosoppressori, come DCC e TP53 (il “guardiano del genoma”), contribuisce alla progressione tumorale. L’instabilità dei microsatelliti (MSI), spesso legata a mutazioni nei geni del sistema MMR (MLH1, MSH2, MSH6), è responsabile di una parte dei CCR sporadici e di quelli in pazienti con HNPCC. Infine, il CIMP (CpG island methylator phenotype) rappresenta un’ulteriore alterazione epigenetica significativa nel CCR.
1. Attivazione delle Vie di Segnalazione Wnt β catenina e MAPK
La patogenesi molecolare del carcinoma colorettale (CCR) è un processo complesso che coinvolge alterazioni genetiche ed epigenetiche. Un punto focale è l'attivazione di specifiche vie di segnalazione. La via Wingless/Wnt gioca un ruolo chiave, spesso attivata da mutazioni nel gene APC, presente in circa il 70% dei CCR. La proteina APC, normalmente coinvolta nella degradazione della β-catenina, perde questa funzione quando mutata, causando un accumulo di β-catenina nel nucleo e l'attivazione di oncogeni come c-Myc, ciclina D1, c-Jun, e Fra-1. Un'altra via cruciale è quella MAPK (Mitogen-Activated Protein Kinase), coinvolta nei processi di differenziazione e proliferazione cellulare. Le mutazioni nel gene KRAS, che codifica per una GTPasi della famiglia Ras, sono presenti in circa il 50% dei CCR, principalmente nei codoni 12, 13 e 61. Queste mutazioni rendono KRAS costitutivamente attiva, portando all'attivazione di una cascata di chinasi e alla conseguente attivazione di fattori di trascrizione. È importante notare che mutazioni gain-of-function nel gene della β-catenina (CTNNB1) possono attivare la via Wnt anche in assenza di mutazioni APC, rappresentando un ulteriore meccanismo di patogenesi.
2. Perdita di Eterozigosità e Ruolo degli Oncosoppressori
Un ulteriore meccanismo importante nella patogenesi del CCR è la perdita di eterozigosi (LOH). Questo evento, caratterizzato da ampie delezioni di segmenti cromosomici che portano alla perdita di un allele in geni chiave, svolge un ruolo primario nella promozione della carcinogenesi. La LOH rende sufficiente una singola ulteriore alterazione genetica o epigenetica per sopprimere l'espressione di geni oncosoppressori. Il documento cita diversi loci cromosomici frequentemente colpiti da LOH, tra cui il cromosoma 18q, dove si trova il gene DCC (Deleted in Colorectal Carcinoma). DCC, codificante per un recettore transmembrana, se mutato, promuove la sopravvivenza cellulare e la progressione tumorale. Altri geni coinvolti nella LOH includono SMAD2 e SMAD4 (via di segnalazione TGF-β), APC (cromosoma 5q), e TP53 (cromosoma 17p). La mutazione di TP53, un oncosoppressore codificante per la proteina p53 (“guardiano del genoma”), è determinante per l'acquisizione di un fenotipo invasivo ed è riscontrata con alta frequenza nei carcinomi. P53 regola processi cruciali come la riparazione del DNA, l'arresto del ciclo cellulare e l'apoptosi.
3. Instabilità dei Microsatelliti MSI e CIMP
L'instabilità dei microsatelliti (MSI) è un'altra importante caratteristica del CCR, responsabile di circa il 15% dei carcinomi sporadici e dell'insorgenza di CCR nella HNPCC. La MSI è un tipo di instabilità genomica caratterizzata da un maggior tasso di mutazioni durante la replicazione del DNA, causato dal silenziamento dell'espressione di geni del sistema MMR (Mismatch Repair), come MLH1, MSH2, e MSH6. Questi geni sono essenziali per la correzione di errori di replicazione del DNA. L'ipermetilazione del promotore di MLH1 è osservata in oltre l'80% dei carcinomi MSI sporadici, suggerendo un ruolo chiave di questo evento epigenetico nella patogenesi. Il documento menziona anche il CIMP (CpG island methylator phenotype), un altro importante evento epigenetico. Diversi geni sono stati identificati come bersagli del CIMP, molti dei quali con significato funzionale ancora non del tutto chiaro. Il fenotipo CIMP è spesso associato alla MSI, con mutazioni frequenti di MLH1 e BRAF nel caso di MSI-H, mentre mutazioni di KRAS sono più comuni nel CIMP MSS. Sia i carcinomi MSI che quelli CIMP condividono alcune caratteristiche clinico-patologiche, come la localizzazione prossimale e l'istologia mucinosa.
III.Istopatologia e Stadiazione del Carcinoma Colorettale
La maggior parte dei CCR sono adenocarcinomi. L'invasione della sottomucosa definisce il CCR invasivo, a differenza di altri carcinomi del tratto digerente. La stadiazione TNM, basata sull'estensione del tumore (T), sui linfonodi (N) e sulle metastasi (M), è fondamentale per la prognosi. La localizzazione del tumore (colon destro o sinistro, retto) influenza la presentazione clinica. Si utilizzano test di screening come il test del sangue occulto nelle feci per la diagnosi precoce.
1. Aspetti Istologici del Carcinoma Colorettale
La maggior parte dei carcinomi colorettali (CCR) sono adenocarcinomi, caratterizzati dalla presenza di strutture ghiandolari formate da cellule cilindriche alte, simili a quelle degli adenomi. Questi tumori inducono una intensa reazione desmoplastica stromale e spesso mostrano materiale necrotico nel lume ghiandolare. Il grado degli adenocarcinomi, secondo la classificazione WHO del 2010, si basa sulla percentuale di volume neoplastico occupato da formazioni ghiandolari. Un carcinoma colorettale è definito invasivo quando infiltra la tonaca sottomucosa, caratteristica che lo distingue da altri carcinomi del tratto digerente, dove l'invasività è definita dall'infiltrazione della lamina propria. Questa differenza è dovuta all'assenza di vasi linfatici nella tonaca mucosa del colon e del retto. I carcinomi intramucosi (infiltranti solo la lamina propria o la muscolaris mucosae) hanno scarso o nullo potenziale metastatico. La localizzazione del tumore influenza notevolmente la presentazione clinica. Le neoplasie del colon prossimale tendono ad essere più insidiose, manifestandosi con anemia da stillicidio ematico cronico, calo ponderale e masse palpabili. Le neoplasie del colon distale, invece, possono presentare sintomi più evidenti come alterazioni dell'alvo e sanguinamento (che può essere cronico e occulto, o più grave).
2. Stadiazione TNM e Metodi di Diagnosi
La stadiazione del carcinoma colorettale si basa sul sistema TNM, che valuta l'estensione del tumore primitivo (T), l'interessamento dei linfonodi (N) e la presenza di metastasi a distanza (M). L'escissione chirurgica di almeno 12 linfonodi è fondamentale per una corretta stadiazione, con un maggior numero di linfonodi esaminati correlato a una migliore prognosi. Il documento descrive le diverse categorie di stadiazione, ad esempio lo stadio II (T3/4, N0, M0), suddiviso ulteriormente in sottostadi (IIA, IIB, IIC). Per quanto riguarda la diagnosi, il documento menziona l'utilizzo di test per il sangue occulto nelle feci come strumento di screening. La positività a questi test indica la necessità di una colonscopia, che può essere utilizzata come indagine di primo livello, con cadenza decennale nella popolazione generale, oppure più frequentemente in pazienti a rischio (familiari di primo grado affetti da polipi o carcinomi, pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali o sindromi genetiche associate al CCR).
3. Trattamento e Fattori Prognostici
Il trattamento del carcinoma colorettale si basa principalmente sulla chirurgia, che può essere impiegata, seppur raramente, anche per il trattamento di metastasi epatiche (con ablazione, embolizzazione o chemio-infusione arteriosa epatica). La chirurgia è anche indicata per il trattamento di ostruzioni coliche (colectomia parziale o colostomia). In alternativa alle resezioni chirurgiche, si possono utilizzare stent posizionati endoscopicamente. La chemioterapia adiuvante può essere somministrata dopo la chirurgia in presenza di fattori di rischio di recidiva (ostruzione, perforazione, coinvolgimento peritoneale, alto grado istologico, invasione linfovascolare, istologia mucinosa, linfoadenectomia insufficiente, margini di resezione positivi). La radioterapia trova applicazione principalmente con intenti palliativi, soprattutto nelle recidive di carcinomi rettali. La prognosi del CCR è strettamente legata alla stadiazione TNM, ma altri fattori prognostici sono oggetto di studio, in quanto la prognosi e la risposta alla terapia possono variare anche tra pazienti con lo stesso stadio.
IV.Budding e Poorly Differentiated Clusters PDC come Fattori Prognostici
Il budding, ovvero il distacco di singole cellule o piccoli cluster di cellule tumorali nello stroma, e i Poorly Differentiated Clusters (PDC), cluster di cellule scarsamente differenziate, sono importanti fattori prognostici nel CCR. Sono associati a un aumentato rischio di metastasi e a prognosi peggiore. Diversi metodi di valutazione del budding, tra cui il conteggio di bud per campo ad alto potere (HPF) e sistemi di grading più complessi, sono in uso, ma la riproducibilità inter- e intra-osservatore rimane una sfida. L'uso dell'immunoistochimica, ad esempio con anticorpi anti-citocheratina CAM5.2, è oggetto di studio per migliorare l'accuratezza della valutazione.
1. Definizione di Budding e Poorly Differentiated Clusters PDC
Il budding è definito come il distacco di singole cellule o piccoli gruppi (cluster) di cellule tumorali, fino a 4 cellule, nello stroma al fronte invasivo di un carcinoma. Questa definizione, pur avendo subito variazioni nel tempo (in passato si consideravano cluster fino a 5 cellule), è stata recentemente rifinita con l'introduzione del concetto di Poorly Differentiated Clusters (PDC). I PDC sono cluster composti da almeno 5 cellule, senza un'evidente differenziazione ghiandolare. La distinzione tra budding e PDC è importante per la classificazione istopatologica, sebbene il valore prognostico del budding non sia significativamente influenzato dal numero di cellule nel cluster. L'ipotesi attuale è che budding e PDC rappresentino fasi sequenziali della crescita e della disseminazione tumorale, supportata dalla loro frequente compresenza, dalla similarità morfologica, dalla localizzazione sul fronte invasivo e dalla condivisione di fattori morfogenetici associati alla transizione epitelio-mesenchimale (come l'attivazione della via WNT/β-catenina, l'espressione di metalloproteinasi e L1CAM, e la ridotta espressione di E-caderine). I PDC rappresenterebbero quindi un'evoluzione dei bud.
2. Valore Prognostico e Metodi di Valutazione del Budding
Il budding è un fattore prognostico noto da decenni, ma la sua valutazione e il suo utilizzo nella pratica clinica non sono ancora universalmente diffusi. Nonostante il sistema TNM rimanga lo standard nella stratificazione prognostica dei pazienti, l'implementazione routinaria della valutazione del budding e dei PDC potrebbe migliorare la precisione della stratificazione del rischio. La descrizione del budding nella letteratura risale al 1954, ma è con Gabbert et al. (1985) e le successive pubblicazioni di Yokoyama, Hayashida e Morodomi che se ne evidenzia l'importanza come fattore prognostico, soprattutto in relazione alla disseminazione linfonodale. Sono stati proposti diversi metodi di valutazione, inizialmente basati su un'impressione soggettiva (nessuno, lieve, moderato, severo), con conseguente scarsa riproducibilità inter- e intra-osservatore. Metodi più recenti, come il sistema dei 10 HPF (High-Power Fields) proposto da Karamitopoulou et al. nel 2013, prevedono il conteggio dei bud in aree selezionate ad alto ingrandimento (x40) dopo colorazione per pan-citocheratina. La scelta del metodo di valutazione e l'utilizzo dell'immunoistochimica sono ancora oggetto di dibattito.
3. Ruolo dell Immunoistochimica nella Valutazione del Budding
L'utilizzo dell'immunoistochimica nella valutazione del budding è un aspetto controverso. Alcuni autori ne limitano l'uso ai casi più difficili da valutare per motivi di costo-efficacia, mentre altri ritengono che possa migliorare l'accuratezza del conteggio se utilizzata abitualmente. Uno studio citato nel documento ha valutato la riproducibilità inter ed intra-osservatore del conteggio del budding con due diverse colorazioni: ematossilina-eosina e anticorpi anti-citocheratina CAM5.2. I risultati suggeriscono che, con un'ottimale definizione del cut-off, l'immunoistochimica potrebbe diventare una pratica standard. L'ematossilina-eosina, infatti, può presentare difficoltà nell'identificazione dei bud, soprattutto quelli costituiti da una singola cellula, e la presenza di infiltrato infiammatorio o altri tipi cellulari può interferire con la valutazione. L'immunoistochimica facilita anche l'identificazione dell'hotspot, l'area del vetrino con la maggiore densità di budding, riducendo la variabilità inter-osservatore legata all'identificazione di questa zona. Ulteriori studi sono necessari per definire un nuovo cut-off ottimale per il budding valutato in immunoistochimica e per standardizzare ulteriormente il metodo di valutazione.
V.Studio sulla Riproducibilità della Valutazione del Budding
Uno studio condotto presso l'Ospedale Policlinico IRCCS San Martino (100 pazienti, periodo 2005-2012) ha analizzato la riproducibilità inter ed intra-osservatore nella valutazione del budding con ematossilina-eosina e immunoistochimica (anticorpi anti-citocheratina CAM5.2). Lo studio ha evidenziato la necessità di definire un cut-off ottimale per il grading del budding in immunoistochimica per migliorare la riproducibilità e il valore prognostico. Il grading CIF si è dimostrato un fattore prognostico indipendente di recidiva di malattia.
1. Obiettivo e Metodologia dello Studio
Lo studio, condotto presso l'Ospedale Policlinico IRCCS San Martino tra il 4 agosto 2005 e il 16 maggio 2012, si proponeva di valutare la riproducibilità inter ed intra-osservatore nella valutazione del budding nel carcinoma del colon-retto, utilizzando due diverse tecniche di colorazione: ematossilina-eosina e immunoistochimica con anticorpi anti-citocheratina CAM5.2. Sono stati selezionati 100 pazienti, suddivisi equamente in stadio II (50 pazienti, tutti IIA) e stadio III (50 pazienti, 41 IIIA e 9 IIIC), con 25 pazienti per ogni stadio con tumore localizzato a destra e 25 a sinistra. Sono stati esclusi istotipi mucinosi, ad anello con castone, midollare e micropapillare per la maggiore difficoltà nel riconoscimento dei bud. Nessun paziente aveva ricevuto terapia neo-adiuvante. Per la valutazione dei Poorly Differentiated Clusters (PDC) è stato utilizzato il metodo di Ueno, contando i PDC ad ingrandimento x20 dopo identificazione dell’hotspot a basso ingrandimento. Il grading dei PDC è stato assegnato in base al numero di PDC (<5, 5-9, ≥10). Questa valutazione, insieme al grading tradizionale del budding, è stata effettuata da un solo osservatore (LM).
2. Risultati e Discussione sulla Riproducibilità
Lo studio ha analizzato la riproducibilità del conteggio e del grading del budding con le due tecniche di colorazione. La discrepanza tra i coefficienti di Spearman ottenuti nel conteggio e nel grading dei bud suggerisce la necessità di identificare un nuovo cut-off per il budding valutato in immunoistochimica. Sebbene si sia osservata una maggiore concordanza inter-osservatore nel conteggio, l'utilizzo del cut-off standard per l'ematossilina-eosina ha probabilmente portato a una sovrastima del grading in immunoistochimica, influenzando la riproducibilità e il valore prognostico. La riproducibilità intra-osservatore è risultata moderata in 2 osservatori su 3, suggerendo che l'innalzamento del cut-off potrebbe migliorare la concordanza nella refertazione. Diversi studi e metanalisi suggeriscono che il valore prognostico delle due colorazioni sia equivalente. L'utilizzo dell'ematossilina-eosina presenta difficoltà nell'identificazione dei bud composti da una singola cellula e può essere influenzato dalla presenza di infiltrato infiammatorio o altri tipi cellulari. L'immunoistochimica semplifica l'identificazione dell'hotspot, migliorando l'accuratezza della valutazione.
3. Conclusioni e Implicazioni Cliniche
Lo studio suggerisce che, con un'ulteriore ottimizzazione del cut-off, l'immunoistochimica potrebbe essere implementata nella valutazione routinaria del budding nei carcinomi del colon-retto. Il grading CIF si è dimostrato un fattore prognostico indipendente di recidiva di malattia, con risultati migliori rispetto al grading tradizionale e ad altri sistemi di valutazione del fronte invasivo. L'immunoistochimica, facilitando l'identificazione dell'hotspot, potrebbe ridurre la variabilità inter-osservatore legata a questa fase della valutazione. Un'ipotesi per futuri studi è quella di definire l'hotspot su un vetrino colorato con anticorpi anti-citocheratina, per poi effettuare il conteggio sulla stessa area su un vetrino colorato con ematossilina-eosina. Questo approccio potrebbe ridurre ulteriormente la variabilità inter-osservatore. In conclusione, lo studio evidenzia la necessità di ulteriori ricerche per ottimizzare l'utilizzo dell'immunoistochimica nella valutazione del budding, al fine di migliorarne la riproducibilità e il valore prognostico nella pratica clinica.
