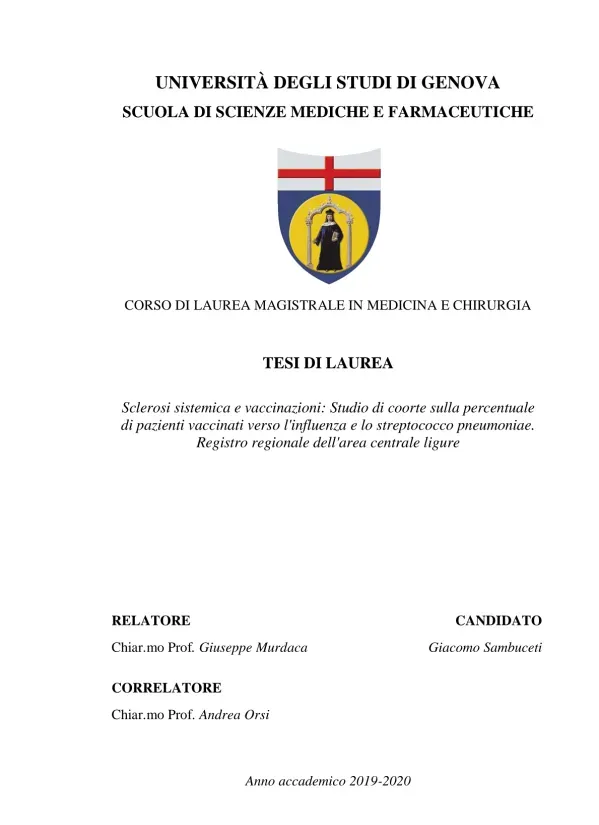
Sclerosi Sistemica e Vaccini: Studio di Coorte
Informazioni sul documento
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 1.78 MB |
Riassunto
I.Introduzione La Sclerosi Sistemica e la Vaccinazione
Questo studio si concentra sull'importanza della vaccinazione contro l'influenza e lo Streptococcus pneumoniae nei pazienti affetti da Sclerosi Sistemica (SSc), una malattia autoimmune con aumentato rischio infettivo. L'obiettivo è valutare l'efficacia di una campagna vaccinale attiva nel migliorare la copertura vaccinale in una coorte ligure di 91 pazienti SSc, confrontandola con le linee guida italiane e con una coorte di controllo di 52 pazienti SSc di Ancona. La ricerca analizza la copertura vaccinale nel tempo e le correlazioni tra la somministrazione dei vaccini e le caratteristiche demografiche dei pazienti.
1. Scopo dello Studio e la Sclerosi Sistemica
Lo studio indaga l'efficacia di una campagna vaccinale attiva contro l'influenza e lo Streptococcus pneumoniae in pazienti con sclerosi sistemica (SSc). La SSc è una malattia autoimmune con prognosi sfavorevole e aumentato rischio infettivo, rendendo la vaccinazione un metodo di prevenzione cruciale, soprattutto per le infezioni respiratorie. L'obiettivo principale è dimostrare come un'attiva campagna vaccinale possa incrementare significativamente il tasso di immunizzazione contro questi patogeni nella popolazione affetta da SSc. La ricerca si focalizza sull'analisi delle percentuali di copertura vaccinale nel tempo, confrontando i dati di una coorte di pazienti liguri con le linee guida italiane e con una coorte di controllo di pazienti sclerodermici provenienti da Ancona. Questo confronto tra diverse realtà geografiche permette di valutare l'impatto delle strategie vaccinali e delle differenze nelle prassi cliniche.
2. Metodologia dello Studio Coorti e Raccolta Dati
La metodologia dello studio prevede l'analisi di due coorti: una coorte ligure di 91 soggetti con SSc e una coorte di controllo di 52 pazienti SSc provenienti da un altro centro (Ancona). La raccolta dati si è svolta nell'arco di tre anni, durante le visite di follow-up presso le cliniche di appartenenza. Sono stati raccolti dati demografici, clinici, terapeutici e relativi alle vaccinazioni. L'analisi statistica include lo studio delle correlazioni tra la somministrazione dei vaccini e le diverse caratteristiche demografiche dei pazienti, al fine di identificare eventuali fattori associati alla risposta alla campagna vaccinale. L'ampiezza del campione, con 91 pazienti nella coorte ligure e 52 nella coorte di controllo, consente una significativa analisi statistica dei dati raccolti nel periodo di tre anni.
II.Classificazione della SSc Forme Limitata e Diffusa
Lo studio include pazienti con Sclerosi Sistemica (SSc) sia nella forma limitata (lcSSc) che diffusa (dcSSc). La lcSSc, precedentemente nota come Sindrome CREST, è caratterizzata da un coinvolgimento cutaneo prevalente, mentre la dcSSc ha un interessamento più sistemico. La presenza di autoanticorpi, come ANA ed ENA, è rilevante per la diagnosi differenziale, ma non è sempre decisiva. L'incidenza della SSc varia a livello geografico, con una netta prevalenza nel sesso femminile, anche se gli uomini tendono a manifestare forme più gravi. Il Fenomeno di Raynaud (FR) è un sintomo precoce in oltre il 95% dei casi.
1. Forme di Sclerosi Sistemica lcSSc e dcSSc
Il documento descrive le due principali forme di sclerosi sistemica (SSc): la forma limitata cutanea (lcSSc) e la forma diffusa cutanea (dcSSc). La lcSSc, precedentemente nota come sindrome CREST (Calcinosi, Fenomeno di Raynaud, dismotilità Esofagea, Sclerodattilia, Telangectasie), si caratterizza per un coinvolgimento prevalentemente cutaneo, con fibrosi limitata alle estremità degli arti o alle dita. La positività agli autoanticorpi anti-centromero è più frequente nella lcSSc rispetto alla dcSSc, contribuendo alla diagnosi differenziale. La morfea, una forma di lcSSc, è considerata più benigna, con coinvolgimento limitato alla cute e scarsa positività agli autoanticorpi (ANA e ENA). La diagnosi di morfea è principalmente clinica, ricorrendo alla biopsia solo in casi dubbi. A differenza della morfea, la lcSSc impatta significativamente sulla qualità di vita dei pazienti, causando maggiori difficoltà. L'incidenza della SSc varia geograficamente (da 0.77 casi per 100.000 persone in Olanda a 5.6 negli USA) e presenta una marcata prevalenza nel sesso femminile (rapporto 3:1-14:1 rispetto agli uomini). Gli uomini, però, tendono a manifestare una forma più grave e con diagnosi più tardiva.
2. Fattori Genetici e Ambientali nella SSc
L'eziologia della SSc è complessa e multifattoriale. Studi su gemelli mostrano una bassa concordanza per la malattia (4.2% nei gemelli monozigoti e 5.6% nei dizigoti), indicando un ruolo significativo di fattori ambientali ed epigenetici oltre alla componente genetica. Il complesso maggiore di istocompatibilità (MHC), e in particolare gli alleli HLA di classe II (HLA-DRB1, HLA-DQA1, HLA-DRB1, HLA-DQB1, HLA-DPB1), sono fortemente implicati nella predisposizione alla SSc. Le differenze genetiche tra le etnie influenzano la suscettibilità alla malattia, come dimostrato da studi che evidenziano una maggiore prevalenza tra nativi americani, caucasici e afroamericani. Queste differenze genetiche potrebbero riguardare la funzionalità di cellule specifiche, interleuchine e recettori. La presenza del Fenomeno di Raynaud (FR) precede spesso l'esordio della malattia, con un intervallo di tempo più lungo nella lcSSc (fino a 10 anni) rispetto alla dcSSc (circa un anno).
III.Aspetti Genetici ed Ambientali della SSc
La predisposizione genetica alla Sclerosi Sistemica (SSc), influenzata dal complesso maggiore di istocompatibilità (MHC) e in particolare dagli alleli HLA, è un fattore importante ma non esclusivo. Studi su gemelli hanno dimostrato una bassa correlazione genetica, suggerendo l'influenza di fattori ambientali ed epigenetici. La prevalenza della SSc varia tra le diverse etnie, con un'incidenza maggiore in alcune popolazioni (es. nativi americani, afroamericani). L'esposizione a specifici agenti chimici (es. acqua ragia) e fattori occupazionali possono peggiorare la malattia, in particolare a livello polmonare.
1. Ruolo della Genetica nella Sclerosi Sistemica
La suscettibilità alla sclerosi sistemica (SSc) presenta una componente genetica complessa, ma non deterministica. Studi su gemelli, citando Feghali-Bostwick et al. (2003), mostrano una bassa concordanza per la malattia (4.2% nei monozigoti e 5.6% nei dizigoti), suggerendo un ruolo significativo di fattori ambientali ed epigenetici. Il complesso maggiore di istocompatibilità (MHC), e in particolare i loci HLA di classe II (HLA-DP, HLA-DQ, HLA-DR), sono cruciali. Studi specifici su HLA-DRB1, HLA-DQA1, HLA-DRB1, HLA-DQB1 e HLA-DPB1 (quest'ultimo associato agli anticorpi anti-centromero) hanno rivelato che alcuni alleli specifici possono predisporre alla malattia, tramite sostituzione di aminoacidi o polimorfismi di singolo nucleotide. Questa variabilità genetica spiega la diversa suscettibilità tra le etnie, con maggiore incidenza in popolazioni come nativi americani, caucasici e afroamericani (Arnett FC, 1996; Arnett FC, 2011; Ramazan Rezaei, 2018; Mayes MD, 2014). Le differenze genetiche possono coinvolgere diverse funzioni cellulari, interleuchine e recettori.
2. Fattori Ambientali e Predisposizione Etnica
Oltre alla componente genetica, l'ambiente svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo della SSc. La prevalenza della malattia è fortemente correlata all'etnia, come dimostrato da studi che evidenziano una maggiore incidenza in determinate popolazioni. Ad esempio, uno studio di Arnett FC e colleghi (1996) ha riscontrato una prevalenza quasi doppia di SSc in Oklahoma, attribuibile alla significativa presenza di nativi americani. Altri studi sottolineano la maggiore suscettibilità di afroamericani e caucasici rispetto ai controlli (Arnett FC, 2011). Questa diversa suscettibilità è principalmente legata al complesso maggiore di istocompatibilità (MHC) e agli HLA di classe II, molecole altamente polimorfiche che interagiscono con gli antigeni nel sistema immunitario. Un malfunzionamento o un fenotipo troppo specifico degli HLA rappresentano un forte fattore di rischio per malattie autoimmuni (Kelly A, 2019). L'esposizione occupazionale e a specifiche sostanze chimiche, come l'acqua ragia (white spirit), solventi per tinture e detergenti, sono state associate a forme più gravi di SSc, soprattutto a livello polmonare (Bottomley WW, 1993; Magnant J, 2005; Marie I, 2014; McCormic ZD, 2010; Liu T, 2015).
IV.Manifestazioni Cliniche della SSc
La Sclerosi Sistemica (SSc) presenta numerose manifestazioni cliniche, che interessano diversi organi. Il Fenomeno di Raynaud (FR) è un sintomo precoce e comune. Il coinvolgimento cutaneo, quasi universale, inizia dalle mani e può progredire, con edema, fibrosi e atrofia cutanea. Altre manifestazioni includono problemi gastrointestinali (soprattutto esofagei), renali (crisi renale sclerodermica), polmonari (fibrosi polmonare, ipertensione polmonare), muscoloscheletrici (artropatia), e cardiaci. La diagnosi è principalmente clinica.
1. Il Fenomeno di Raynaud FR nella SSc
Il Fenomeno di Raynaud (FR) è un sintomo precoce e molto comune nella sclerosi sistemica (SSc), presente in oltre il 95% dei casi. Si tratta di una manifestazione vascolare caratterizzata da vasospasmi, perdita capillare e, in casi estremi, gangrena. È fondamentale indagare tutti gli individui che riportano almeno due manifestazioni di FR, utilizzando la videocapillaroscopia per una diagnosi accurata (Meier FM, et al., 2012). La distinzione tra FR idiopatico e secondario (causato da SSc) si basa su alcuni fattori: l'esordio dopo i 25 anni, una minore frequenza degli episodi e un rapporto femmine/maschi più elevato (20:1 rispetto al 4:1 della SSc) suggeriscono un FR idiopatico (RUGARLI, MEDICINA INTERNA SISTEMATICA-Rugarli C, 2015). L'intervallo di tempo tra la comparsa del FR e l'esordio degli altri sintomi varia a seconda della forma di SSc: nella dcSSc è più breve (circa un anno), mentre nella lcSSc può essere più lungo (anche 5 anni) (Ostojić P, 2004).
2. Coinvolgimento Cutaneo nella SSc
Il coinvolgimento cutaneo è quasi universale nella SSc, iniziando spesso dalle mani ed estendendosi agli arti superiori. Nella dcSSc, può interessare anche il tronco e il viso (Volkmann, 2015). I primi sintomi sono spesso una sensazione di gonfiore e impaccio alle mani (“puffy”), seguita da fibrosi e atrofia tissutale (Hughes, et al., 2019). Nella fase sclerotica, la cute è tesa, ispessita ma assottigliata, aderente ai piani sottostanti, con riduzione o assenza di peli, volto amimico, microstomia e microcheilia (Bajraktari IH, 2015; Christopher P Denton, 2017). L'aderenza cutanea alle articolazioni limita il movimento, causando contrattura delle dita (“ad artiglio”) e possibile acroosteolisi (RUGARLI, MEDICINA INTERNA SISTEMATICA-Rugarli C, 2015). La riduzione dello spessore cutaneo, la vasculopatia periferica e la scarsa elasticità predispongono alla formazione di ulcere e lesioni tipiche come le “pitting scars” (Ferreli, 2017).
3. Altre Manifestazioni Cliniche della SSc
La SSc può colpire diversi organi e apparati. L'apparato respiratorio può presentare fibrosi polmonare e ipertensione polmonare, con dispnea come sintomo comune. La diagnosi di ipertensione polmonare si basa sull'ecocardiografia o sul cateterismo cardiaco destro (Hoeper MM; Saygin D, 2019). L'artropatia è molto diffusa (80-90%), presentandosi come artralgia simmetrica simil-reumatoide, con o senza rigidità articolare (Morrisroe KB, 2015; UNIREUMA-REUMATOLOGIA, 2016). Si può osservare acroosteolisi delle falangi distali, tensosinovite, entesite, borsite e miositi (Lóránd V, 2014; Siao-Pin S, 2016; Thietart S, 2018). Altri problemi includono disordini gastrointestinali (più frequenti a livello esofageo), renali (crisi renale sclerodermica), e aumento del rischio di neoplasie (soprattutto polmonari) (Sargin G, 2018). Patologie come la nevralgia del trigemino e l'impotenza (nei maschi) possono influenzare la qualità di vita (Bajraktari IH, 2015; Jaeger VK, 2016).
V.Esami di Laboratorio e Diagnostica
Non esiste un profilo laboratoristico patognomonico per la SSc. Spesso si osserva anemia, aumento degli indici infiammatori (VES, PCR), e carenze nutrizionali (ferro, vitamina B12). La diagnosi si basa sui criteri clinici dell'American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism (ACR/EULAR) del 2013. La diagnostica strumentale include ecografia, radiologia, e indagini specifiche per gli organi interessati (es. esofagoscopia, ecocardiografia).
1. Esami di Laboratorio nella SSc
Il documento sottolinea l'assenza di un quadro laboratoristico unico e patognomonico per la sclerosi sistemica (SSc). L'emocromo di routine spesso rivela anemia, che può essere microcitica normocromica (tipica delle connettiviti) o ipocromica per un eccessivo turnover cellulare. Nei pazienti con ipertensione polmonare, il ricambio eritrocitario elevato causa deficit di ferro nel 46% dei casi (Ruiter G, 2014). Un'altra carenza frequente è quella di vitamina B12 (71% dei pazienti), che può portare ad anemia megaloblastica (Tas Kilic D, 2018). Gli indici infiammatori aspecifici, come VES e PCR, risultano significativamente aumentati in quasi il 95% dei casi, indicando una flogosi cronica e sistemica (Becker M, et al., 2019). Nonostante la mancanza di un marker specifico, questi esami di laboratorio forniscono importanti indicazioni cliniche.
2. Diagnostica Strumentale nella SSc
La diagnosi della SSc è principalmente clinica, facilmente formulabile in presenza di coinvolgimento cutaneo. Esistono criteri classificativi (American Rheumatology Association - ARA e European League Against Rheumatism - EULAR, 2013), utili per la ricerca ma non dirimenti per la diagnosi. La diagnostica strumentale varia a seconda dell'organo coinvolto. L'esofago, frequentemente interessato, viene valutato tramite tonometria esofagea, pH-metria delle 24 ore, RX con pasto baritato ed eventualmente esofago-gastroscopia (Kröner PT, 2019). La componente renale è valutata con ecografia Doppler (Rosato E, 2018), mentre per l'apparato muscoloscheletrico si utilizzano ecografia Doppler e radiografia tradizionale, con RMN come esame di secondo livello per indagini più approfondite (Thietart S, 2018; Lóránd V, 2014). La scelta degli esami strumentali è dunque guidata dalla clinica e dalle specifiche manifestazioni della malattia.
VI.Trattamento e Prognosi
Il trattamento della SSc mira a gestire i sintomi e le complicazioni. Per il Fenomeno di Raynaud (FR) si utilizzano vasodilatatori. La crisi renale sclerodermica richiede una terapia antiipertensiva aggressiva. L'ipertensione polmonare viene trattata con vasodilatatori. La terapia immunosopressiva aumenta il rischio di infezioni, rendendo fondamentale la vaccinazione.
1. Aspetti Laboratoristici nella SSc
Non esiste un profilo laboratoristico specifico per la sclerosi sistemica (SSc). Gli esami di routine possono evidenziare anemia, spesso microcitica normocromica (tipica delle malattie del tessuto connettivo), che può evolvere in anemia ipocromica a causa di un elevato turnover cellulare. L'ipertensione polmonare, complicanza frequente, è associata a deficit di ferro nel 46% dei casi, a causa dell'aumentato ricambio eritrocitario (Ruiter G, 2014). Anche la carenza di vitamina B12 è comune (71% dei pazienti), potendo causare anemia megaloblastica (Tas Kilic D, 2018). Quasi il 95% dei pazienti presenta un aumento significativo degli indici infiammatori aspecifici (VES e PCR), indicando una flogosi cronica e sistemica (Becker M, et al., 2019). Questi reperti, pur non essendo specifici per la SSc, sono utili per la valutazione clinica.
2. Diagnostica Strumentale e Criteri Diagnostici
La diagnosi di SSc è prevalentemente clinica, facilmente effettuabile quando il coinvolgimento cutaneo è evidente. Esistono criteri classificativi, definiti da American Rheumatology Association (ARA) e European League Against Rheumatism (EULAR) nel 2013, che non sono dirimenti ma forniscono supporto diagnostico, soprattutto nella ricerca. La scelta degli esami strumentali dipende dagli organi colpiti. L'esofago, frequentemente interessato, richiede tonometria esofagea, pH-metria 24h, RX con pasto baritato ed eventualmente esofagogastroscopia (Kröner PT, 2019). La valutazione renale si basa su ecografia Doppler (Rosato E, 2018), mentre per l'apparato muscoloscheletrico si utilizzano ecografia Doppler e radiografia semplice, con risonanza magnetica (RM) nei casi dubbi (Thietart S, 2018). Per il sistema muscolare, l'elettromiografia può essere utile (Lóránd V, 2014).
VII.Risultati dello Studio sulla Copertura Vaccinale
Lo studio ha mostrato un significativo miglioramento nella copertura vaccinale contro l'influenza e lo Streptococcus pneumoniae nella coorte ligure di 91 pazienti SSc nei tre anni di osservazione. La campagna vaccinale attiva ha aumentato il numero di soggetti immunizzati. Il confronto con la coorte di controllo di Ancona (52 pazienti) evidenzia differenze nella copertura vaccinale, sottolineando l'importanza di una strategia attiva di informazione e sensibilizzazione. L'età media della coorte ligure era di 63,5 anni, con una prevalenza femminile dell'80%. Il 50,5% dei pazienti presentava lcSSc e il 29,7% dcSSc. I risultati sottolineano l'importanza delle raccomandazioni mediche per raggiungere una copertura vaccinale adeguata, anche in pazienti non rientranti nelle categorie a rischio indicate dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV).
1. Caratteristiche della Coorte e Confronto con Ancona
Lo studio ha coinvolto una coorte ligure di 91 pazienti con sclerosi sistemica (SSc), con un'età media di 63,5 anni e una mediana di 64. Il rapporto maschi/femmine era di circa 1:4, con le donne che rappresentavano poco più dell'80% del campione. La distribuzione delle forme di SSc era la seguente: 50.5% lcSSc e 29.7% dcSSc. Il numero di pazienti reclutati è aumentato da 72 nel primo anno a 91 nei due anni successivi, con un decesso compensato da un nuovo arruolamento. Una coorte di controllo di 52 pazienti SSc di Ancona è stata utilizzata per il confronto, presentando caratteristiche cliniche e demografiche simili, ad eccezione di una diversa prevalenza di patologie cardiovascolari. Questo confronto tra coorti italiane permette di valutare l'efficacia delle strategie vaccinali in contesti clinici simili, evitando le variabili introdotte da studi internazionali con linee guida differenti.
2. Copertura Vaccinale Influenza e Streptococcus pneumoniae
La copertura vaccinale nella coorte ligure, inizialmente inadeguata, è aumentata significativamente negli anni successivi all'implementazione di una campagna vaccinale attiva contro l'influenza e lo Streptococcus pneumoniae. I dati (tabelle 5 e 6) mostrano un miglioramento statisticamente significativo confrontando il primo e il terzo anno dello studio. La coorte di Ancona, invece, fornisce solo un dato istantaneo sulla copertura vaccinale, senza analisi temporale. Secondo il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV), solo il 7.7% dei pazienti liguri non rientrava nelle categorie a rischio (età superiore a 65 anni, terapia immunosoppressiva o comorbidità). Nonostante ciò, solo circa tre quarti dei pazienti hanno usufruito della vaccinazione, evidenziando una discrepanza tra l'elevata indicazione vaccinale e la copertura effettiva. La copertura vaccinale contro lo Streptococcus pneumoniae è risultata soddisfacente (almeno 75% in ogni categoria analizzata), con una maggiore protezione osservata nei pazienti con comorbidità, sotto terapia immunosoppressiva e con età superiore a 65 anni.
3. Ruolo delle Raccomandazioni Mediche e Immunizzazione di Gregge
L'alto livello di sicurezza ed efficacia dei vaccini contro l'influenza e lo Streptococcus pneumoniae, anche in pazienti con malattie reumatiche o immunologiche (Murdaca, et al., 2014; Bijl, et al., 2012), rende la loro raccomandazione cruciale. A differenza di quanto osservato in Austria (Harrison, et al., 2018), dove i medici di medicina generale svolgevano un ruolo maggiore nell'accettazione delle vaccinazioni, in Liguria la gestione sembra più a carico degli specialisti. I risultati mostrano un'alta accettazione delle raccomandazioni degli specialisti, portando ad un'elevata copertura vaccinale. La copertura per lo Streptococcus pneumoniae supera il 75% in tutte le categorie, mentre per l'influenza i risultati sono ancora più significativi, dimostrando una dedizione annuale costante. L'eterogeneità della popolazione protetta nel corso degli anni evidenzia la necessità di estendere le raccomandazioni vaccinali a tutti i pazienti con SSc, indipendentemente dalle caratteristiche cliniche o anagrafiche, per massimizzare la protezione tramite il principio dell'immunità di gregge (Rashid H., 2012).
