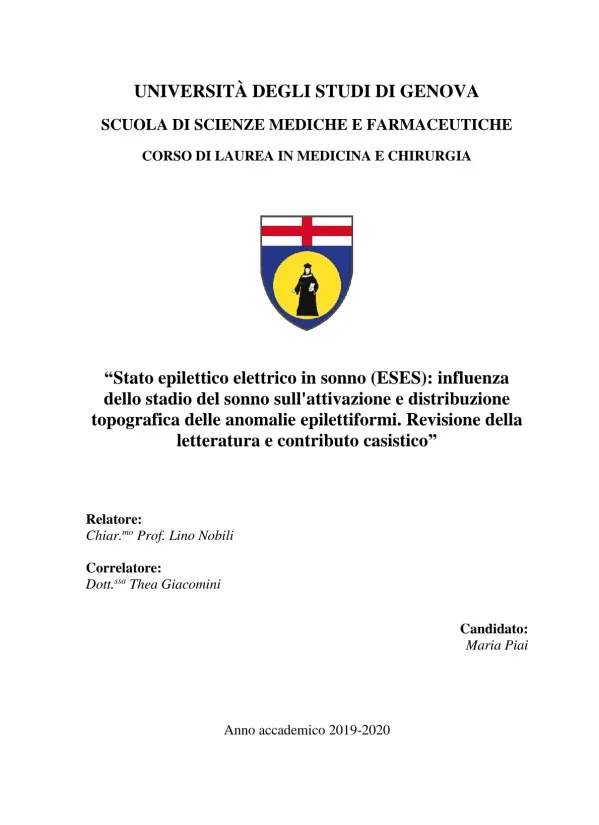
ESES: Epilessia e Sonno
Informazioni sul documento
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 3.71 MB |
Riassunto
I.Definizione e Classificazione dell Epilessia
Questo capitolo definisce l'epilessia come un disturbo neurologico caratterizzato da crisi epilettiche ricorrenti e non provocate. La diagnosi richiede due o più crisi non provocate a distanza di almeno 24 ore, oppure una singola crisi con alta probabilità di recidiva (almeno il 60% nei successivi 10 anni). Le crisi sono classificate come focali (con o senza compromissione della consapevolezza) o generalizzate (motorie o non motorie, come le assenze). Il tipo di epilessia (focale, generalizzata, combinata o a esordio sconosciuto) e la sindrome epilettica (combinazione di caratteristiche cliniche, elettroencefalografiche e radiologiche) sono elementi chiave nella classificazione. Spesso, l'eziologia dell'epilessia rimane sconosciuta, anche se fattori genetici, infettivi, metabolici e immunitari possono essere coinvolti.
1. Definizione di Epilessia
Il documento definisce l'epilessia come un disturbo neurologico caratterizzato dalla comparsa di crisi epilettiche e da una tendenza patologica e duratura allo sviluppo di ulteriori crisi. Questa definizione si basa su criteri specifici: due o più crisi epilettiche non provocate, separate da un intervallo di almeno 24 ore, oppure una singola crisi non provocata con una probabilità di recidiva superiore al 60% nei successivi 10 anni. Questo cut-off del 60% è stato scelto in quanto rappresenta il limite inferiore della probabilità di recidiva dopo due crisi non provocate, come evidenziato dagli studi citati (13). La definizione sottolinea l'aspetto ricorrente della patologia e la significativa probabilità di ulteriori eventi epilettici, differenziandola da episodi isolati di convulsioni. L'importanza di distinguere tra crisi provocate e non provocate per la diagnosi è implicita nella definizione stessa, sottolineando il ruolo della storia clinica del paziente nel processo diagnostico.
2. Classificazione delle Crisi Epilettiche
Il testo prosegue descrivendo la classificazione delle crisi epilettiche, partendo da una distinzione fondamentale tra crisi focali e generalizzate. Il termine 'focale' sostituisce la precedente definizione di 'crisi parziale'. Le crisi focali vengono ulteriormente suddivise in base allo stato di coscienza: crisi a consapevolezza integra ('aware') e crisi con consapevolezza compromessa ('impaired awareness'), sostituendo le precedenti definizioni di crisi semplice e complessa. Successivamente, le crisi focali sono classificate in base all'esordio, motorio o non motorio. Per le crisi a esordio generalizzato, lo stato di coscienza è quasi sempre compromesso e quindi non viene considerato nella classificazione primaria; invece, si specifica la natura dell'onset, motoria o non motoria. Le crisi generalizzate motorie sono ulteriormente definite come tonico-cloniche o 'other motor', mentre quelle non motorie sono definite assenze. Questa classificazione gerarchica e dettagliata mira a fornire una descrizione precisa e completa delle diverse manifestazioni cliniche dell'epilessia, fondamentale per una corretta diagnosi e gestione del paziente.
3. Tipi di Epilessia e Sindromi Epilettiche
Oltre alla classificazione delle crisi, il documento affronta la classificazione dell'epilessia stessa. Si evidenzia che, dopo aver valutato il tipo di crisi epilettiche, si procede, quando possibile, alla definizione del tipo di epilessia, che può essere focale, generalizzata, combinata (focale e generalizzata) o di tipo non noto ('unknown onset'). Questo aspetto sottolinea la complessità della patologia e la difficoltà, in alcuni casi, di una precisa classificazione. Un ulteriore livello di classificazione prevede l'identificazione della sindrome epilettica, definita come la risultante dell'associazione di più caratteristiche cliniche, elettroencefalografiche e radiologiche. L'esistenza di pazienti che non rientrano in nessuna classificazione specifica è riconosciuta, sottolineando la variabilità e la complessità delle manifestazioni cliniche dell'epilessia. La distinzione tra tipo di crisi, tipo di epilessia e sindrome epilettica è essenziale per una comprensione completa della patologia.
4. Eziologia dell Epilessia
Il paragrafo dedicato all'eziologia dell'epilessia elenca diverse possibili cause, sottolineando la complessità e l'eterogeneità della patologia. Tra le cause si menzionano fattori genetici, infettivi, metabolici e immunitari, evidenziando la possibilità di una coesistenza di più fattori eziologici in uno stesso paziente. Per quanto riguarda l'aspetto genetico, si specifica che diversi geni, molti ancora sconosciuti, possono essere coinvolti e che gli studi di genetica molecolare hanno identificato numerose mutazioni geniche causative, ma la maggior parte di esse presenta eterogeneità fenotipica. Analogamente, la maggior parte delle sindromi epilettiche mostra una grande eterogeneità genetica. Nonostante l'identificazione di questi gruppi eziologici, spesso l'eziologia dell'epilessia rimane non nota (14), un aspetto importante da considerare nella pratica clinica e nella ricerca.
II.Meccanismi di Epilettogenesi
L'epilettogenesi si riferisce all'attività neuronale anomala che genera attività epilettica. L'equilibrio tra attività eccitatoria e inibitoria nel cervello è fondamentale. Una riduzione della soglia di eccitabilità neuronale, dovuta a diversi fattori, può portare a scariche parossistiche e conseguenti crisi epilettiche. L'attività epilettica può essere focale o generalizzata, e le manifestazioni cliniche dipendono dalla localizzazione e dalla propagazione dell'attività.
1. Definizione di Epilettogenesi
Il termine 'epilettogenesi' indica una condizione caratterizzata da un'attivazione neuronale anomala che produce attività epilettica episodica, rilevabile tramite elettroencefalogramma (EEG). Questa attività può essere associata o meno a manifestazioni cliniche. L'attività epilettica può coinvolgere piccole popolazioni neuronali (attività focale) oppure l'intero cervello simultaneamente (epilessia generalizzata). La presenza e la natura delle manifestazioni cliniche dipendono dalla localizzazione dell'evento iniziale e dalla sua eventuale propagazione nel cervello. Il processo di epilettogenesi è intimamente legato all'equilibrio fisiologico tra l'attività eccitatoria (depolarizzazione) e inibitoria (iperpolarizzazione) dei neuroni. Qualsiasi alterazione di questo delicato equilibrio, ad esempio un aumento dell'attività eccitatoria o una diminuzione di quella inibitoria, può superare la soglia di eccitabilità neuronale, causando una scarica parossistica eccessiva che genera una crisi epilettica.
2. Meccanismi di Ipereccitabilità Neuronale
Il testo identifica tre elementi chiave che contribuiscono all'ipereccitabilità neuronale, condizione necessaria per l'epilettogenesi: alterazioni dei canali ionici, modificazioni sinaptiche e cambiamenti nell'attività neurochimica. Questi fattori possono agire singolarmente o in combinazione, determinando una riduzione della soglia di eccitabilità neuronale e, di conseguenza, l'insorgenza di crisi epilettiche. La descrizione di questi meccanismi sottolinea la complessità del processo epilettogenetico, coinvolgendo diversi aspetti della fisiologia neuronale e delle interazioni sinaptiche. La comprensione di questi meccanismi è fondamentale per lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche mirate a ristabilire l'equilibrio fisiologico neuronale e a prevenire l'insorgenza delle crisi.
III.Epilessia e Sonno
Questo capitolo esplora la complessa relazione tra epilessia e sonno. I due principali stadi del sonno, NREM e REM, hanno effetti contrastanti sull'attività epilettica. Il sonno NREM, caratterizzato da onde lente (SWA), favorisce la diffusione degli spikes, aumentando la probabilità di crisi epilettiche, soprattutto quelle tonico-cloniche e miocloniche. Al contrario, il sonno REM, con la sua attività desincronizzata e atonia muscolare, sembra avere un effetto protettivo, riducendo la propagazione degli spikes. La registrazione EEG durante il sonno è cruciale per la diagnosi e la gestione dell'epilessia.
1. Effetti del Sonno NREM sull Attività Epilettica
Il documento evidenzia che il sonno NREM, caratterizzato da un'attività EEG sincronizzata e dalla presenza di onde lente (Slow Wave Activity - SWA), favorisce la diffusione e la propagazione degli spikes epilettici. Questa sincronizzazione neuronale aumenta la probabilità di evoluzione degli spikes interictali in crisi epilettiche clinicamente manifeste. In particolare, le crisi generalizzate tonico-cloniche e miocloniche si verificano più frequentemente durante il sonno NREM. La maggiore sincronizzazione delle scariche cellulari durante questa fase del sonno contribuisce, quindi, a un aumento del rischio di crisi epilettiche. L'attività EEG durante il sonno NREM, e in particolare l'ampiezza delle oscillazioni lente, correlata alla densità dei picchi, fornisce informazioni cruciali per la comprensione della relazione tra sonno e attività epilettica. La presenza di fusi del sonno (attività sigma) mostra una relazione temporale tipica con gli spikes, confermando questa correlazione.
2. Effetti del Sonno REM sull Attività Epilettica
Contrariamente al sonno NREM, il sonno REM si caratterizza per un'attività elettrica desincronizzata e per la depolarizzazione delle cellule talamocorticali, con conseguente blocco delle loro oscillazioni. Un'altra caratteristica distintiva del sonno REM è la totale assenza di tono muscolare (atonia muscolare). Questa attività desincronizzata e l'atonia muscolare sembrano avere un effetto protettivo contro l'attività epilettica, riducendo la probabilità di scariche epilettiche e impedendo la comparsa dei movimenti motori associati alle crisi. Il sonno REM è stato definito 'sonno paradosso' proprio per questo contrasto tra un cervello attivo ed un corpo paralizzato. Gli spikes interictali mostrano, durante il sonno REM, una minore tendenza alla propagazione e all'evoluzione in crisi clinicamente evidenti. Questo effetto protettivo del sonno REM è confermato dall'evidenza clinica e dagli studi elettrofisiologici.
3. Alterazioni del Sonno e Farmaci Antiepilettici
Qualsiasi alterazione del sonno può peggiorare le crisi epilettiche, sottolineando l'importanza del riposo adeguato nella gestione dell'epilessia. La registrazione EEG durante il sonno è fondamentale per rilevare l'attività epilettiforme, aumentando la sensibilità rispetto alle registrazioni routinarie. La privazione del sonno può agire come trigger per le scariche epilettiche in soggetti predisposti. I farmaci antiepilettici possono influenzare il sonno, sia positivamente che negativamente, un aspetto da considerare nella scelta della terapia. La comprensione degli effetti contrastanti dei diversi stadi del sonno sull'attività epilettica e dell'influenza dei farmaci antiepilettici sul sonno è fondamentale per una gestione ottimale dei pazienti affetti da epilessia.
IV.ESES e Sindromi Correlate
La sezione si concentra sull'ESES (stato epilettico elettrico durante il sonno lento) e sindromi correlate come la sindrome di Landau-Kleffner (LKS) e la CSWS (onde continue a punta-onda durante il sonno lento). L'ESES è caratterizzata da attività epilettica persistente durante il sonno NREM, con significativa attenuazione nel sonno REM. I parametri diagnostici includono lo Spike-Wave Index (SWI) e le caratteristiche dell'attività epilettica. Fattori genetici, come mutazioni del gene GRIN2A, e fattori neurologici preesistenti possono contribuire allo sviluppo dell'ESES. La patogenesi potrebbe coinvolgere una compromissione della maturazione cerebrale e uno squilibrio nella neurotrasmissione GABAergica. Le conseguenze neuropsicologiche possono essere significative, causando deficit cognitivi e comportamentali. Il trattamento include farmaci antiepilettici (AEDs), corticosteroidi, e in alcuni casi, la chirurgia (come la MST). Lo studio clinico descritto coinvolge 5 pazienti (3 maschi, 2 femmine) con età compresa tra 5 e 10 anni, seguiti presso l'IRCCS Istituto Giannina Gaslini a Genova, Italia. I risultati preliminari confermano l'effetto protettivo del sonno REM, in particolare del sonno REM fasico, sull'attività epilettica nell'ESES.
1. Definizione e Caratteristiche dell ESES
La sezione si concentra sull'ESES (Electrical Status Epilepticus during Slow Sleep), definito come uno stato epilettico elettrico che si manifesta durante il sonno lento (NREM). L'ESES è caratterizzato da un pattern EEG di punte-onde lente continue, bilateralmente diffuse, principalmente a una frequenza di 1.5-2.5 Hz. Questo pattern è evidente nel sonno NREM, con una marcata attenuazione nel sonno REM. L'ESES tipicamente emerge tra i 4 e i 14 anni, sviluppandosi 1 o 2 anni dopo la comparsa delle crisi epilettiche. L'attività epilettica nell'ESES è spesso descritta come un'attività ad onset focale con sincronizzazione bilaterale secondaria, sebbene in alcuni casi si possano osservare pattern con vari gradi di lateralizzazione emisferica. Diversi parametri qualitativi e quantitativi, come il Spike-Wave Index (SWI), vengono utilizzati per la sua definizione e descrizione, ma non c'è una totale uniformità nei metodi di calcolo e nei valori soglia. La definizione fornita dall'ILAE non specifica un valore soglia per lo SWI.
2. Sindromi Correlate all ESES
Il documento evidenzia la stretta correlazione tra ESES e altre sindromi epilettiche, in particolare la sindrome di Landau-Kleffner (LKS) e la CSWS (Continuous Spike-Waves during Slow Sleep). Queste tre sindromi condividono probabilmente uno stesso meccanismo patogenetico, con differenti gradi di espressione. La CSWS, a differenza dell'ESES, mostra una maggiore associazione con antecedenti neurologici congeniti o acquisiti, come convulsioni neonatali, emiparesi congenita, meningite, ritardo psicomotorio, e lesioni cerebrali documentabili radiologicamente. Queste anomalie preesistenti possono associarsi a disabilità intellettiva, emiparesi congenita o diplegia spastica. La presenza di lesioni cerebrali strutturali nell'ESES è meno frequente e di solito non ha un significato eziopatologico. L'associazione tra ESES e queste altre sindromi suggerisce una possibile patogenesi comune, con diverse manifestazioni cliniche probabilmente determinate da una diversa localizzazione topografica dei network neuronali ipereccitabili.
3. Aspetti Genetici e Immunologici dell ESES
La genesi dell'ESES potrebbe essere influenzata da fattori genetici, con mutazioni del gene GRIN2A (16p13.2) che sembrano fortemente correlate a LKS e CSWS. Il gene GRIN2A codifica per la sotto-unità GluN2A del recettore NMDA del glutammato, presente ad alta concentrazione in aree cerebrali cruciali per il linguaggio. Alterazioni di questo gene sono associate a disturbi del neurosviluppo, tra cui l'epilessia. Nonostante l'identificazione di geni potenzialmente coinvolti, il loro ruolo patogenetico nell'ESES rimane in gran parte imprecisato. Anche disordini immunologici potrebbero giocare un ruolo, come suggerito dalla presenza di anticorpi onconeurali e autoanticorpi contro il BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor) in alcuni pazienti con CSWS e LKS. L'indagine su questi aspetti genetici e immunologici è fondamentale per una maggiore comprensione della patogenesi dell'ESES.
4. Patogenesi e Sindrome di Penelope
La patogenesi dell'ESES e delle sindromi correlate potrebbe essere legata a una compromissione della maturazione cerebrale durante i primi anni di vita, che porta alla formazione di network neuronali ipereccitabili. La diversa localizzazione di questi network spiegherebbe le diverse presentazioni cliniche. Un'ipotesi sulla patogenesi dell'ESES riguarda uno shift da una predominanza della neurotrasmissione GABA A a una prevalenza della neurotrasmissione GABA B, con conseguente ipersincronizzazione dei neuroni reticolari. L'attività epilettica prolungata durante il sonno interferisce con la SWA, compromettendo i processi di plasticità sinaptica e le funzioni cognitive. Questa interferenza con i processi di consolidamento mnemonico durante il sonno porta alla definizione di 'Sindrome di Penelope', in cui l'attività epilettica notturna 'cancella' il lavoro di costruzione di nuove reti neuronali svolto durante il giorno. La localizzazione topografica dell'attività epilettica influenza le caratteristiche cliniche dell'encefalopatia epilettica, con deficit visuo-spaziali in caso di localizzazione occipito-temporale e sindrome disesecutiva frontale in caso di prevalenza nelle regioni anteriori.
