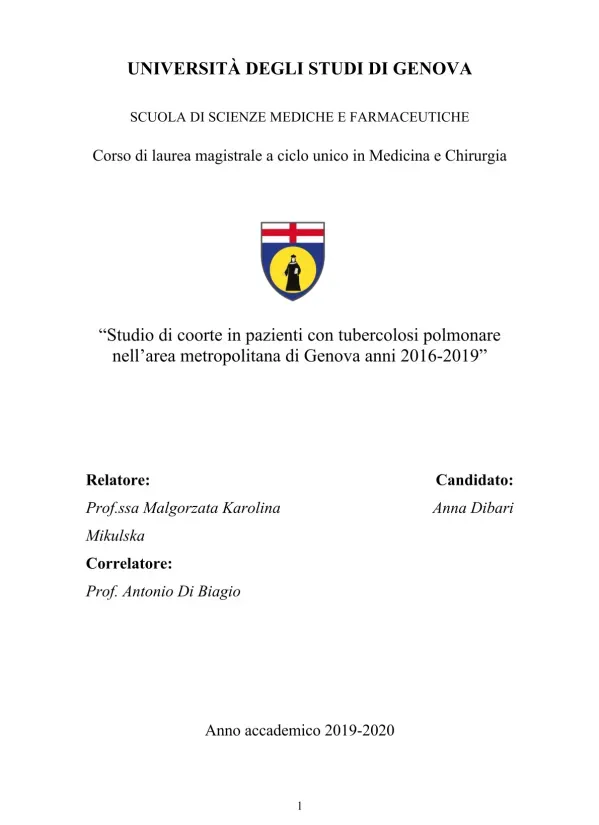
Tubercolosi: Studio di coorte a Genova
Informazioni sul documento
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 4.76 MB |
Riassunto
I.Storia e diffusione della tubercolosi TB
La tubercolosi, conosciuta fin dall'Antica Grecia come "phthìsis", ha visto nel XIX secolo un'impennata dei casi in Europa e Nord America, raggiungendo una prevalenza del 70-90% della popolazione a causa dell'aumento della densità urbana e degli scambi commerciali. L'alto tasso di mortalità per tubercolosi, intorno all'80% nei casi attivi, spinse alla creazione dei primi sanatori, nonostante questi non migliorassero significativamente la sopravvivenza. Solo nel 1865 Villemin ne confermò la natura contagiosa.
1.1. Cenni storici sulla tubercolosi
Il testo inizia tracciando una breve storia della tubercolosi, evidenziando la sua conoscenza già nell'Antica Grecia, come testimoniato dalle opere di Ippocrate, che la definiva "phthìsis", e di Galeno, che ne propose trattamenti con aria fresca, latte e soggiorni in città costiere. È interessante notare come Galeno, a differenza dei suoi predecessori (incluso Ippocrate), sospettasse la natura contagiosa della phthìsis, attribuita invece precedentemente a cause ereditarie. Questo aspetto sottolinea l'evoluzione della comprensione della malattia nel corso dei secoli. La conferma definitiva della natura infettiva giunse solo nel 1865, grazie agli esperimenti di Jean-Antoine Villemin, che inoculò con successo la tubercolosi in un coniglio utilizzando materiale purulento prelevato da un individuo deceduto per la malattia. Questa scoperta fu un punto di svolta nella comprensione e nella lotta contro la tubercolosi.
1.2. Diffusione della tubercolosi nel XIX secolo e nascita dei sanatori
Verso la fine del XIX secolo, la tubercolosi raggiunse livelli epidemici in Europa e Nord America, con una prevalenza stimata tra il 70% e il 90% della popolazione. Questo drammatico aumento fu attribuito a diversi fattori, tra cui l'incremento demografico nelle aree urbane, l'aumento della migrazione e l'intensificazione degli scambi economici. La mortalità associata alla tubercolosi attiva era estremamente elevata, raggiungendo circa l'80% dei casi. L'assenza di trattamenti efficaci contribuì a questa elevata mortalità. In questo contesto, nel 1859 nacque a Gobersdorf, in Germania, il primo sanatorio, una struttura concepita per isolare i pazienti dalla società e fornire cure basate su riposo, esposizione all'aria fresca e al sole, una dieta adeguata e buone pratiche igieniche. Nonostante i benefici psicologici apportati dai sanatori, i dati suggeriscono che la mortalità tra i pazienti ricoverati era simile a quella dei malati che rimanevano a casa, evidenziando i limiti delle terapie disponibili all'epoca.
1.3 Mortalità legata alla tubercolosi
La sezione sulla mortalità legata alla tubercolosi presenta dati significativi sull'impatto devastante della malattia prima dell'avvento della terapia farmacologica. In assenza di trattamento, la mortalità a dieci anni raggiungeva il 70% nei pazienti HIV-negativi con espettorato positivo all'esame microscopico, mentre scendeva al 20% nei pazienti HIV-negativi con forme paucibacillari (espettorato negativo alla microscopia, ma positivo alla coltura). Nel 2018, la tubercolosi ha causato 1,2 milioni di morti tra i pazienti HIV-negativi e 251.000 tra quelli HIV-positivi, con un'incidenza rispettivamente di 16 e 20 casi ogni 100.000 persone. L'Africa e il Sud-est asiatico hanno registrato l'80% delle morti in soggetti HIV-negativi, a indicare una minore prevalenza nei paesi più industrializzati. Si evidenzia inoltre una correlazione tra lo stato socioeconomico e il rischio di contrarre la tubercolosi: individui provenienti da contesti poveri sono più esposti a fattori di rischio come ambienti affollati e mal ventilati, contatto con soggetti infetti, malnutrizione e limitato accesso alle cure mediche. Altri fattori di rischio, come fumo, alcolismo, infezione da HIV e diabete mellito di tipo 2, sono più diffusi tra le fasce socioeconomiche più basse. Sebbene studi abbiano evidenziato una correlazione tra tubercolosi attiva e ridotta tolleranza al glucosio o diabete mellito, non vi è una prova conclusiva di una relazione causale diretta; si ipotizza piuttosto un'influenza della risposta immunitaria all'infezione e di alcuni farmaci antitubercolari, come la rifampicina, sullo sviluppo dell'iperglicemia.
II.Patogenesi della tubercolosi
La patogenesi della tubercolosi è complessa. Mycobacterium tuberculosis viene fagocitato dai macrofagi alveolari, ma riesce a bloccare la formazione del fagolisosoma, replicandosi all'interno. La risposta immunitaria, mediata dai linfociti Th1 e dall'IFNg, porta alla formazione di granulomi e alla necrosi caseosa. Il sistema DosR regola la risposta del micobatterio all'ipossia, inducendo uno stato di latenza. Nel 90% dei casi l'infezione guarisce o diventa latente, mentre nel 10% si sviluppa la tubercolosi attiva.
2.1 Infezione primaria e replicazione di Mycobacterium tuberculosis
La patogenesi della tubercolosi inizia con l'inalazione di particelle contenenti Mycobacterium tuberculosis. Queste particelle raggiungono gli alveoli polmonari, dove il batterio viene fagocitato dai macrofagi alveolari. Crucialmente, M. tuberculosis inibisce la maturazione del fagosoma e la formazione del fagolisosoma, impedendo la sua degradazione e permettendo la replicazione all'interno del macrofago. Questa fase iniziale, detta infezione primaria, può portare a batteriemia e metastasi per via linfoematogena nelle prime tre settimane. La capacità di M. tuberculosis di evitare la distruzione intracellulare è un fattore chiave nella sua patogenicità. Il testo sottolinea anche il ruolo del sistema DosR (dormancy survival regulon), un importante programma genetico indotto da condizioni di ipossia e scarsità di nutrienti. Questo sistema blocca la replicazione batterica, attivando il metabolismo anaerobio e inducendo uno stato di latenza, consentendo al batterio di sopravvivere in condizioni avverse all'interno dell'ospite.
2.2 Risposta immunitaria e formazione del granuloma
La risposta immunitaria gioca un ruolo fondamentale nel contenimento dell'infezione tubercolare. I macrofagi alveolari migrano ai linfonodi regionali, presentando gli antigeni tubercolari ai linfociti T. Questi ultimi si differenziano in linfociti Th1, producendo Interferon-gamma (IFNg), che attiva ulteriormente i macrofagi, promuovendo la maturazione dei fagolisosomi, la produzione di ROS (specie reattive dell'ossigeno) e ossido nitrico, e l'autofagia, un processo di degradazione intracellulare. Questa risposta Th1 è responsabile della formazione del granuloma, una struttura caratterizzata da un'area centrale di necrosi caseosa (caseum) circondata da macrofagi attivati (cellule epitelioidi) e cellule giganti di Langhans. La necrosi caseosa deriva dalla distruzione dei macrofagi non attivati che ospitano bacilli in attiva replicazione. La formazione del granuloma rappresenta un meccanismo di contenimento dell'infezione, ma anche un microambiente che può favorire la persistenza del batterio.
2.3 Evoluzione dell infezione primaria tubercolosi latente e attiva
Il decorso dell'infezione tubercolare può evolvere in due direzioni principali: la tubercolosi latente e la tubercolosi attiva. Nel 90% dei casi, il sistema immunitario riesce a controllare l'infezione, portando alla guarigione o allo sviluppo di una tubercolosi latente, asintomatica. In questa condizione, i granulomi possono calcificare, formando il complesso primario di Ghon (focolaio parenchimale e adenite satellite) visibile alla radiografia del torace. Nel restante 10% dei casi, il complesso primario evolve in tubercolosi attiva. Questo processo è legato alla colliquazione del caseum, che aumenta l'ossigenazione del focolaio, favorendo la replicazione di M. tuberculosis. Il materiale colliquato può drenare nei bronchi (con conseguente possibile trasmissione a altri individui) e nei vasi ematici e linfatici, causando la disseminazione del batterio. Questa fase è caratterizzata anche dalla formazione di cavitazioni. Il testo evidenzia come i micobatteri possano rimanere all'interno dei macrofagi per anni, sottolineando la complessità della patogenesi e la persistenza del batterio anche in caso di apparente guarigione clinica.
III. Diagnosi della tubercolosi
La diagnosi di tubercolosi latente si basa sul test cutaneo (TST) e sui test IGRAs. La diagnosi di tubercolosi attiva richiede l'isolamento di M. tuberculosis da espettorato, aspirato gastrico o lavaggio broncoalveolare (BAL). Le tecniche colturali (MGIT, BacT/Alert, Versa TREK) e i test genotipici (come GeneXpert MTB/RIF per la resistenza alla rifampicina) sono cruciali. La microscopia dell'espettorato è un esame fondamentale, anche se la sua sensibilità è limitata nei casi paucibacillari. Test come il TST e l'IGRA possono dare falsi positivi (vaccinazione BCG, infezioni da micobatteri non tubercolari) o falsi negativi (immunodeficienza).
3.1 Diagnosi di Tubercolosi Latente
La diagnosi di tubercolosi latente si basa principalmente su due test: il test cutaneo (TST) e gli Interferon Gamma Release Assays (IGRA). Il NICE (National Institute for Health and Care Excellence) raccomanda un approccio a due fasi: inizialmente il TST, e se positivo, la conferma con un test IGRA. Il documento evidenzia la possibilità di falsi positivi dovuti a precedente vaccinazione con BCG o infezioni da micobatteri non tubercolari. Un infiltrato cutaneo di diametro maggiore o uguale a 15 mm è fortemente indicativo di infezione da M. tuberculosis. I falsi negativi, invece, possono essere causati da errori nell'esecuzione o lettura del test, ma soprattutto da condizioni che compromettono la risposta immunitaria dell'ospite, come infezione da HIV, linfoma di Hodgkin, terapie immunosoppressive, malnutrizione o età avanzata. Un risultato negativo, quindi, non esclude definitivamente la presenza di infezione tubercolare. L'importanza di un approccio diagnostico accurato e la considerazione di fattori che possono influenzare i risultati dei test sono sottolineati nel testo.
3.2 Diagnosi di Tubercolosi Attiva
La diagnosi di tubercolosi attiva richiede la dimostrazione della presenza di Mycobacterium tuberculosis nei materiali patologici. La localizzazione della malattia determina il tipo di campione da analizzare: per la tubercolosi polmonare, l'esame si concentra su espettorato (spontaneo o indotto), aspirato gastrico e lavaggio broncoalveolare (BAL). Il documento descrive diverse metodiche per la coltura del micobatterio, tra cui l'utilizzo di terreni liquidi come il Mycobacterial Growth Indicator Tube (MGIT), il BacT/Alert e il Versa TREK, che offrono risultati più rapidi (1-2 settimane) rispetto ai terreni solidi. Vengono inoltre menzionati i test genotipici o molecolari, che rilevano le mutazioni genetiche responsabili della resistenza ai farmaci antitubercolari. Il sistema GeneXpert MTB/RIF, ad esempio, permette di identificare la presenza di M. tuberculosis e la resistenza alla rifampicina in soli 100 minuti. La sensibilità e specificità di questo test sono elevate, ma un risultato negativo non esclude completamente la diagnosi di tubercolosi. L'esame microscopico dell'espettorato, pur fondamentale, ha una sensibilità inferiore nei casi paucibacillari. La necessità di un approccio diagnostico multimodale, che integri diversi test per una maggiore accuratezza, è evidente.
IV. Trattamento della tubercolosi
Il trattamento della tubercolosi prevede l'utilizzo di farmaci antitubercolari di prima linea (isoniazide, rifampicina, pirazinamide, etambutolo/streptomicina) per un regime 2HRZE/4HR. L'aderenza terapeutica è fondamentale, e tecniche come la DOT (directly observed treatment) migliorano il successo. La resistenza ai farmaci antitubercolari, in particolare MDR-TB e XDR-TB, richiede regimi terapeutici più lunghi e complessi, che possono includere farmaci di seconda linea come bedaquilina e delamanid. Nei casi di tubercolosi multi-farmaco resistente (MDR-TB) e tubercolosi estensivamente farmaco-resistente (XDR-TB), si può ricorrere anche alla chirurgia.
4.1 Trattamento della tubercolosi sensibile ai farmaci
Il trattamento standard per la tubercolosi sensibile ai farmaci prevede una terapia di prima linea, che include tipicamente isoniazide (H), rifampicina (R), pirazinamide (Z) ed etambutolo (E) o streptomicina (S). Il regime più comune è il 2HRZE/4HR, con una fase intensiva (o di induzione) di due mesi con quattro farmaci, seguita da una fase di mantenimento di quattro mesi con solo isoniazide e rifampicina. Per migliorare l'aderenza al trattamento, si consiglia l'utilizzo di compresse FDC (fixed-dose combination), contenenti due o più farmaci in un'unica compressa. La DOT (directly observed treatment), ovvero l'assunzione del farmaco sotto osservazione diretta da parte di un'altra persona, si è dimostrata efficace nell'aumentare l'aderenza e il successo terapeutico rispetto alla SAT (self-administered therapy), con tassi migliori di successo terapeutico, di aderenza e di conversione dell'espettorato dopo due mesi di trattamento. Studi recenti hanno esplorato regimi più brevi, ma un regime di quattro mesi con fluorchinoloni, pur mostrando una più rapida negativizzazione dell'esame microscopico dell'espettorato, ha mostrato un'incidenza di recidiva maggiore rispetto al regime standard a 6 mesi.
4.2 Trattamento della tubercolosi farmaco resistente MDR TB e XDR TB
Il trattamento della tubercolosi multi-farmaco resistente (MDR-TB) e della tubercolosi estensivamente farmaco-resistente (XDR-TB) richiede regimi terapeutici più lunghi e complessi, con farmaci di seconda linea. Il testo fa riferimento all'uso di farmaci come bedaquilina e delamanid, sottolineando che la bedaquilina è controindicata nei pazienti sotto i 18 anni (se non in casi particolari, sopra i 6 anni), mentre il delamanid, pur con meno studi clinici a supporto, mostra una più rapida negativizzazione dell'esame colturale. Entrambi i farmaci presentano come effetto avverso più grave il prolungamento dell'intervallo QT, con il rischio di aritmie ventricolari e morte cardiaca improvvisa. Per la MDR-TB, il documento accenna a regimi a lunga durata (vedi tabella 4), suggerendo l'inclusione di tre farmaci del gruppo A e uno del gruppo B, o altri accorgimenti in caso di resistenza a determinati farmaci. Il trattamento deve essere iniziato in base ai risultati del DST (drug susceptibility testing) o, in attesa di questi, se la resistenza alla rifampicina è esclusa. L'importanza della combinazione di farmaci per evitare lo sviluppo di resistenza è ripetutamente sottolineata.
4.3 Ruolo della chirurgia e della terapia antiretrovirale
Prima dell'era della chemioterapia, la chirurgia era un pilastro fondamentale nel trattamento della tubercolosi polmonare, basata sul collasso della zona polmonare interessata per ridurre l'ossigenazione e limitare la sopravvivenza di M. tuberculosis. Con l'emergere di ceppi MDR/XDR, la chirurgia è stata reintrodotta, spesso in combinazione con regimi per MDR-TB, per rimuovere tessuto irrecuperabile e ridurre la carica batterica. Gli studi suggeriscono la superiorità della resezione polmonare parziale rispetto alla pneumonectomia totale. La chirurgia è inoltre utilizzata in alcune forme di tubercolosi extrapolmonare, come la meningite tubercolare (in caso di idrocefalo ostruttivo), la pericardite tubercolare (pericardiectomia in caso di costrizione) e la malattia di Pott (decompressione midollare in caso di compressione). Infine, il documento evidenzia il ruolo cruciale della terapia antiretrovirale (HAART) nella co-infezione tubercolosi-HIV, raccomandando l'inizio della HAART entro le prime 8 settimane dall'inizio del trattamento antitubercolare per ridurre l'incidenza della tubercolosi, la frequenza delle recidive, e la mortalità, migliorando gli outcome della malattia e riducendo l'incidenza della Sindrome Infiammatoria da Immunoricostituzione (IRIS).
V.Complicazioni e trattamento della tubercolosi
La tubercolosi può causare diverse complicanze, tra cui la tubercolosi endobronchiale, versamento pleurico, malattia di Pott (tubercolosi vertebrale), infezione renale, peritonite tubercolare e meningite tubercolare. Il trattamento chirurgico può essere necessario in alcuni casi di tubercolosi polmonare estesa e in forme extrapolmonari. L'uso di corticosteroidi è dibattuto, ma può essere indicato in alcune complicanze come la meningite tubercolare.
5.1 Complicanze della tubercolosi post primaria
Il documento elenca numerose complicanze possibili della tubercolosi post-primaria, oltre all'aneurisma di Rasmussen. Tra queste, la tubercolosi endobronchiale, che consiste nell'infezione della parete bronchiale, può diffondersi ad altri segmenti polmonari, causando broncopolmonite. Si manifesta con tosse abbaiante, sibili ed espettorazione di materiale caseoso. Un'altra complicanza è rappresentata dalle bronchiectasie, causate dalla dilatazione delle pareti bronchiali. Il versamento pleurico, caratterizzato da febbre, sudorazione, astenia, tosse e dolore puntorio, è un'altra possibile complicazione. La diagnosi può richiedere la pleurocentesi e, in alcuni casi, la biopsia pleurica per l'isolamento del micobatterio. La malattia di Pott, una forma di tubercolosi vertebrale, può causare dolore dorsale, paraplegia e sintomi neurologici, con compressione midollare fino al 30% dei casi. La disseminazione cutanea tramite tragitti fistolosi è frequente. L'infezione renale può essere inizialmente asintomatica, con piuria sterile, ma progredire verso l'escavazione e la disseminazione agli ureteri, vescica e genitali. La calcificazione renale o la formazione di calcoli sono caratteristiche in metà dei casi, con possibile evoluzione verso insufficienza renale cronica terminale (autonefrectomia). La peritonite tubercolare, infine, si manifesta con dolori addominali vaghi, febbre, astenia e versamento ascitico.
5.2 Altre Complicazioni e Manifestazioni della Tubercolosi
Oltre alle complicanze già descritte, il documento menziona la meningite tubercolare, che può essere l'unica manifestazione della malattia o coesistere con il coinvolgimento di altri organi. Il sistema nervoso centrale è coinvolto nel 5-10% dei casi di tubercolosi extrapolmonare, con maggiore rischio per bambini, pazienti HIV-positivi o immunocompromessi. La diagnosi richiede la puntura lombare, con analisi del liquido cefalorachidiano, ma le alterazioni riscontrate non sono esclusive della meningite tubercolare. La diagnosi certa si basa su criteri microbiologici, pur con la bassa sensibilità della microscopia e della coltura. Altre manifestazioni cutanee includono lo scrofuloderma (infiltrazione cutanea sopra un linfonodo tubercolare), il lupus vulgaris (placca con margine rilevato e verrucoso, che può ulcerarsi) e la chancre tubercolare (inoculazione diretta). Il documento evidenzia l'importanza della diagnosi differenziale, considerando la variabilità della presentazione clinica di queste complicazioni e la necessità di metodi diagnostici specifici per confermare l'eziologia tubercolare.
5.3 Trattamento delle Complicazioni
Il trattamento delle complicanze della tubercolosi varia a seconda della localizzazione e della gravità. Per la meningite tubercolare, l'uso di corticosteroidi è raccomandato dalle linee guida NICE per ridurre mortalità, recidive e disabilità, mentre le linee guida IDSA lo consigliano solo in casi specifici (versamento pericardico abbondante, segni di costrizione o alti livelli di markers infiammatori). Nella pericardite tubercolare, l'uso di corticosteroidi è dibattuto. La pericardiectomia è indicata nei casi di pericardite costrittiva. Nella malattia di Pott, l'intervento chirurgico può essere necessario in caso di ascesso, cifosi severa (>60°) o deformità severa residua. In caso di idrocefalo ostruttivo complicanza della meningite tubercolare, se i diuretici non sono sufficienti, si ricorre a uno shunt ventricolo-peritoneale. Il trattamento della tubercolosi stessa, come descritto in precedenza, è fondamentale per controllare l'infezione e ridurre il rischio di complicanze. La scelta terapeutica si basa sul test di sensibilità ai farmaci (DST) per guidare la scelta del regime più appropriato, considerando anche la possibile resistenza alla rifampicina e all'isoniazide.
VI.Vaccinazione anti tubercolosi e sorveglianza
Il vaccino BCG offre una protezione variabile contro la tubercolosi polmonare, con efficacia ridotta vicino all'Equatore. Non è considerato uno strumento efficace per ridurre l'incidenza della tubercolosi nella popolazione generale. La sorveglianza epidemiologica della tubercolosi è essenziale per monitorare la prevalenza, la resistenza ai farmaci e l'efficacia delle strategie di controllo. Lo studio menzionato evidenzia una diminuzione della prevalenza di pazienti con co-infezione da HIV e una maggiore capacità di diagnosi e gestione dei casi di tubercolosi.
6.1 Efficacia del vaccino BCG
Il documento affronta l'efficacia del vaccino BCG contro la tubercolosi, sottolineando che la sua efficacia negli adulti è meno chiara rispetto ai bambini. Una meta-analisi di studi clinici ha dimostrato che il BCG conferisce protezione in un range compreso tra 0% e 80% dei casi, con un grado di protezione che sembra diminuire avvicinandosi all'equatore, probabilmente a causa di una precedente esposizione a ceppi non tubercolari di micobatteri. Per queste ragioni, si ritiene ormai che il vaccino BCG non possa essere utilizzato come strumento per ridurre l'incidenza della tubercolosi a livello di popolazione. Nonostante ciò, il documento specifica che il vaccino BCG è sicuro e che le complicanze sono estremamente rare. Le reazioni avverse locali, come lesioni necrotiche, ascessi sottocutanei, cheloidi e linfoadenopatia, sono poco comuni. Reazioni disseminate sono estremamente rare e associate a elevata mortalità, soprattutto in bambini immunocompromessi. Attualmente sono in corso studi per sviluppare nuovi vaccini, con l'obiettivo di sostituire il BCG con un vaccino più efficace o di potenziare l'effetto protettivo del BCG stesso.
6.2 Sorveglianza epidemiologica della tubercolosi
Il documento accenna alla sorveglianza epidemiologica della tubercolosi, confrontando dati interni con quelli dell'OMS. Si osserva una diminuzione della prevalenza di pazienti con infezione da HIV nel periodo 2016-2019 rispetto al periodo 2000-2015. Lo studio confronta due coorti (2000-2015 e 2016-2019) analizzando parametri come età alla diagnosi, sesso, etnia, localizzazione della malattia, fattori di rischio e co-infezione da HIV. Per lo studio delle resistenze ai farmaci antitubercolari, sono stati considerati solo i pazienti con coltura positiva e con almeno un DST (drug susceptibility test) eseguito. Nel periodo 2016-2019, si è osservato un aumento del numero di ricoveri per tubercolosi, in contrasto con il dato OMS di un calo dell'incidenza in Europa. La discrepanza tra i dati potrebbe essere dovuta a una migliore capacità di monitoraggio dei dati da parte della clinica di malattie infettive del Policlinico rispetto ad altri centri italiani. L'analisi degli outcome mostra un miglioramento nel tasso di guarigione e una riduzione dei pazienti persi al follow-up nel periodo 2016-2019 rispetto al periodo 2000-2015. Infine, si evidenzia che la scarsa compliance al trattamento non dipende dall'etnia o dalla nazionalità dei pazienti. L'analisi dei pazienti con tubercolosi polmonare mostra un'elevata percentuale di pazienti con esame colturale positivo e testati per la farmacoresistenza, ma un'assenza di casi di MDR-TB nella casistica analizzata, a differenza dei dati OMS.
