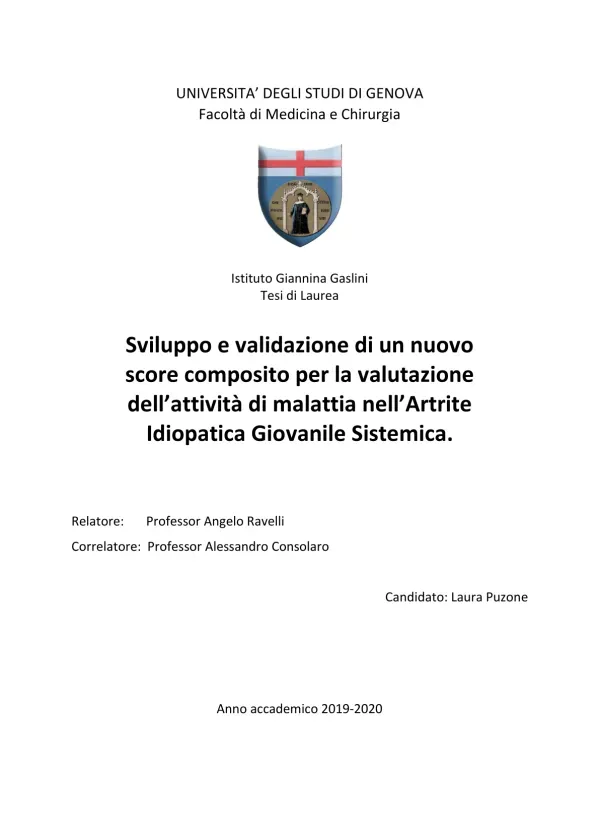
sJADAS: Score per Artrite Giovanile
Informazioni sul documento
| Autore | Laura Puzone |
| Scuola | Università Degli Studi Di Genova, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Istituto Giannina Gaslini |
| Specialità | Medicina e Chirurgia |
| Anno di pubblicazione | 2020 |
| Tipo di documento | Tesi di Laurea |
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 1.89 MB |
Riassunto
I.Validazione dello sJADAS Uno Strumento per la Misurazione dell Attività di Malattia nell Artrite Idiopatica Giovanile Sistemica sAIG
Questo studio presenta la validazione del nuovo sJADAS, uno strumento di scoring per la valutazione dell’attività di malattia nell’artrite idiopatica giovanile sistemica (sAIG). Lo sJADAS, basato sul già noto JADAS, incorpora un nuovo parametro, il Systemic Manifestation Score (SMS), per quantificare le manifestazioni sistemiche extraarticolari. Lo studio, condotto su 163 pazienti in 16 centri internazionali (27 in Italia, con il 23.6% dei pazienti; l'Egitto ne ha il 25.5%; India 22.4%; altri paesi: Brasile, Russia, Thailandia, Argentina, Giordania, Arabia Saudita, Giappone), ha valutato le proprietà metriche dello sJADAS, includendo diverse versioni (con VES, CRP, e senza parametri sierologici). I risultati dimostrano che lo sJADAS è uno strumento semplice, valido e reattivo, superiore agli score utilizzati nell'artrite reumatoide adulta (CDAI, DAS28) e nella malattia di Still dell'adulto (Pouchot score), adatto al monitoraggio dell'andamento clinico e alla risposta alla terapia, supportando l'approccio treat-to-target.
1.1 Sviluppo e Composizione dello sJADAS
Lo studio si concentra sulla validazione dello sJADAS, uno strumento di scoring derivato dal JADAS, ma arricchito con un nuovo parametro: il Systemic Manifestation Score (SMS). Questo SMS è stato aggiunto per quantificare in modo più accurato le manifestazioni sistemiche extraarticolari, spesso presenti nell'artrite idiopatica giovanile sistemica (sAIG). Il punteggio finale dello sJADAS è la somma di cinque variabili: la valutazione globale del medico sull'attività della malattia (VAS), la valutazione del benessere da parte del genitore/paziente (VAS), il conteggio delle articolazioni attive, la VES normalizzata (o CRP in una versione alternativa) e il punteggio SMS (0-10). Sono state testate tre versioni dello sJADAS: sJADAS10-ESR (con VES), sJADAS10-CRP (con Proteina C Reattiva al posto della VES), e sJADAS10-noAPR (senza parametri sierologici). La scelta di includere la CRP è motivata dalla sua maggiore stabilità rispetto alla VES e dalla sua capacità di mantenere un alto valore di alfa di Cronbach anche in assenza di altri parametri. La semplicità e la velocità di calcolo sono caratteristiche fondamentali dello sJADAS, rendendolo uno strumento pratico per l'uso clinico quotidiano.
1.2 Validazione e Proprietà Metriche dello sJADAS
La validazione dello sJADAS ha considerato diversi aspetti cruciali. La praticità d'uso (Feasibility) è stata valutata in termini di brevità, semplicità e facilità di calcolo. La validità di contenuto (Face and Content Validity) è stata verificata analizzando le singole variabili che compongono lo score. La validità di costrutto (Construct Validity) è stata analizzata tramite la correlazione di Spearman tra lo sJADAS e altre misure di outcome non incluse nello score stesso (dolore, capacità funzionale, qualità di vita). I risultati mostrano una buona correlazione (0.41-0.60), migliore per la versione con VES rispetto a quella con CRP o senza parametri sierologici, e comunque superiore a quella di altri strumenti utilizzati nell'artrite reumatoide adulta (CDAI, DAS28) e nella malattia di Still dell'adulto (Pouchot score). La responsiveness, misurata con lo Standardized Response Mean (SRM), risulta eccellente (2.04-2.58), migliore rispetto al JADAS10 e al cJADAS10, e agli strumenti per adulti. L'analisi fattoriale (Factor Analysis) conferma che lo sJADAS misura un singolo costrutto, ovvero il grado di attività di malattia.
1.3 Confronto con Altri Score e Considerazioni Finali
Lo studio ha confrontato le prestazioni dello sJADAS con altri score già consolidati, come il JADAS10 e il cJADAS10, evidenziando una maggiore sensibilità e responsività del nuovo strumento nella valutazione dell'attività di malattia nella sAIG. Il confronto ha incluso anche gli score utilizzati per la valutazione di pazienti adulti affetti da artrite reumatoide (CDAI, DAS28) e Malattia di Still (Pouchot score), dimostrando la superiorità dello sJADAS in termini di proprietà metriche. Sono state considerate anche le diverse versioni dello sJADAS, con e senza parametri infiammatori (VES e CRP), evidenziando le performance superiori della versione con CRP. Nonostante le ottime proprietà metriche dimostrate, il documento riconosce alcuni limiti dello studio, come la valutazione della febbre nelle sole ultime 24 ore (che potrebbe essere ampliata a 3 giorni) e l'esclusione dei pazienti senza febbre tra la sintomatologia extraarticolare. La mancanza di uno studio longitudinale prospettico a lungo termine (oltre i 3 mesi) impedisce una valutazione completa della capacità predittiva dello sJADAS sull'outcome del paziente. Nonostante ciò, lo sJADAS si dimostra uno strumento valido, semplice e maneggevole per la misurazione dell'attività di malattia nella sAIG, adatto sia alla pratica clinica che alla ricerca.
II.Epidemiologia ed Esordio della sAIG
L'artrite idiopatica giovanile sistemica (sAIG) rappresenta il 5-15% dei casi di artrite cronica infantile in Europa e Nord America, ma la sua prevalenza è maggiore in regioni come il sud-est asiatico (India, Thailandia, Giappone: 25-50%). L'incidenza è simile tra maschi e femmine, senza un'età di esordio preferenziale, sebbene alcuni studi segnalino una maggiore frequenza sotto i 5 anni. L'incidenza annua è di 0,4-0,9 casi ogni 100.000 e contribuisce a due terzi della mortalità totale per AIG.
2.1 Prevalenza e Incidenza dell Artrite Idiopatica Giovanile Sistemica sAIG
L'artrite sistemica, una forma distinta di artrite idiopatica giovanile (AIG), rappresenta una percentuale significativa dei casi di artrite cronica infantile. In Europa e Nord America, la sua prevalenza si aggira intorno al 5-15% di tutti i bambini affetti da artrite cronica. Tuttavia, la prevalenza è notevolmente più alta in alcune regioni del Sud-est asiatico, in particolare in India, Thailandia e Giappone, dove raggiunge il 25-50% dei casi totali. Questo dato sottolinea una significativa variabilità geografica nell'incidenza della malattia. L'incidenza della sAIG è simile tra maschi e femmine e non presenta un'età di esordio preferenziale, sebbene alcuni studi indichino una maggiore frequenza nei bambini al di sotto dei 5 anni. Si stima che l'incidenza annua sia compresa tra 0,4 e 0,9 casi ogni 100.000 bambini, con un dato particolarmente rilevante: la sAIG contribuisce da sola a due terzi del tasso di mortalità totale associato all'artrite idiopatica giovanile. Questa informazione evidenzia la gravità e l'importanza di una diagnosi precoce e di un trattamento adeguato.
III.Patogenesi e Biomarcatori della sAIG
La sAIG si distingue per una disregolazione dell'immunità innata, con alterazione dei livelli di citochine proinfiammatorie (TNF-α, IL-1, IL-6, IL-18, E-selectine) e molecole di adesione. A differenza di altre forme di AIG, la sAIG mostra una debole associazione con autoanticorpi (ANA o FR) o fenotipi HLA. Il fattore di inibizione macrofagica MIF è un importante biomarcatore, con livelli sierologici elevati nei pazienti con esordio sistemico e associato a prognosi sfavorevole e alla Sindrome da Attivazione Macrofagica (MAS). La sAIG è sempre più considerata un'entità autoinfiammatoria, piuttosto che autoimmune, con analogie con la Malattia di Still ad esordio adulto (AOSD).
3.1 Patogenesi della sAIG Un Profilo Infiammatorio Distinto
La patogenesi dell'artrite idiopatica giovanile sistemica (sAIG) presenta un profilo infiammatorio differente rispetto ad altre forme di artrite. A differenza delle forme oligo o poliarticolari, la sAIG sembra derivare principalmente da una disregolazione dell'immunità innata, con minore coinvolgimento di autoanticorpi (ANA o FR) o fenotipi HLA. L'assenza di linfociti autoreattivi nei pazienti sistemici suggerisce un ruolo centrale dell'attività dei neutrofili e dei macrofagi nello sviluppo della malattia e delle sue complicanze. Si osserva un'importante alterazione dei livelli circolanti di citochine proinfiammatorie come TNF-α, IL-1, IL-6, IL-18, E-selectine e molecole di adesione intracellulari. Questa peculiarità infiammatoria, insieme alla mancanza di una forte associazione con la classe MHC II, supporta la crescente tendenza a classificare la sAIG all'interno delle malattie autoinfiammatorie, piuttosto che come una classica patologia autoimmune. Questa classificazione è ulteriormente rafforzata dalla forte analogia clinica tra sAIG e la Malattia di Still ad esordio adulto (AOSD), suggerendo una possibile correlazione patogenetica confermata da studi recenti, tanto che oggi si tende a definirle come la stessa malattia con diverso esordio.
3.2 Biomarcatori nella sAIG MIF e altri Indicatori
Diversi biomarcatori sono cruciali nella comprensione e nella gestione della sAIG. Il fattore di inibizione macrofagica (MIF) riveste un ruolo significativo, con livelli sierologici elevati nei pazienti con esordio direttamente sistemico. La presenza di specifici polimorfismi del MIF è considerata un fattore predittivo di esito negativo (poor outcome), correlato alla Sindrome da Attivazione Macrofagica (MAS), una complicanza grave e potenzialmente letale della sAIG. Oltre al MIF, altre alterazioni immunitarie contribuiscono alla patogenesi della sAIG, come l'alterazione dei livelli di citochine proinfiammatorie (IL-6, IL-18, IL-1), proteine come MRP8 e MRP14 (indicative di recidiva o flare), e la presenza di elevati livelli circolanti di IL-2Rα (CD25) e di sCD163, che riflettono l'attivazione e l'espansione dei linfociti T e dei macrofagi. Questi biomarcatori, insieme alle alterazioni genetiche, aiutano a comprendere la perpetuazione della risposta infiammatoria innata caratteristica della sAIG, aprendo la strada allo sviluppo di terapie mirate (target-therapy).
IV.Diagnosi della sAIG
La diagnosi di sAIG è di esclusione, richiedendo l'esclusione di infezioni, neoplasie, altre malattie reumatologiche (malattia reumatica, vasculiti come la malattia di Kawasaki, LES giovanile, artriti reattive), e sindromi autoinfiammatorie (febbre familiare mediterranea). Gli esami includono emocromo (leucocitosi neutrofila, trombocitosi/trombocitopenia, anemia microcitica), analisi di autoanticorpi (tipicamente negativi per FR e ANA), ed indagini strumentali (radiografia, ecografia, RM). La presenza di artrite attiva è necessaria per la diagnosi, mentre manifestazioni extraarticolari all’esordio suggeriscono solo un sospetto diagnostico.
4.1 Diagnosi di Esclusione e Importanza dell Esame Obiettivo
La diagnosi di artrite idiopatica giovanile sistemica (sAIG) è principalmente una diagnosi di esclusione, un processo complesso che richiede l'esclusione di numerose altre condizioni. Il medico deve considerare e scartare attentamente infezioni virali e batteriche (come la malattia di Lyme o la brucellosi), neoplasie con sintomi muscoloscheletrici (leucemie e linfomi), altre malattie reumatologiche infantili (febbre reumatica, vasculiti come la malattia di Kawasaki o la poliarterite nodosa, LES giovanile, artriti reattive), e sindromi autoinfiammatorie (come la febbre familiare mediterranea). Un esame obiettivo completo e accurato è fondamentale, dato il carattere sistemico della malattia. Il bambino deve essere visitato completamente, da testa a piedi, con particolare attenzione all'esame articolare per individuare segni di artrite attiva (tumefazione, dolore, limitazione del range di movimento non meccanica). È importante ricordare che per la diagnosi di sAIG è necessaria la presenza di artrite attiva; la sola presenza di manifestazioni extraarticolari all'esordio permette solo un sospetto diagnostico, in attesa della comparsa di sintomi articolari.
4.2 Esami Ematochimici e Strumentali nella Diagnosi
Gli esami ematochimici svolgono un ruolo cruciale nella diagnosi differenziale della sAIG. L'emocromo spesso rivela una marcata leucocitosi neutrofila (>30.000 cellule/mm³), con spesso trombocitosi, sebbene si possa osservare anche trombocitopenia, soprattutto all'esordio. Un'anemia microcitica ipocromica iposideremica, più grave di quella osservata nell'artrite reumatoide, è un altro dato caratteristico, correlato ai livelli di IL-6. Si possono riscontrare anche livelli aumentati di immunoglobuline, ipoalbuminemia, aumento delle transaminasi e dei trigliceridi. Il crollo della VES, della conta piastrinica e dei globuli bianchi può suggerire l'insorgenza della Sindrome da Attivazione Macrofagica (MAS). L'analisi per la ricerca di autoanticorpi (Fattore Reumatoide e ANA) è negativa nella maggior parte dei pazienti con sAIG, aiutando nella diagnosi differenziale. Le indagini strumentali completano il quadro diagnostico. La radiografia convenzionale, pur rimanendo il gold standard per la rilevazione di alterazioni ossee e danno articolare, ha scarsa sensibilità per l'infiammazione sinoviale iniziale. L'ecografia, esame non invasivo, rapido ed economico, permette invece di diagnosticare sinovite e versamento articolare, guidando anche le iniezioni intraarticolari di corticosteroidi. La risonanza magnetica (RM), pur essendo più efficace per la visualizzazione precoce del danno dei tessuti molli, è meno pratica per l'utilizzo clinico routinario.
V.Decorso e Prognosi della sAIG
Il decorso della sAIG è variabile: monociclico (50%, risoluzione in 1-2 anni) o intermittente. Il restante 50% presenta un decorso persistente, con artrite cronica e gravi danni articolari. Fattori predittivi di prognosi sfavorevole includono la persistenza di sintomi sistemici a 6 mesi, trombocitosi, uso prolungato di corticosteroidi, interessamento delle anche e linfoadenomegalia in bambini <8 anni.
5.1 Decorso Variabile della sAIG Monociclico vs. Persistente
Il decorso della sAIG è caratterizzato da una notevole variabilità individuale. Circa il 50% dei pazienti presenta un decorso monociclico, con risoluzione della malattia entro pochi mesi o al massimo 1-2 anni, oppure un decorso intermittente con fasi di riacutizzazione alternate a periodi di remissione. In questi casi, l'artrite è spesso associata agli episodi febbrili, ma tende a scomparire con il controllo dei sintomi sistemici. La prognosi a lungo termine è generalmente buona per questi pazienti, con limitate conseguenze funzionali a lungo termine. L'altra metà dei pazienti, purtroppo, presenta un decorso persistente della malattia. In questi casi, i sintomi sistemici possono risolversi nel giro di qualche mese o anno, ma l'artrite persiste con un decorso cronico, causando danni articolari significativi. Circa il 30% dei pazienti sviluppa una grave poliartrite cronica, con manifestazioni sistemiche che possono durare fino a 10 anni dalla diagnosi, portando a deformità, osteoporosi e deficit di crescita e funzionalità. Questa forma severa della malattia comporta i maggiori rischi di complicanze a lungo termine.
5.2 Fattori Predittivi di Prognosi Sfavorevole nella sAIG
Diversi fattori possono predire un esito sfavorevole (poor outcome) nella sAIG. La persistenza dei sintomi sistemici oltre i 6 mesi dall'esordio è un indicatore significativo di un decorso più grave e prolungato. La trombocitosi, l'uso prolungato di corticosteroidi, il coinvolgimento delle anche in un contesto di poliartrite, e la presenza di linfoadenomegalia in bambini di età inferiore agli 8 anni sono tutti segnali che suggeriscono una prognosi peggiore. Questi fattori sottolineano l'importanza di un monitoraggio attento e tempestivo dei pazienti con sAIG per identificare precocemente i casi a rischio di un decorso più severo e adottare strategie terapeutiche adeguate per ridurre le complicanze a lungo termine. La comprensione di questi fattori predittivi permette di personalizzare il trattamento e di migliorare la gestione della malattia, con l'obiettivo di raggiungere la remissione clinica e limitare i danni articolari e le disabilità associate a questa condizione.
VI.Terapia della sAIG
Il trattamento della sAIG richiede un approccio multidisciplinare (reumatologo pediatrico, oftalmologo, ortopedico, fisioterapista, psicologo). L'obiettivo è la remissione clinica, con controllo dei sintomi, dolore e disabilità. I corticosteroidi sono utilizzati per manifestazioni sistemiche severe, ma hanno effetti collaterali. Gli inibitori di IL-1R, IL-6R sono utilizzati come terapia mirata, mentre gli inibitori del TNFα hanno minor impiego. Il continue monitoring, con strumenti standardizzati come lo sJADAS, è fondamentale per valutare l'attività di malattia e la risposta alla terapia.
6.1 Approccio Multidisciplinare e Obiettivi Terapeutici
Il trattamento della sAIG richiede un approccio multidisciplinare, coinvolgendo un team di specialisti composto da reumatologo pediatrico, oftalmologo, ortopedico, fisioterapista e psicologo. Questa strategia integrata è necessaria per gestire sia i sintomi articolari che quelli sistemici, garantendo un approccio completo alla cura del paziente. L'obiettivo principale della terapia è il raggiungimento di una remissione clinica completa, con controllo efficace dei sintomi, del dolore e delle limitazioni funzionali. È fondamentale assicurare al bambino un normale sviluppo psicologico e motorio, prevenendo le conseguenze a lungo termine della malattia e del trattamento stesso. Il monitoraggio continuo dell'attività di malattia e della risposta alla terapia, attraverso l'utilizzo di strumenti standardizzati, è parte integrante di questo approccio terapeutico.
6.2 Ruolo dei Corticosteroidi e dei Farmaci Biologici
L'uso di corticosteroidi sistemici nella sAIG è un tema molto dibattuto. Sebbene siano spesso necessari per controllare le manifestazioni sistemiche gravi (in caso di risposta inadeguata ai FANS, anemia severa, pericardite o MAS), presentano importanti effetti collaterali a lungo termine, soprattutto nei bambini in crescita, con rischio di arresto della crescita, osteoporosi e fratture patologiche. L'utilizzo è quindi limitato ai casi più severi. Le iniezioni intraarticolari eco-guidate di corticosteroidi (triamcinolone hexacetonide) sono una pratica comune, soprattutto nelle fasi iniziali della malattia con forme mono o oligoarticolari. Queste iniezioni, pur non essendo curative, offrono un rapido e duraturo sollievo dai sintomi, prevenendo contratture e deformità. Negli ultimi anni, i farmaci DMARDs biologici stanno assumendo un ruolo sempre più importante nel trattamento della sAIG, grazie alla possibilità di una terapia mirata (target-therapy) basata sulla patogenesi della malattia. Inibitori selettivi di citochine e dei loro recettori, come gli inibitori di IL-1R (Anakinra, Canakinumab, Rilonacept), gli inibitori di IL-6R (Tocilizumab), stanno mostrando risultati promettenti, mentre gli inibitori del TNFα trovano minor applicazione nella sAIG, a causa del ruolo meno preponderante del TNF nella sua patogenesi.
6.3 Trattamento di Pazienti con Manifestazioni Sistemiche Senza Artrite Attiva
Un sottogruppo di pazienti con sAIG può presentare manifestazioni sistemiche senza artrite attiva, ad esempio pazienti con artrite risolta spontaneamente o con FANS, ma con persistenza di episodi febbrili. Anche in questi casi, il trattamento richiede una valutazione attenta dell'attività di malattia generale e del numero di articolazioni attive. La persistenza della febbre oltre i 6 mesi dalla diagnosi, elevati marcatori infiammatori e la necessità di terapia prolungata con steroidi sistemici sono considerati fattori prognostici negativi. La scelta terapeutica deve essere personalizzata in base alle caratteristiche cliniche del paziente, con l'obiettivo di raggiungere la remissione dei sintomi e prevenire le complicanze a lungo termine. L'utilizzo di farmaci biologici mirati potrebbe essere particolarmente utile in questi casi, ma la decisione deve essere presa in accordo con lo specialista.
