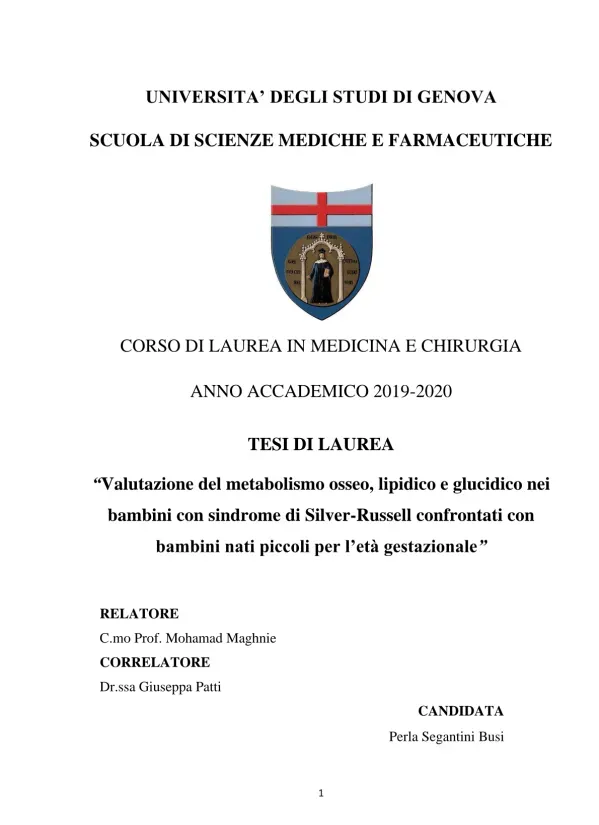
Sindrome Silver-Russell: Metabolismo Osseo
Informazioni sul documento
| Scuola | Università Degli Studi Di Genova, Scuola Di Scienze Mediche E Farmaceutiche |
| Specialità | Medicina E Chirurgia |
| Anno di pubblicazione | 2019-2020 |
| Tipo di documento | Tesi Di Laurea |
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 1.59 MB |
Riassunto
I.Caratteristiche Cliniche della Sindrome di Silver Russell
La Sindrome di Silver-Russell (SRS) si manifesta con una bassa statura sproporzionata, facies caratteristica con viso piccolo e triangolare, fronte prominente e bocca larga con labbra sottili. Queste caratteristiche facciali si attenuano con l'età, ma la statura definitiva rimane ridotta (circa 140 cm nelle femmine e 150 cm nei maschi). Altri sintomi comuni includono clinodattilia del V dito e malformazioni congenite cardiache e genitourinarie (ipospadia e criptorchidismo nei maschi, utero e vagina iposviluppati o assenti nelle femmine). Le anomalie genetiche principali associate sono l'ipometilazione 11p15 e la mUPD7 (disomia uniparentale materna del cromosoma 7), con quest'ultima correlata a una maggiore incidenza di disturbi del linguaggio e dello spettro autistico.
1. Aspetto Facciale e Statura
La Sindrome di Silver-Russell (SRS) è caratterizzata da una facies peculiare: viso piccolo e di forma triangolare, fronte larga e prominente, bocca larga con labbra sottili e angoli rivolti verso il basso. Sebbene l'espressione fenotipica si modifichi durante l'infanzia e l'adolescenza, con le caratteristiche facciali che diventano meno evidenti con l'età, la crescita non recupera completamente. La statura definitiva attesa è significativamente inferiore alla media, attestandosi intorno ai 140 cm per le femmine e 150 cm per i maschi. Questa bassa statura, un elemento chiave nella diagnosi di SRS, rappresenta una delle principali difficoltà per i pazienti affetti da questa sindrome, impattando sulla loro qualità di vita e richiedendo spesso interventi terapeutici.
2. Clinodattilia e Malformazioni Congenite
Oltre alle caratteristiche facciali, la SRS presenta spesso altre manifestazioni cliniche. La clinodattilia del V dito è un segno frequente, così come la presenza di malformazioni congenite. Queste malformazioni interessano prevalentemente il sistema cardiovascolare e genitourinario. Negli individui di sesso maschile, si possono osservare ipospadia e criptorchidismo, mentre nelle femmine si può verificare un iposviluppo o addirittura l'assenza di utero e vagina. L'incidenza di queste malformazioni è maggiore nei pazienti con ipometilazione del cromosoma 11. È importante sottolineare che la presenza di queste anomalie contribuisce alla complessità del quadro clinico della SRS e richiede un approccio diagnostico e terapeutico multidisciplinare.
3. Disturbi Neuropsichici e Difficoltà nello Sviluppo
La Sindrome di Silver-Russell può essere associata a difficoltà nell'apprendimento, disturbi del linguaggio e problemi nell'alimentazione. Questi disturbi neuropsichici sono più frequentemente riscontrati nei bambini con mUPD7 (disomia uniparentale materna del cromosoma 7), una delle alterazioni genetiche associate alla SRS. È fondamentale una valutazione neuropsichiatrica in età prescolare, soprattutto nei bambini con mUPD7, per individuare precocemente eventuali disturbi del linguaggio (disprassia verbale o oromotoria) e disturbi dello spettro autistico. La diagnosi precoce di queste problematiche è essenziale per implementare interventi riabilitativi adeguati e supportare lo sviluppo del bambino, migliorando la sua autonomia e la sua integrazione sociale. Il ritardo motorio può anche essere presente a causa di diverse difficoltà.
II.Diagnosi e Test Genetici per la SRS
La diagnosi di SRS inizia con lo studio di metilazione del gene H19 nella regione 11p15 del cromosoma 11, tramite MS-MLPA. Valori di metilazione borderline richiedono test su tessuti differenti (mucosa buccale o cute). L'ipometilazione con numero normale di CNV conferma la causa epigenetica, mentre la LOM (Loss Of Methylation) associata ad alterazione del numero di CNV indica microdelezione/duplicazione, richiedendo studi CNV sui genitori per valutare il rischio di ricorrenza. È importante escludere altre displasie scheletriche che possono mimare la SRS.
1. Analisi della Metilazione del Gene H19
Il primo passo diagnostico per la Sindrome di Silver-Russell (SRS) è lo studio della metilazione del gene H19 nella regione 11p15 del cromosoma 11. Questa analisi viene eseguita mediante la tecnica MS-MLPA (Methylation-Specific Multiplex Ligation-mediated PCR Amplification), che consente l'analisi parallela del numero di copie e della metilazione del DNA. L'individuazione di un'ipometilazione in presenza di un numero normale di CNV (Copy Number Variations) conferma una causa epigenetica della SRS. Al contrario, una LOM (Loss Of Methylation) associata ad un'alterazione del numero di CNV suggerisce una microdelezione o duplicazione, richiedendo ulteriori indagini genetiche sui genitori per valutare il rischio di ricorrenza della malattia. Questa analisi genetica è fondamentale per una diagnosi precisa e per la valutazione del rischio genetico familiare.
2. Metodiche Alternative e Test su Tessuti Diversi
In caso di valori di metilazione borderline ottenuti con la MS-MLPA, è necessario ricorrere a metodiche alternative e analizzare tessuti differenti. Il testo suggerisce l'utilizzo di un campione di mucosa buccale, prelevato tramite brushing, oppure di un campione di cute, ottenuto mediante biopsia. Questa flessibilità nella scelta del materiale biologico per l'analisi genetica è importante per garantire la precisione della diagnosi, soprattutto in presenza di risultati incerti con il primo test. La scelta del metodo più adatto dipende dalle caratteristiche del paziente e dalle risorse disponibili. L'obiettivo rimane sempre quello di ottenere un risultato diagnostico certo e affidabile per una corretta gestione del caso.
3. Esclusione di Altre Patologie
La diagnosi differenziale della SRS è importante per escludere altre condizioni cliniche che possono presentare sintomi simili. In presenza di bassa statura sproporzionata, è necessario eseguire un'indagine radiologica scheletrica per escludere una displasia ossea. Un'altra patologia da considerare è la Sindrome 3M (OMIM #273750, #612921, #614205), una malattia autosomica recessiva causata da mutazioni nei geni CCDC8, CUL7 o OBSL1. Sebbene alcune caratteristiche fisiche della Sindrome 3M siano simili a quelle della SRS (clinodattilia del V dito, bozze frontali, macrocefalia relativa e facies triangolare), la presenza di pectus excavatum, ipoplasia costale e collo corto permette di differenziarla dalla SRS. Una diagnosi accurata è quindi fondamentale per una gestione clinica appropriata e per evitare trattamenti inappropriati.
III.Terapia con Ormone della Crescita e Risposta al Trattamento
La terapia con ormone della crescita (GH) migliora la prognosi staturale nei bambini con SRS. L'incremento staturale è simile a quello osservato nei bambini SGA non affetti da SRS, anche se la statura definitiva rimane inferiore. La risposta al GH è migliore nei soggetti con mUPD7 o forme idiopatiche rispetto a quelli con ipometilazione di 11p15. L'età e le SDS dell'altezza all'inizio del trattamento sono fattori predittivi della risposta. La dose di GH varia tra 35-70 μg/kg al giorno, cercando di utilizzare la dose minima efficace.
1. Effetti dell Ormone della Crescita sulla Prognosi Staturale
L'utilizzo dell'ormone della crescita (GH) nei bambini affetti da Sindrome di Silver-Russell (SRS) porta a un miglioramento significativo della prognosi staturale. Confronti con bambini nati piccoli per l'età gestazionale (SGA) ma non affetti da SRS mostrano un incremento staturale simile nei due gruppi (incremento medio di 1.30 SDS nei pazienti SRS e 1.26 SDS nei pazienti SGA non-SRS). Nonostante questo incremento, la statura definitiva rimane inferiore nella popolazione affetta da SRS (-2.17 SDS rispetto a -1.65 SDS dei non affetti), a causa di un'altezza pre-trattamento molto inferiore. Lo studio di Smeets et al. [2016] evidenzia una risposta al trattamento migliore nei soggetti con mUPD7 o forme idiopatiche di SRS rispetto a quelli con ipometilazione 11p15, sottolineando l'importanza di considerare le diverse alterazioni genetiche nella risposta alla terapia.
2. Fattori Predittivi della Risposta al Trattamento con GH
L'efficacia della terapia con GH nella SRS è influenzata da diversi fattori. L'età e le SDS dell'altezza all'inizio del trattamento sono elementi fortemente predittivi della risposta a breve e lungo termine, mostrando una correlazione inversa: età e altezza maggiori all'inizio del trattamento predicono un incremento staturale minore. Questo evidenzia l'importanza di iniziare la terapia il prima possibile e di considerare attentamente la condizione del paziente prima di iniziare il trattamento. L'incremento medio della statura si attesta tra +1.2 e +1.4 SDS per dosi di GH comprese tra 35-70 μg/kg al giorno, con la necessità di utilizzare la dose minima efficace per garantire uno sviluppo adeguato. Una valutazione attenta delle caratteristiche individuali del paziente è quindi fondamentale per ottimizzare la terapia.
3. Considerazioni sulla Dosaggio e Monitoraggio del Trattamento
La terapia con GH richiede un attento monitoraggio e una precisa regolazione del dosaggio. È fondamentale utilizzare la minima dose efficace di GH per ottenere un adeguato sviluppo staturale, evitando dosaggi eccessivi che potrebbero avere effetti collaterali. L'obiettivo è massimizzare l'incremento di altezza senza compromettere la salute del paziente. La scelta del dosaggio appropriato deve essere personalizzata in base alle caratteristiche individuali del paziente, considerando fattori come l'età, l'altezza iniziale e la risposta alla terapia. Il monitoraggio regolare della crescita e della risposta alla terapia è quindi essenziale per garantire l'efficacia e la sicurezza del trattamento.
IV.Problematiche Metaboliche e Nutrizionali
Nei primi anni di vita, l'obiettivo principale è assicurare un adeguato apporto calorico, potenzialmente con metodi invasivi, monitorando l'incremento ponderale per prevenire l'obesità e problemi cardiovascolari in età adulta. È importante prevenire le crisi ipoglicemiche, in particolare con l'aggiunta di polimeri di glucosio o amido di mais. In caso di malattia febbrile con chetonuria o ipoglicemia, è necessario il ricovero e la somministrazione di destrosio endovenoso. Per bambini tra 2 e 4 anni, l'obiettivo prima dell'inizio della terapia con GH è un BMI tra 12-14 kg/m² o un peso per altezza al 75-85% del 50° percentile.
1. Apporto Calorico e Metodi di Alimentazione
Una delle principali problematiche nei primi anni di vita dei bambini affetti da Sindrome di Silver-Russell è garantire un adeguato apporto calorico. Questo provvedimento deve essere intrapreso il prima possibile per prevenire deficit staturoponderali e le conseguenze a lungo termine. Potrebbe essere necessario ricorrere a metodiche di alimentazione invasive, che devono essere attentamente monitorate per evitare un incremento di peso corporeo troppo rapido, soprattutto nella prima infanzia, associato ad un aumentato rischio di obesità e problematiche cardiovascolari in età adulta. Un'alimentazione corretta e monitorata è quindi fondamentale per la salute a lungo termine del bambino, richiedendo spesso un supporto nutrizionale specialistico.
2. Prevenzione dell Ipoglicemia e Gestione di Eventi Acuti
La prevenzione delle crisi ipoglicemiche è un obiettivo terapeutico fondamentale nei primi due anni di vita. Per i lattanti con meno di 10 mesi, si può ricorrere all'aggiunta di un polimero di glucosio ad elevato peso molecolare all'alimentazione, mentre per i bambini più grandi è indicato l'amido di mais crudo nell'ultimo pasto serale. In caso di malattia febbrile associata a chetonuria o ipoglicemia, è necessario un ricovero precoce e la somministrazione endovenosa di destrosio al 10%. La dimissione avviene solo quando il bambino è metabolicamente stabile, senza necessità di supporto endovenoso, con assenza di chetonuria per almeno 12 ore e in grado di alimentarsi adeguatamente. Un'attenzione particolare alla gestione di queste situazioni è quindi cruciale per prevenire complicazioni potenzialmente gravi.
3. Obiettivi Terapeutici e Target da Raggiungere
Gli obiettivi terapeutici nei primi due anni di vita comprendono un adeguato supporto nutrizionale, la prevenzione delle crisi ipoglicemiche e il recupero di eventuali deficit staturoponderali correlati a un ridotto apporto calorico. Per i bambini tra i 2 e i 4 anni, prima di iniziare la terapia con ormone della crescita, si deve raggiungere un Body Mass Index (BMI) compreso tra 12 e 14 kg/m² o un peso per altezza pari al 75-85% del peso al 50° percentile. Questi parametri rappresentano dei target importanti per valutare l'adeguatezza dello stato nutrizionale del bambino prima di iniziare altre terapie. Il raggiungimento di questi obiettivi è fondamentale per ottimizzare la risposta alla terapia e ridurre il rischio di complicazioni metaboliche.
V.Sviluppo Puberale e Composizione Corporea negli Individui con SRS
Lo sviluppo puberale nella SRS avviene in epoca fisiologica, ma spesso all'estremità inferiore del range, con possibile adrenarca precoce. Studi dimostrano un avvio puberale anticipato nei soggetti con SRS rispetto agli SGA, con un declino più ripido delle SDS dell'altezza. I nati SGA mostrano spesso una densità minerale ossea inferiore, aumentato rischio di insulino-resistenza, e alterazioni nella composizione corporea, con maggiore massa grassa e minore massa magra rispetto ai nati AGA, soprattutto dopo un catch-up growth. La terapia con GH non sembra influenzare significativamente l'avvio e la progressione puberale.
1. Sviluppo Puberale nella Sindrome di Silver Russell
Lo sviluppo puberale nei soggetti affetti da Sindrome di Silver-Russell (SRS) generalmente avviene in epoca fisiologica, sebbene più verso l'estremità inferiore del range di età. È possibile, tuttavia, osservare una comparsa precoce di adrenarca, definita da un significativo aumento dei livelli sierici di deidroepiandrosterone (DHEAS) >500 ng/ml. Lo studio di Binder et al. (2017) evidenzia un'incidenza di adrenarca precoce del 13% nei soggetti con SRS, percentuale superiore rispetto alla popolazione generale. Smeets et al. (2016) dimostrano un'insorgenza della pubertà significativamente anticipata nei pazienti con SRS rispetto ai controlli SGA (nati piccoli per l'età gestazionale), con una media di 10.2 anni nelle femmine e 11.4 anni nei maschi affetti da SRS, contro 11.2 e 12 anni rispettivamente nei controlli SGA. Nonostante questo anticipo, la maggior parte dei casi (80% dei maschi e 76% delle femmine) rientra nel range fisiologico, seppur precoce rispetto alla popolazione generale. Studi su coorti più ampie, come quello di Hvidt et al. [2019], confermano un anticipo dello sviluppo puberale nei nati SGA, soprattutto nei maschi, anche se la comparsa del bottone mammario nelle femmine non risulta anticipata. L'accelerata maturazione ossea, con chiusura precoce delle epifisi, contribuisce ad una statura definitiva inferiore a quella attesa. Il precoce avvio puberale e la conseguente maturazione ossea compromettono il raggiungimento della statura definitiva prevista.
2. Composizione Corporea e Insulino resistenza
La composizione corporea nei soggetti con SRS presenta anomalie rispetto alla popolazione generale. I nati SGA, che rappresentano la maggior parte dei casi di SRS, mostrano una percentuale di massa magra inferiore rispetto ai nati AGA (appropriate for gestational age), mentre la percentuale di massa grassa è simile nei due gruppi, risultando però più alta negli SGA con catch-up staturoponderale spontaneo. L'aumento di peso nei primi anni di vita influenza la composizione corporea nell'età adulta, con i nati SGA che presentano una percentuale di massa magra inferiore e una percentuale di massa grassa simile o superiore ai nati AGA. La massa grassa nell'adulto è l'unico predittore significativo della sensibilità all'insulina, risultando inferiore nei soggetti nati SGA con catch-up spontaneo rispetto ai controlli. Inoltre, nei soggetti nati SGA che sperimentano un importante incremento di peso nei primi anni di vita, si riscontrano frequentemente un aumento del tessuto adiposo viscerale, ridotta sensibilità all'insulina e livelli elevati di IGF1 tra i 2 e i 4 anni di età, fattori che potrebbero essere correlati al basso peso alla nascita e all'adrenarca precoce. La resistenza insulinica e livelli elevati di IGF1 stimolano la secrezione surrenalica di androgeni, portando a pubarca precoce. Esiste inoltre una correlazione tra peso e BMI all'età di 8 anni e la comparsa del menarca.
3. Effetti della Terapia con Ormone della Crescita sullo Sviluppo Puberale
Diversi studi hanno indagato la relazione tra la terapia con ormone della crescita e lo sviluppo puberale. Lo studio di Boonstra et al. [2003] non ha evidenziato effetti della terapia sull'avvio e la progressione puberale, sull'età del menarca e sull'intervallo tra la comparsa del bottone mammario e il menarca, anche a dosi elevate di GH (2 mg/m²/die). L'incremento di altezza durante la pubertà è risultato maggiore nei bambini con età minore, altezza inferiore e maggiore ritardo dell'età ossea all'inizio della pubertà. Nonostante la crescita puberale totale sia simile nei bambini nati SGA e AGA, lo spurt puberale, pur garantendo un incremento di statura, risulta inferiore all'atteso, probabilmente a causa del precoce avvio puberale e della maturazione ossea accelerata con fusione precoce delle epifisi. La densità minerale ossea (BMD) risulta inferiore nella popolazione nata SGA, con aumentato rischio di insulino-resistenza dopo incremento staturoponderale post-natale; l'aumento improvviso del BMI può stimolare l'avvio puberale.
VI.Studio Osservazionale presso l Istituto Giannina Gaslini di Genova
Lo studio osservazionale prospettico, condotto presso il Day Hospital Auxo-Endocrinologico dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova, ha analizzato pazienti con SRS, confrontandoli con controlli sani nati SGA e AGA. Sono state valutate la composizione corporea (massa grassa e magra, tramite DXA), la densità minerale ossea (BMD), il metabolismo glucidico (glicemia, insulina, HOMA-IR) e il metabolismo lipidico (colesterolo totale, LDL, trigliceridi). Sono state inoltre analizzate l'età di avvio puberale e l'età ossea.
1. Design dello Studio Osservazionale
Lo studio condotto presso il Day Hospital Auxo-Endocrinologico dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova è uno studio osservazionale spontaneo prospettico. La maggior parte dei pazienti coinvolti sono in età evolutiva e sono giunti alla consultazione auxo-endocrinologica per scarso accrescimento, un sintomo tipico della Sindrome di Silver-Russell (SRS). I dati relativi ai controlli sani (nati piccoli e adeguati per l'età gestazionale - SGA e AGA) sono stati raccolti retrospettivamente dalle cartelle cliniche. Questo approccio metodologico, combinando dati prospettici e retrospettivi, permette di analizzare un campione più ampio, ma richiede attenzione nella gestione dei dati per garantire l'affidabilità dei risultati. La scelta dell'Istituto Giannina Gaslini come sede dello studio garantisce un accesso a un elevato numero di pazienti con SRS, data la sua esperienza in ambito auxologico ed endocrinologico pediatrico.
2. Metodi di Valutazione e Analisi Statistiche
Lo studio ha impiegato la tecnica DXA (Lunar Prodigy, version 13, GE Healthcare, Madison, WI) per la valutazione della composizione corporea (massa grassa e magra), analizzando specificamente il tronco, il corpo totale, le gambe e gli arti. La densità minerale ossea (BMD) è stata misurata a livello lombare (L1-L4) con Z-score L1-L4 e a livello del corpo totale con Z-score TBLH. I soggetti con Sindrome di Silver-Russell (SRS), suddivisi in base alle alterazioni molecolari (UPD7 e 11p15 LOM), sono stati confrontati con i controlli sani nati SGA e AGA. Le differenze nelle variabili quantitative sono state valutate tramite il test non parametrico di Mann-Whitney (o test della somma dei ranghi), appropriato per il confronto tra gruppi che non seguono una distribuzione normale dei dati. Questo approccio statistico è stato scelto per gestire adeguatamente la variabilità dei dati clinici e genetici, garantendo la robustezza delle analisi e l'affidabilità delle conclusioni.
VII.Risultati e Discussione Confronto tra Gruppi con Diverse Alterazioni Molecolari
Lo studio ha evidenziato differenze nella composizione corporea, con maggiore massa grassa nei soggetti con SRS e SGA rispetto agli AGA. Sono state osservate differenze nel metabolismo glucidico e lipidico tra i soggetti con SRS, mUPD7 e ipometilazione 11p15, rispetto ai gruppi di controllo. In particolare, i soggetti con 11p15 LOM mostravano una maggiore glicemia basale e valori di HOMA-IR, mentre quelli con mUPD7 presentavano una glicemia basale inferiore. L'età di avvio puberale è risultata significativamente anticipata nei soggetti con SRS, specialmente nel gruppo con 11p15 LOM. Questi risultati sottolineano l'importanza di un follow-up endocrinologico a lungo termine nei pazienti con SRS per monitorare le problematiche metaboliche.
1. Composizione Corporea Confronto tra Gruppi SRS SGA e AGA
I risultati dello studio osservazionale condotto presso l'Istituto Giannina Gaslini di Genova mostrano una composizione corporea anomala nei soggetti con Sindrome di Silver-Russell (SRS), caratterizzata da elevate percentuali di massa grassa totale e massa grassa al tronco. Questi risultati sono in linea con la letteratura e sono simili a quelli osservati nei soggetti nati piccoli per l'età gestazionale (SGA), che presentano livelli di massa grassa al tronco significativamente più elevati rispetto ai controlli nati adeguati per l'età gestazionale (AGA). In particolare, il confronto tra i gruppi di controllo SGA e AGA evidenzia una quantità maggiore di massa grassa al tronco in grammi e una massa magra al tronco in grammi significativamente più alta nei soggetti SGA rispetto agli AGA. Nonostante le anomalie nella composizione corporea, non sono state osservate differenze statisticamente significative riguardo alla massa magra nei soggetti SRS rispetto ai controlli SGA. L'analisi evidenzia quindi una discrepanza nella composizione corporea tra i pazienti con SRS e i controlli, con una maggiore quantità di massa grassa nei primi.
2. Metabolismo Glucidico e Lipidico Analisi dei Gruppi mUPD7 e 11p15 LOM
L'analisi del metabolismo glucidico e lipidico ha rivelato differenze tra i soggetti con le diverse alterazioni molecolari associate alla SRS. I bambini con mUPD7 presentano una glicemia basale media, una glicemia al minuto 120 dell’OGTT e una insulina basale media inferiori rispetto ai controlli nati SGA. Rispetto ai controlli AGA, i bambini con mUPD7 mostrano invece valori maggiori di insulina basale media e HOMA-IR basale medio. Al contrario, i bambini con 11p15 LOM presentano un HOMA-IR basale medio maggiore rispetto ai controlli nati AGA. Per quanto riguarda il metabolismo lipidico, non sono state osservate differenze significative nel profilo lipidico tra i soggetti con SRS e i controlli SGA, mentre si è rilevato un aumento dei livelli plasmatici medi di trigliceridi rispetto ai nati AGA, rimanendo comunque all'interno dei valori normali. L'analisi delle singole alterazioni molecolari non ha evidenziato differenze significative nel metabolismo lipidico, suggerendo che le differenze metaboliche siano principalmente legate ad altri fattori.
3. Sviluppo Puberale Confronto tra Gruppi e Correlazioni
Lo studio ha evidenziato differenze significative nell'età di avvio puberale tra i soggetti con SRS e i controlli SGA, con un avvio mediamente un anno prima nei pazienti con SRS. Anche l'ormone luteinizzante (LH) risulta dosabile mediamente circa un anno e mezzo prima nei soggetti con SRS rispetto ai controlli SGA. Interessante notare come nei soggetti con 11p15 LOM si verifichi una comparsa del menarca mediamente un anno prima rispetto ai controlli, con una forte correlazione tra l'avvio puberale e il peso alla nascita in SD in questo sottogruppo. L'analisi dei dati evidenzia una correlazione tra altezza e BMI all'ultima DXA e la massa grassa corporea nei soggetti con SRS, così come una correlazione tra stadio puberale, BMD e BMC lombare, e BMD totale nei soggetti con mUPD7 e una correlazione tra stadio puberale e percentuale di massa grassa al tronco nei soggetti con 11p15 LOM. Questi risultati suggeriscono un'accelerazione della maturazione ossea e un anticipo dello sviluppo puberale nei pazienti con SRS, soprattutto in relazione all'alterazione genetica 11p15 LOM.
