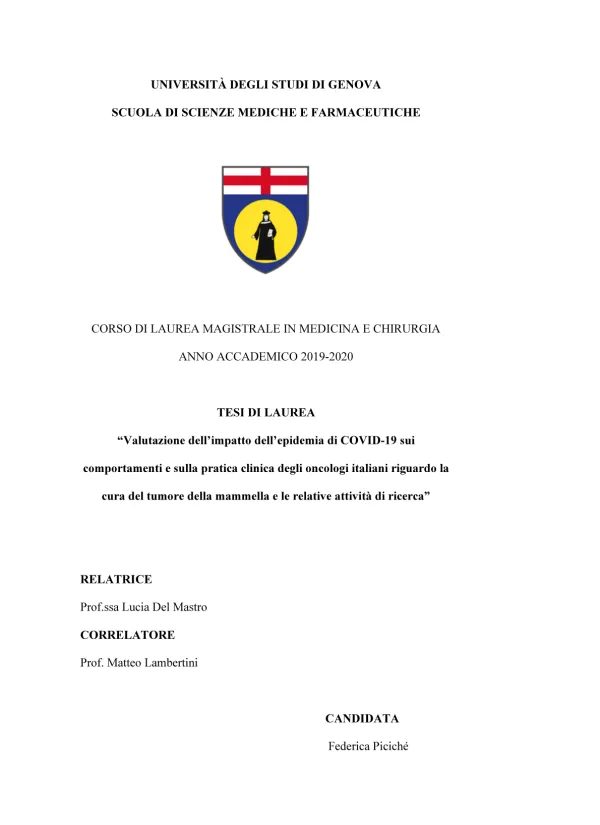
COVID-19 e Tumore al Seno: Impatto sulla Clinica
Informazioni sul documento
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 618.72 KB |
Riassunto
I.L impatto del COVID 19 sulla pratica clinica oncologica nel trattamento del tumore al seno in Italia
Questa ricerca indaga come l'emergenza COVID-19 ha modificato la gestione del tumore della mammella da parte degli oncologi medici italiani. Sono state analizzate le scelte terapeutiche, in particolare per quanto riguarda la chemioterapia (paclitaxel, docetaxel, schemi dose-dense vs standard) e la terapia endocrina (inibitori di CDK4/6), sia nel setting (neo)adiuvante che metastatico. Lo studio, condotto su 165 oncologi (maggioranza donne, 53.3%, molti nel Nord Italia, 73.3% in Breast Unit), ha rivelato significative variazioni nelle pratiche cliniche durante la pandemia, influenzando la scelta dei farmaci e le tempistiche degli esami di imaging. L'obiettivo è valutare il potenziale impatto di queste modifiche sull'outcome dei pazienti.
1. Obiettivi e Metodologia dello Studio
Lo studio si pone l'obiettivo di valutare l'impatto della pandemia da COVID-19 sulla pratica clinica oncologica nel trattamento del tumore al seno in Italia. L'indagine, di natura esplorativa, ha coinvolto 165 oncologi italiani specializzati nella cura del tumore della mammella, selezionati tramite mailing list dell'AIOM (1991 oncologi contattati) e del GIM (210 oncologi contattati). Il campione, considerato adeguato per l'analisi, presentava un'età mediana di 52 anni (IQR 38,0-59,5), una maggioranza di genere femminile (53,3%), una significativa presenza di oncologi che lavorano nel Nord Italia (12,7% in Lombardia e 39,4% al di fuori), e un'alta percentuale (73,3%) che operava all'interno di una Breast Unit. L'esperienza clinica mediana degli oncologi partecipanti era di 23 anni. La raccolta dati è avvenuta tramite questionario a risposta multipla, le cui analisi statistiche sono state condotte con SPSS per Windows, considerando significative le associazioni con P<0.05. L'indagine si focalizza specificamente sul tumore della mammella per ottenere dati più precisi e confrontabili, evitando generalizzazioni a altre neoplasie.
2. Impatto di COVID 19 sulla scelta dei taxani nel setting neo adiuvante
L'analisi dei dati ha evidenziato significative modifiche nelle scelte terapeutiche in relazione all'emergenza COVID-19. Nel setting (neo)adiuvante, si è osservata una riduzione significativa (P<0.001) nell'utilizzo del paclitaxel settimanale, precedentemente il regime preferito, a favore di alternative come il docetaxel ogni tre settimane. Questo cambiamento nella scelta del taxano riflette probabilmente la volontà di ridurre il numero di accessi ospedalieri necessari per il trattamento, limitando così l'esposizione al rischio di contagio da COVID-19. Per quanto riguarda la chemioterapia a base di antracicline (EC, AC, FEC), si è riscontrato un passaggio significativo (P<0.001) da schemi dose-dense a quelli standard. Anche in questo caso, la motivazione principale sembra essere la riduzione del numero di visite ospedaliere, sebbene la chemioterapia dose-dense, pur richiedendo un numero simile di accessi, sia dimostrata più efficace nel migliorare l'outcome delle pazienti. Non sono emerse differenze significative nei comportamenti degli oncologi tra le diverse regioni italiane.
3. Impatto di COVID 19 sulla terapia del tumore al seno metastatico
Anche nel setting metastatico, l'emergenza COVID-19 ha influenzato le decisioni terapeutiche. Si è osservata una riduzione significativa (P=0.002) nell'utilizzo del paclitaxel settimanale, in combinazione con il doppio blocco anti-HER2, come terapia di prima linea nei tumori HER2-positivi. La preferenza si è spostata verso il docetaxel ogni tre settimane, in linea con la tendenza osservata nel setting (neo)adiuvante, a ridurre la frequenza delle visite ospedaliere. Inoltre, si è registrata una diminuzione significativa (P<0.001) nell'utilizzo degli inibitori di CDK4/6 in associazione alla terapia endocrina, con il 50% degli oncologi che non la raccomandava durante l'epidemia. Questo cambiamento potrebbe essere legato sia al rischio di tossicità ematologica, sia alla necessità di controlli ematochimici più frequenti. Anche il monitoraggio del trattamento con inibitori di CDK4/6 è stato ridotto, con una diminuzione dei controlli ematochimici a cadenza bisettimanale e mensile, rispetto alle indicazioni della scheda tecnica. Infine, si è osservato un ritardo nell’esecuzione degli esami di imaging per la valutazione della risposta al trattamento, in particolare nei tumori triplo-negativi (P<0.001).
4. Conclusioni e Considerazioni Finali
L'indagine ha evidenziato un impatto significativo della pandemia da COVID-19 sulla pratica clinica oncologica nel trattamento del tumore al seno in Italia. Le modifiche osservate, pur sembrando ragionevoli per ridurre il rischio di contagio e gli accessi ospedalieri, necessitano di ulteriori approfondimenti per valutare il loro impatto a lungo termine sull'outcome dei pazienti. La riduzione dell'utilizzo di schemi chemioterapici più intensi (dose-dense) e l'adozione di regimi con minore frequenza di somministrazione, sebbene giustificabili in un contesto emergenziale, potrebbero comportare un compromesso sull'efficacia del trattamento. L'indagine sottolinea l'importanza di bilanciare la necessità di ridurre il rischio di contagio con la necessità di garantire la continuità delle cure oncologiche ottimali. È necessario ricercare soluzioni alternative per il monitoraggio dei pazienti, come esami ematochimici in laboratori esterni, colloqui telefonici e consegna a domicilio dei farmaci, per minimizzare gli accessi ospedalieri senza compromettere la qualità delle cure. Inoltre, la pandemia ha avuto un impatto notevole sulla ricerca oncologica, con una riduzione dell'attività dell'80%, sottolineando la complessità della situazione e la necessità di un approccio integrato per garantire sia la sicurezza dei pazienti che la continuità della ricerca.
II.Cambiamenti nella chemioterapia neo adiuvante per il tumore al seno durante la pandemia di COVID 19
Rispetto al periodo pre-pandemia, si è osservata una significativa riduzione nell'utilizzo del paclitaxel settimanale a favore del docetaxel ogni tre settimane nel setting (neo)adiuvante. Anche per la chemioterapia a base di antracicline, si è registrato un passaggio da schemi dose-dense a quelli standard, con conseguente diminuzione degli accessi ospedalieri. Queste modifiche, pur essendo apparentemente motivate dalla necessità di ridurre il rischio di contagio da COVID-19, richiedono un'attenta valutazione del loro impatto sull'efficacia del trattamento e sulla sopravvivenza delle pazienti. La Regione Lombardia, tra le aree più colpite da COVID-19 in Italia, ha mostrato variazioni simili alle altre regioni.
1. Cambiamenti nella scelta dei taxani
L'analisi ha rivelato una significativa variazione nella scelta dei taxani utilizzati nella chemioterapia (neo)adiuvante per il tumore al seno durante la pandemia di COVID-19. In particolare, si è osservata una diminuzione statisticamente significativa (P<0.001) nella preferenza per il paclitaxel settimanale, precedentemente il regime di trattamento più comune. Questa variazione è stata a favore del docetaxel somministrato ogni tre settimane. Questa scelta, dettata dalla necessità di ridurre il numero di accessi in ospedale e quindi il rischio di esposizione al virus, è stata adottata da un numero inferiore di oncologi durante la pandemia rispetto al periodo precedente. Sebbene l'efficacia dei due taxani sia simile, la scelta del docetaxel ogni tre settimane comporta un aumento del rischio di tossicità ematologica, inclusi tassi più elevati di neutropenia febbrile e infezioni. Per mitigare questo rischio, l'utilizzo di una profilassi primaria con fattori di crescita granulocitari potrebbe essere considerato.
2. Modifiche negli schemi di chemioterapia con antracicline
Un altro cambiamento significativo riguarda l'utilizzo della chemioterapia con antracicline in pazienti con tumore al seno precoce e caratteristiche aggressive (linfonodi positivi e/o tumore triplo negativo). Si è osservato un passaggio statisticamente significativo (P<0.001) da schemi dose-dense a schemi standard (intervallo più lungo tra i cicli). Prima dell'emergenza COVID-19, il 58,8% degli oncologi adottava schemi dose-dense, mentre durante la pandemia questa percentuale è scesa al 43%. Le ragioni alla base di questa variazione non sono completamente chiare, anche se la scelta di schemi standard potrebbe essere correlata alla volontà di ridurre gli accessi ospedalieri. Questa decisione è da valutare con attenzione, considerando che gli studi hanno dimostrato che i regimi dose-dense, pur non comportando un aumento significativo del numero di accessi ospedalieri rispetto agli schemi standard, determinano un miglioramento significativo nell'outcome delle pazienti, con una riduzione della neutropenia febbrile rispetto a regimi somministrati ogni tre settimane.
3. Assenza di differenze regionali significative
È importante notare che, nonostante la Lombardia sia stata una delle regioni italiane più colpite dall'epidemia di COVID-19, non sono state osservate differenze significative nei comportamenti degli oncologi riguardo alle scelte terapeutiche nel setting (neo)adiuvante tra la Lombardia e il resto del Nord Italia. Questo dato suggerisce che l'impatto della pandemia sulla pratica clinica è stato piuttosto uniforme a livello nazionale, indipendentemente dall'intensità dell'emergenza sanitaria nella specifica area geografica. La coerenza delle modifiche nelle pratiche cliniche in tutte le aree del Nord Italia indica un cambiamento di approccio generalizzato, probabilmente dettato dalle direttive nazionali e dalle strategie di contenimento della pandemia a livello nazionale, piuttosto che da differenze nell'intensità dell'emergenza locale.
III.Modifiche nella terapia del tumore al seno metastatico durante la pandemia di COVID 19
Nel setting metastatico, l'impatto di COVID-19 sulla scelta del trattamento è risultato evidente. Si è registrata una diminuzione dell'utilizzo del paclitaxel settimanale come terapia di prima linea nei tumori HER2-positivi, a favore di schemi meno frequenti. Inoltre, l'aggiunta di inibitori di CDK4/6 alla terapia endocrina è risultata meno frequente durante la pandemia, così come il monitoraggio ematochimico. Anche in questo caso, le modifiche nelle tempistiche degli esami di imaging sono state significative, con un aumento dei ritardi.
1. Scelta del Taxano in Tumori HER2 positivi
L'epidemia di COVID-19 ha inciso significativamente sulla scelta del taxano nella terapia di prima linea per il tumore alla mammella metastatico HER2-positivo, in combinazione con il doppio blocco anti-HER2 (trastuzumab e pertuzumab). Si è osservata una diminuzione statisticamente significativa (P=0.002) nell'utilizzo del paclitaxel settimanale, con il 41.8% degli oncologi che lo ha prescelto durante la pandemia, rispetto al 53.9% nel periodo precedente. Questa variazione riflette la preferenza per il docetaxel ogni tre settimane, con l'obiettivo di ridurre la frequenza degli accessi ospedalieri e minimizzare il rischio di esposizione al virus. Sebbene l'efficacia del paclitaxel settimanale sia stata dimostrata, la sua somministrazione richiede accessi più frequenti in ospedale rispetto al docetaxel ogni tre settimane. Questa tendenza è risultata particolarmente marcata tra gli oncologi della Regione Lombardia, area fortemente colpita dall'epidemia.
2. Utilizzo degli Inibitori di CDK4 6 e Monitoraggio Ematochimico
L'emergenza COVID-19 ha influenzato anche l'utilizzo degli inibitori di CDK4/6 in associazione alla terapia endocrina, nel trattamento del tumore alla mammella metastatico ormonale-positivo ed HER2-negativo. Si è registrata una diminuzione significativa (P<0.001) nell'adozione di questa combinazione terapeutica durante la pandemia (55.8% vs 80% nel periodo precedente). Questa scelta potrebbe essere motivata da diversi fattori, tra cui il rischio di tossicità ematologica e la necessità di controlli ematochimici più frequenti, con una conseguente maggiore frequenza di accessi ospedalieri. Sebbene l'incidenza di neutropenia febbrile con gli inibitori di CDK4/6 sia bassa, la riduzione dei controlli ematochimici, suggerita dal 30% degli oncologi, potrebbe non essere appropriata, soprattutto per la valutazione della neutropenia. Per ridurre gli accessi ospedalieri senza compromettere il monitoraggio, si suggerisce di implementare sistemi alternativi, come esami in laboratori esterni, colloqui telefonici e consegna a domicilio dei farmaci.
3. Tempistiche per la Valutazione Strumentale
L'epidemia di COVID-19 ha portato a modifiche significative nelle tempistiche per la valutazione strumentale della risposta al trattamento nelle pazienti con tumore alla mammella metastatico. Per i tumori triplo-negativi, si è osservata una significativa tendenza (P<0.001) a ritardare l'esecuzione degli esami di imaging (a 4-6 mesi o più) durante la pandemia (65.5% vs 34.5% nel periodo precedente). Analogamente, si è registrato un ritardo nelle procedure di imaging e nel lavaggio degli accessi venosi centrali. Sebbene manchino evidenze scientifiche a supporto di queste modifiche, esse possono essere considerate ragionevoli per ridurre il numero di visite ospedaliere e l'esposizione al rischio di contagio, ma richiedono una valutazione attenta del loro impatto sull'efficacia del trattamento e sull'outcome del paziente. La necessità di bilanciare la riduzione dei rischi di contagio con la tempestiva diagnosi e monitoraggio rimane cruciale.
IV.Impatto del COVID 19 sulla ricerca oncologica e conclusioni
La pandemia ha avuto un impatto negativo sulla ricerca oncologica, con una riduzione dell'attività di circa l'80%. Lo studio conclude che, pur essendo molti dei cambiamenti nella pratica clinica comprensibili alla luce dell'emergenza COVID-19, è necessario valutare attentamente il loro impatto a lungo termine sulla sopravvivenza e la qualità di vita delle pazienti con tumore al seno. Ulteriori ricerche sono necessarie per comprendere appieno le conseguenze di questi cambiamenti nella gestione del tumore della mammella nel contesto della pandemia e per sviluppare strategie per mitigare i potenziali effetti negativi sull'outcome dei pazienti.
1. Impatto del COVID 19 sulla Ricerca Oncologica
La pandemia da COVID-19 ha avuto un impatto significativo sulla ricerca oncologica, causando una riduzione dell'attività di circa l'80% rispetto al periodo pre-pandemia. Questo dato evidenzia le difficoltà incontrate dagli oncologi nel condurre studi e ricerche durante l'emergenza sanitaria. La riduzione dell'attività di ricerca, come sottolineato nel documento, è un aspetto critico, dato che la ricerca sul cancro è fondamentale per l'avanzamento delle conoscenze e lo sviluppo di nuove terapie. La limitazione delle risorse e l'attenzione prioritaria dedicata alla gestione dell'emergenza sanitaria hanno inevitabilmente compromesso la capacità di condurre studi clinici e ricerche di base, rallentando il progresso in questo settore cruciale per la salute pubblica. Le difficoltà riscontrate sottolineano l'urgenza di sviluppare strategie per mitigare l'impatto negativo delle pandemie sulla ricerca scientifica, garantendo la continuità delle attività di ricerca oncologica anche in situazioni emergenziali.
2. Conclusioni e Considerazioni sull Outcome del Paziente
In conclusione, questa indagine fornisce evidenza dell'impatto dell'epidemia di COVID-19 sulla cura del tumore alla mammella e sulle relative attività di ricerca tra gli oncologi italiani. La maggior parte dei cambiamenti osservati nelle pratiche cliniche, pur essendo risposte ragionevoli all'emergenza sanitaria, necessitano di una valutazione attenta del loro impatto a lungo termine sull'outcome dei pazienti. Sebbene molti cambiamenti nella pratica clinica siano apparsi come risposte ragionevoli all'emergenza, è fondamentale considerare il potenziale rischio che queste modifiche possano condizionare negativamente l'esito della malattia. La riduzione della preferenza per trattamenti più intensi, come la chemioterapia dose-dense, e la scelta di schemi terapeutici meno frequenti, pur motivati dalla riduzione degli accessi ospedalieri, potrebbero comportare un compromesso sull'efficacia del trattamento e sulla sopravvivenza delle pazienti. La ricerca ha evidenziato l'importanza di bilanciare la gestione dell'emergenza sanitaria con la necessità di garantire la continuità delle cure oncologiche ottimali, minimizzando i potenziali effetti negativi sull'outcome dei pazienti.
