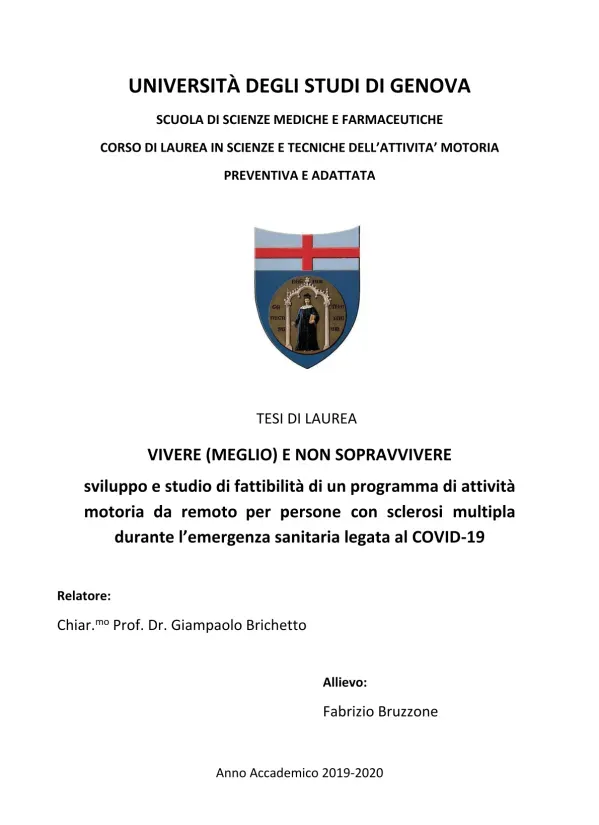
Attività motoria remota per SM
Informazioni sul documento
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 2.12 MB |
Riassunto
I.L impatto del Confinamento sulla Sclerosi Multipla
Questo studio indaga gli effetti del confinamento sociale sulla popolazione affetta da Sclerosi Multipla (SM). L'isolamento, paragonabile a una convalescenza forzata, ha aumentato i rischi di depressione e sindrome ipocinetica, soprattutto negli anziani e nei disabili. Gli adulti hanno mostrato una maggiore resilienza grazie a una maggiore possibilità di movimento per necessità familiari, mentre gli anziani, i bambini e i soggetti con disabilità hanno sperimentato una maggiore riduzione dell'attività fisica, amplificando i rischi connessi alla SM. La riduzione del movimento ha peggiorato lo stato di disabilità in pazienti con SM, specialmente in quelli con un danno neurologico maggiore, aumentando l'atrofia dei sistemi funzionali compromessi dalla malattia. La prevalenza della SM in Italia è stimata intorno a 198 casi ogni 100.000 abitanti, raggiungendo i 370 casi in Sardegna, la regione più colpita.
1. Il Confinamento e la Riduzione dell Attività Fisica
Le misure di confinamento, imposte dalle ordinanze ministeriali per contrastare la pandemia, hanno limitato drasticamente la possibilità di movimento per tutti i cittadini, con eccezione di comprovate necessità. Questa situazione ha costretto molte aziende a chiudere, prolungando l'immobilità forzata. Anche dopo la fine del lockdown, le misure di distanziamento sociale hanno mantenuto un certo livello di restrizione. Tale situazione di immobilità forzata, paragonabile ad una lunga convalescenza, ha rappresentato un fattore di rischio significativo per la salute, in particolare per le persone anziane e disabili, che già presentavano capacità funzionali ridotte. Per queste categorie di persone, la riduzione dell'attività fisica ha aumentato la probabilità di una significativa riduzione dell'umore, con il rischio di sviluppare quadri depressivi o sindrome ipocinetica, soprattutto di tipo cronico. Al contrario, gli adulti, spesso caricati della responsabilità logistica familiare, hanno potuto mantenere un livello di movimento più adeguato, a differenza di anziani, bambini e disabili che hanno sperimentato una drastica riduzione degli spostamenti, esponendosi a maggiori rischi. L'impatto del confinamento sulla salute fisica e mentale delle persone con capacità funzionali limitate, e in particolare su chi soffre di Sclerosi Multipla, è stato quindi un elemento centrale nello studio.
2. L Impatto del Confinamento sulla Sclerosi Multipla
Le persone affette da Sclerosi Multipla, soprattutto quelle con un danno neurologico significativo, hanno risentito particolarmente della riduzione di movimento imposta dal confinamento. Si è osservato un peggioramento dello stato di disabilità, con un aumento dell'atrofia dei sistemi funzionali già compromessi dalla malattia, un aspetto che evidenzia la criticità dell'immobilità prolungata in questa patologia. Il testo cita il caso di Liduina di Schiedam, vissuta tra il 1380 e il 1433, come primo quadro clinico attribuibile alla SM, sottolineando il progressivo deterioramento delle sue condizioni motorie e visive. La prevalenza della Sclerosi Multipla, secondo i dati dell'AISM, si attesta intorno a 198 casi ogni 100.000 abitanti all'anno in Italia, con un picco di 370 casi in Sardegna. Questi dati sono confermati dai PDTA regionali, con valori compresi tra 150 e 210 casi ogni 100.000 abitanti. La discrepanza tra i dati evidenzia la complessità della diagnosi e la necessità di monitoraggio costante. L'analisi dei dati sulla prevalenza fornisce un quadro della diffusione della patologia nel paese, contestualizzando l'importanza dello studio sugli effetti del confinamento su questa popolazione.
II.Eziopatogenesi della Sclerosi Multipla
La Sclerosi Multipla è una malattia autoimmune scatenata da un evento infettivo, probabilmente virale. L'incapacità del sistema immunitario di sviluppare una completa tolleranza immunologica e il riconoscimento a bassa affinità di auto-antigeni (proteine della mielina) da parte dei linfociti T autoreattivi, innescano un processo neuro-infiammatorio. Questo processo danneggia gli oligodendrociti e i neuroni, causando demielinizzazione. La perdita di linfociti regolatori (Treg) aumenta la suscettibilità alle infezioni e contribuisce allo sviluppo della risposta autoimmune. La correlazione tra latitudine e incidenza della malattia potrebbe essere legata alla ridotta esposizione ai raggi solari e alla conseguente diminuzione della sintesi di vitamina D. Un gene, HLA-DRB1*1501, risulta dominante in Nord Europa, dove il rischio di SM è aumentato di 3 volte, e la sua espressione è ridotta dalla vitamina D.
1. La Sclerosi Multipla come Malattia Autoimmune
La sezione sull'eziopatogenesi della sclerosi multipla inizia definendola come una malattia autoimmune, scatenata probabilmente da un'infezione virale. Questo evento innesca un processo neuroinfiammatorio a causa dell'incapacità del sistema immunitario di sviluppare una completa tolleranza immunologica. Il riconoscimento a bassa affinità di auto-antigeni, proteine che costituiscono la mielina, da parte dei linfociti T autoreattivi, è un elemento chiave. Il rilascio di citochine e chemochine pro-infiammatorie porta ad una cascata di eventi immunologici che richiamano linfociti T nel sito dell'infiammazione, aumentando la permeabilità della barriera emato-encefalica. Macrofagi e astrociti attivati dalla microglia danneggiano gli oligodendrociti e, successivamente, i neuroni, causando la demielinizzazione. Studi su animali suggeriscono che specifiche proteine della mielina, opportunamente immunizzate, agiscono come trigger per la risposta immunitaria. Queste proteine attirano linfociti T circolanti che migrano nel sistema nervoso centrale, riconoscendo le proteine mieliniche 'self' e innescando la risposta autoimmune infiammatoria. La descrizione dettagliata del processo infiammatorio, con la sua cascata di eventi a livello cellulare, contribuisce alla comprensione dei meccanismi patogenetici alla base della malattia.
2. Ruolo dei Linfociti T Regolatori e Vitamina D
La perdita di linfociti regolatori, come i Treg (scoperti da S. Sakaguchi nel 1995), gioca un ruolo cruciale nello sviluppo della SM. Questi linfociti sono specializzati nella soppressione dell'attivazione del sistema immunitario verso gli auto-antigeni, mantenendo la tolleranza al self. Una loro riduzione aumenta la suscettibilità alle infezioni e permette ai linfociti autoreattivi di attraversare la barriera emato-encefalica, attivandosi e innescando la risposta autoimmune infiammatoria. Il processo neuroinfiammatorio che ne consegue stimola l'ingresso dei macrofagi, l'attivazione degli astrociti e della microglia, che attaccano gli oligodendrociti, causando demielinizzazione, degenerazione degli assoni e danno neuronale. Un'altra ipotesi correlata all'eziopatogenesi della SM riguarda la correlazione tra latitudine e incidenza della malattia. Si ipotizza un legame tra ridotta esposizione ai raggi solari, ridotta produzione e assorbimento di vitamina D e aumentato rischio di contrarre la patologia. L'analisi di questo fattore ambientale contribuisce a completare il quadro delle possibili cause della SM.
3. Il ruolo del gene HLA DRB1 1501 e il processo di riparazione
Il testo menziona il ruolo del gene HLA-DRB11501, una combinazione allelica dominante nel Nord Europa, dove il rischio di sclerosi multipla è tre volte maggiore. L'espressione di questo antigene è ridotta dalla vitamina D. La minor espressione di HLA-DRB11501 limita l'attivazione dei linfociti T, che in alcuni casi possono scatenare la risposta autoimmunitaria contro le proteine del corpo, in particolare la mielina. Il tentativo di riparazione degli oligodendrociti in risposta al processo infiammatorio è descritto in fasi distinte. Nella fase precoce, gli oligodendrociti tentano di rigenerare la mielina persa, formando una 'placca ombra', ma questo tentativo è inefficacie a causa della progressiva distruzione delle cellule. Successivamente, gli astrociti formano tessuto cicatriziale, e nella fase tardiva, la cicatrice è nettamente delineata e priva di oligodendrociti. La comprensione di questi meccanismi di riparazione, o meglio, di mancata riparazione, è fondamentale per lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche.
III.Sintomi e Disturbi nella Sclerosi Multipla
I sintomi della SM sono variabili, ma i più comuni includono disturbi motori (90% dei casi), che influenzano la deambulazione, la coordinazione e le attività quotidiane; disturbi visivi come neurite ottica, diplopia e nistagmo; disturbi della sensibilità propriocettiva, con ripercussioni sull'equilibrio e la coordinazione; e disturbi cerebellari, con vertigini e atassia. Il dolore neuropatico, descritto come bruciante o urente, è frequente. La fatica è un sintomo invalidante presente nel 95% dei casi, che impatta sulla qualità di vita, sul lavoro e sulle relazioni sociali. La scala EDSS viene utilizzata per misurare lo stato di disabilità.
1. Disturbi Motori nella Sclerosi Multipla
I disturbi motori rappresentano una delle manifestazioni più comuni della sclerosi multipla, colpendo il 90% dei soggetti. Questi disturbi influenzano significativamente la vita quotidiana, incidendo sulla deambulazione, sui cambiamenti posturali e sui movimenti comuni. Le capacità manipolative e comunicative risultano compromesse, con difficoltà nell'articolare le parole (disartria). Le attività strumentali della vita quotidiana, come l'utilizzo dei mezzi pubblici per recarsi al lavoro, possono diventare estremamente difficili. Nei casi più gravi, si possono verificare quadri di tetraplegia con conseguente allettamento e completa dipendenza. L'impatto sulla capacità di svolgere attività lavorative e di mantenere l'autonomia è significativo, sottolineando la gravità di questi disturbi e la necessità di interventi riabilitativi mirati. La descrizione dettagliata delle difficoltà motorie evidenzia l'ampiezza del problema e l'impatto sulla qualità di vita dei pazienti.
2. Disturbi Visivi e Sensibilità Propriocettiva
Tra i disturbi associati alla sclerosi multipla, quelli visivi sono molto frequenti, includendo la neurite ottica, caratterizzata da dolore, alterazioni del campo visivo e calo dell'acuità visiva. L'ispessimento bianco del nervo ottico è evidenziabile alla tomografia. Altri sintomi visivi includono diplopia (visione doppia) e nistagmo, movimenti oscillatori involontari dei bulbi oculari che possono compromettere l'equilibrio. I disturbi della sensibilità propriocettiva, o profonda, derivano da una compromissione dei meccanocettori a livello di aponeurosi, muscoli e ossa. Questi disturbi compromettono la capacità di percepire la posizione degli arti nello spazio (batiestesia), la rapidità dei movimenti (cinestesia), la pressione (barestesia) e le vibrazioni (pallestesia). Le conseguenze sono evidenti ripercussioni sull'equilibrio e sulla coordinazione del movimento, valutabili attraverso test come quello di Romberg. La descrizione dei meccanismi sensoriali coinvolti offre una comprensione più approfondita delle difficoltà che i pazienti affrontano quotidianamente.
3. Disturbi Cerebellari Dolore Neuropatico e Scala EDSS
I disturbi cerebellari si manifestano come vertigini soggettive, sensazione che l'ambiente giri intorno al paziente, causando instabilità. Nei casi più gravi, si possono osservare riduzioni dell'equilibrio statico e dinamico, atassia della marcia, sbandamenti e tremore intenzionale. L'atassia contribuisce all'ipotonia (riduzione del tono muscolare), alla disartria e al nistagmo. Nelle patologie del midollo spinale associate a disturbi cerebellari, come nella SM, si può sviluppare una sindrome atasso-spastica. Il dolore neuropatico, indipendente dagli stimoli o evocato da stimoli inadeguati, è descritto come bruciante, urente, continuo o intermittente. Le disestesie, come il segno di Lhermitte (sensazione di scossa elettrica lungo la colonna vertebrale), sono altre manifestazioni del dolore neuropatico. La scala EDSS, sviluppata dal dottor John Kurtzke, permette di misurare lo stato di invalidità valutando il grado di compromissione di diversi sistemi funzionali: piramidali (movimento), cerebellari (equilibrio), tronco encefalico, sensoriali, intestinali e vescicali. La scala considera anche la distanza di deambulazione, l'uso di dispositivi di assistenza e le capacità di svolgere le attività quotidiane. L'utilizzo della scala EDSS permette una valutazione oggettiva dello stato di disabilità.
IV.Trattamenti e Riabilitazione nella Sclerosi Multipla
I trattamenti per la SM includono gli interferoni-β (prima linea per le forme recidivanti-remittenti), il Copaxone e il Teriflunomide. La riabilitazione è fondamentale per il recupero dell'autonomia e della partecipazione sociale. L'attività motoria, particolarmente utile nelle fasi remissive, integra la riabilitazione, promuovendo l'educazione alla salute e migliorando la qualità di vita. Programmi di attività motoria a distanza sono utili per mantenere i contatti, incentivare l'attività fisica e prevenire l'aumento dei rischi di infortunio. La spesa farmaceutica totale per la SM è significativa (681,8 milioni di euro nel 2018), con una spesa media annua pro capite di 6.574 euro. L'assistenza socio-sanitaria è necessaria per quasi la metà dei pazienti.
1. Trattamenti Farmacologici per la Sclerosi Multipla
Il testo descrive i trattamenti attuali per la sclerosi multipla, sottolineando la variabilità dei sintomi e del decorso della malattia. Mentre alcuni pazienti possono sperimentare attacchi isolati seguiti da remissione completa, altri presentano una demielinizzazione e deficit progressivi. Gli interferoni-β, introdotti nel 1994, sono farmaci di prima linea, agendo da citochine che ottimizzano il sistema immunitario, inibendo la replicazione e diffusione virale e rafforzando le difese immunitarie (linfociti T e macrofagi). Oltre agli interferoni-β (1a e 1b) sintetici, altri farmaci di prima linea indicati per le forme recidivanti-remittenti (RR) includono il Copaxone, un immunomodulatore, e il Teriflunomide, sebbene il meccanismo d'azione di alcuni di questi non sia ancora completamente noto. La scelta del trattamento è personalizzata in base all'andamento della malattia, alla gravità dei sintomi e alla risposta individuale al farmaco. La spesa farmaceutica totale per la SM è di 681,8 milioni di euro (19,4% dei farmaci immunomodulatori e antineoplastici nel 2018), con una spesa media annua pro capite di 6.574 euro, di cui il 17% a carico del paziente. Questo dato sottolinea l'impatto economico significativo della malattia.
2. Riabilitazione e Attività Motoria Un Approccio Integrato
La riabilitazione gioca un ruolo cruciale nel trattamento della sclerosi multipla, mirando al recupero dell'autonomia nelle attività quotidiane, lavorative e alla maggiore partecipazione sociale. Il Progetto Riabilitativo Individuale (PRI) è fondamentale per personalizzare l'intervento. Le attività di prevenzione basate sull'attività motoria enfatizzano l'educazione alla salute, il miglioramento delle relazioni interpersonali e la qualità di vita attraverso la pratica condivisa del movimento. L'attività motoria, però, non sostituisce la riabilitazione ed è indicata principalmente per persone con basso/medio grado di disabilità, soprattutto nelle fasi remissive di un decorso recidivante-remittente. L'attività motoria, quindi, diventa uno strumento complementare alla riabilitazione, integrandosi con essa per raggiungere una migliore gestione della malattia e una maggiore autonomia del paziente. L'accesso ai servizi di assistenza socio-sanitaria è un aspetto fondamentale, con la necessità di assistenza personale nella gestione delle attività familiari richiesta da quasi metà dei soggetti, con un aumento del 30% rispetto al 2013. Il case manager è presente in meno della metà dei centri clinici, raggiungendo quasi il 70% nelle strutture di maggiori dimensioni.
V.Valutazione dell Attività Motoria durante il Confinamento
Lo studio ha valutato l'impatto del confinamento sull'attività fisica e la motivazione dei pazienti con SM. L'80% dei partecipanti ha mantenuto stabili i sintomi della SM durante il confinamento, mentre il 90% ha continuato a praticare attività motoria. La motivazione principale per l'attività fisica è stata il desiderio di godere dei benefici per la salute (media 7/10). Il questionario MSWS-12 ha mostrato un impatto complessivamente minimo della malattia sulla capacità di camminare nell'80% dei partecipanti. I test di equilibrio hanno dato risultati positivi nell'86% dei casi. L'obiettivo è di incentivare l'attività fisica, anche a distanza, per contrastare i sintomi della SM, migliorare la qualità della vita e prevenire l'isolamento sociale.
1. Livelli di Attività Fisica durante il Confinamento
Lo studio ha indagato la pratica di attività motoria in persone con sclerosi multipla durante il periodo di confinamento. Il 90% del campione ha confermato di aver svolto attività fisica, con il 56% che ha praticato attività aerobica almeno tre volte a settimana. Tuttavia, solo il 40% ha raggiunto i 150 minuti settimanali di attività fisica a bassa intensità raccomandati dall'OMS, mentre il restante 60% ha riportato sessioni di attività motoria superiori ai 30 minuti. L'analisi evidenzia una discrepanza tra la volontà di mantenere l'attività fisica e il raggiungimento delle linee guida OMS, suggerendo la necessità di strategie per incentivare una maggiore adesione alle raccomandazioni. È importante sottolineare che, nonostante il confinamento, nell'80% dei casi i sintomi legati alla sclerosi multipla sono rimasti stabili. Tuttavia, si sono registrati casi di recidiva (trattata con corticosteroidi) e di riduzione dei sintomi, evidenziando la variabilità individuale della risposta alla situazione di isolamento e la necessità di ulteriori approfondimenti sugli effetti farmacologici.
2. Valutazione dell Equilibrio e dell Impatto sulla Debulazione
La valutazione dell'equilibrio è stata condotta su 9 partecipanti utilizzando il test FSST, registrando una media di 6,8 secondi (DS= 2,3 sec). Questi risultati, inferiori di 2 secondi rispetto ad altri studi su soggetti con SM di età e grado EDSS comparabili, indicano una compromissione dell'equilibrio dinamico. Per l'80% dei partecipanti, l'impatto della malattia sulla capacità di camminare, misurato con il questionario MSWS-12, è risultato complessivamente minimo (MSWS-12= 17/60, DS= 10). La valutazione dell'equilibrio attraverso 5 test ha dato risultati positivi nell'86% delle prove (durata di almeno 20 secondi), con il test di equilibrio monopodalico destro che ha registrato il maggior numero di insuccessi (3 su 50). Si è osservato un aumento di sintomi non correlati alla malattia (tosse secca e febbre) in 2 casi su 10, attribuibile al periodo invernale. Questi dati offrono informazioni importanti sulla condizione fisica dei partecipanti, evidenziando punti di forza e fragilità in relazione alla malattia e al confinamento.
3. Motivazioni all Attività Fisica e Gestione della Fatica
L'analisi delle motivazioni all'attività fisica, basata su un punteggio attribuito a domande specifiche, ha rivelato che la motivazione più forte (media 7/10, DS= 3,7) è il desiderio di godere dei benefici dell'attività motoria. La ricerca della prestazione (media 6,8/10, DS= 3,7) e la riduzione della sintomatologia dolorosa (media 6,6/10, DS= 3,8) sono risultati altrettanto importanti. Obiettivi come il dimagrimento (media 5,2/10, DS= 3,9) e la partecipazione a competizioni sportive (media 4,2/10, DS= 4) sono risultati meno rilevanti, sebbene importanti per chi pratica sport agonistico. La sensazione di calo energetico prima dell'attività ha ottenuto un punteggio medio di 3,7/10 (DS= 3,1). L'analisi evidenzia una possibile correlazione tra questa sensazione e la fatica primaria della SM: maggiore la stanchezza, minore la percezione di infondatezza del calo energetico. Questi aspetti richiedono ulteriori approfondimenti su un campione più ampio. I progetti di attività motoria da remoto sono considerati strumenti utili per mantenere la motivazione, contrastare i sintomi e prevenire infortuni.
