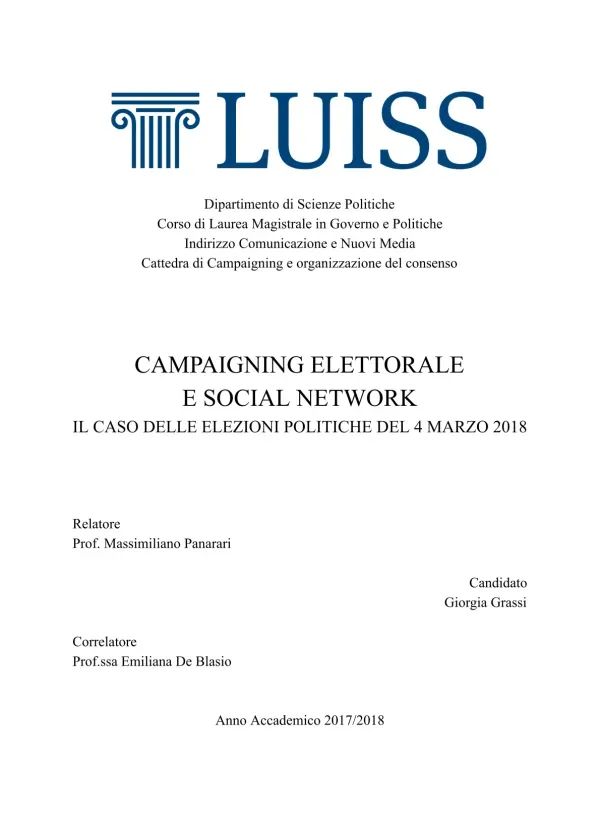
Campaigning 2018: Social Media & Voto
Informazioni sul documento
| Autore | Giorgia Grassi |
| instructor/editor | Prof. Massimiliano Panarari |
| school/university | Dipartimento di Scienze Politiche, Corso di Laurea Magistrale in Governo e Politiche Indirizzo Comunicazione e Nuovi Media |
| subject/major | Governo e Politiche Indirizzo Comunicazione e Nuovi Media |
| Tipo di documento | Tesi di Laurea Magistrale |
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 7.29 MB |
Riassunto
I.Il Contesto Normativo delle Elezioni Politiche del 2018 e il Finanziamento ai Partiti
Questo studio analizza le elezioni politiche italiane del 4 marzo 2018, focalizzandosi sull'applicazione della nuova legge elettorale e sulla normativa sul finanziamento ai partiti. Viene esaminato il ruolo del 2x1000 nel 2017 (basato sui dati del 2016) e le diverse strategie di fundraising adottate dai partiti, come quelle del Partito Democratico (con iniziative come l'Azione del Giorno) e del Movimento 5 Stelle (con la lotteria dei premi in Valle d'Aosta). Si evidenziano i limiti normativi in termini di trasparenza e rendicontazione, con particolare attenzione alle fondazioni politiche private, il cui numero è cresciuto esponenzialmente tra il 2015 e il 2017 (da circa 65 a 102), mostrando una carenza di trasparenza. Le Linee guida AGCOM per le elezioni del 2018, che si concentrano su par condicio, trasparenza pubblicitaria, contenuti illeciti e fact-checking, vengono analizzate, sottolineando la necessità di garantire la parità di accesso anche sulle piattaforme digitali.
1. Il Contesto Normativo delle Elezioni del 2018
Il capitolo iniziale ricostruisce il quadro normativo delle elezioni politiche italiane del 4 marzo 2018, focalizzandosi sull'inedita applicazione contemporanea della nuova legge elettorale e della normativa sul finanziamento dei partiti. Si evidenzia la peculiarità di queste elezioni, proprio per l'entrata in vigore di queste due nuove norme, che ha modificato profondamente il panorama elettorale. L'analisi evidenzia, inoltre, come le critiche alla legge elettorale, in particolare per l'assenza di una maggioranza di governo omogenea, non siano imputabili esclusivamente al sistema elettorale adottato. L'agenzia Youtrend, nel suo blog, ha infatti dimostrato che anche con sistemi elettorali diversi (tedesco, spagnolo, greco, first-past-the-post, Mattarellum, Porcellum, Italicum, francese), la formazione di una maggioranza monocolore sarebbe risultata difficoltosa, dato il risultato elettorale ottenuto. La peculiarità del voto del 2018, quindi, non è da imputarsi unicamente al nuovo sistema elettorale, ma anche ai risultati elettorali stessi, confermando il principio che nessuna legge elettorale può prescindere dai risultati ottenuti alle urne. L'analisi approfondisce anche le criticità della nuova legge, mettendo in luce le sue lacune principali.
2. Il Finanziamento dei Partiti e le Strategie di Fundraising
La sezione analizza in dettaglio la nuova normativa sul finanziamento dei partiti, concentrandosi sui dati relativi al 2x1000 del 2017 (basati sui dati dell'anno di imposta 2016). Vengono esaminate le diverse strategie di fundraising adottate dai partiti durante la campagna elettorale del 4 marzo 2018, evidenziando la forte sinergia tra comunicazione politica e raccolta fondi. Sono state prese in considerazione, ad esempio, l'Azione del Giorno del Partito Democratico e la lotteria del Movimento 5 Stelle in Valle d'Aosta, come esempi di strategie comunicative volte a mobilitare e coinvolgere gli elettori, integrandole con la richiesta di fondi. Il documento sottolinea inoltre i limiti della normativa in termini di trasparenza e rendicontazione, segnalando l'assenza di prescrizioni per i candidati e per le fondazioni politiche private. Un dossier di OpenPolis evidenzia la crescita esponenziale del numero di fondazioni politiche private (da circa 65 nel 2015 a 102 nel 2017), con una significativa mancanza di trasparenza riguardo a statuti, bilanci e finanziatori. Questa mancanza di regolamentazione rappresenta una lacuna normativa significativa nell'ambito del finanziamento politico.
3. Le Linee Guida AGCOM per le Elezioni del 2018
La parte dedicata alle Linee guida dell'AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) per le elezioni politiche del 2018 si concentra sui punti fondamentali: parità di accesso ai mezzi di informazione (par condicio), trasparenza dei messaggi pubblicitari elettorali, gestione di contenuti illeciti o vietati (come i sondaggi), il silenzio elettorale e il fact-checking. La legge sulla par condicio (l. n. 28 del 2000) già garantisce la parità di accesso ai media tradizionali; le linee guida estendono questa richiesta anche alle piattaforme digitali, pur lasciando ampia autonomia a queste ultime. L'AGCOM auspica inoltre che la segnalazione del committente elettorale, già prassi per i media tradizionali, venga estesa al mondo online, che vengano implementati meccanismi di segnalazione, rimozione e sanzione dei contenuti illeciti online, e che venga esteso online il divieto di diffusione di propaganda elettorale nel periodo di silenzio elettorale. Infine, l'Autorità raccomanda il rafforzamento delle iniziative di fact-checking durante la campagna elettorale. Queste linee guida mostrano la complessità di regolare la comunicazione politica nell'era digitale, cercando di bilanciare la libertà di espressione con la necessità di garantire trasparenza e correttezza.
II.L Analisi dei Risultati Elettorali e la Legge Elettorale
Lo studio valuta l'impatto della nuova legge elettorale sui risultati elettorali del 2018, analizzando l'impossibilità di formare una maggioranza monocolore anche con altri sistemi elettorali (tedesco, spagnolo, greco, first-past-the-post, Mattarellum, Porcellum, Italicum, francese), come dimostrato da un articolo di Youtrend. Vengono inoltre evidenziate le lacune normative: la legge si applica solo ai partiti che richiedono il finanziamento del 2x1000, escludendo candidati e fondazioni private, e non prevede codici di condotta.
1. L Impatto della Legge Elettorale sui Risultati del 2018
Questa sezione analizza criticamente l'impatto della legge elettorale del 2018 sui risultati elettorali, concentrandosi sulla mancata formazione di una maggioranza di governo omogenea. Il punto centrale è dimostrare che la difficoltà nel formare una maggioranza monocolore non è imputabile esclusivamente al nuovo sistema elettorale, ma anche ai risultati elettorali stessi. A sostegno di questa tesi, il documento cita un articolo di Youtrend che confronta i risultati del 2018 con quelli ipotetici ottenuti con diversi sistemi elettorali (tedesco, spagnolo, greco, first-past-the-post, Mattarellum, Porcellum, Italicum, francese). L'analisi di Youtrend conclude che, indipendentemente dal sistema elettorale utilizzato, la formazione di una maggioranza monocolore sarebbe stata comunque problematica, data la frammentazione del voto. Questa analisi evidenzia l'importanza di considerare i risultati elettorali come un fattore determinante nella formazione del governo, indipendentemente dal sistema elettorale in vigore. In altre parole, la legge elettorale, pur influente, non è l'unico fattore determinante nella composizione della maggioranza parlamentare.
2. Lacune Normative e Mancanza di Trasparenza
La sezione prosegue evidenziando tre principali lacune della legge elettorale. In primo luogo, le prescrizioni si applicano solo ai partiti che richiedono il finanziamento del 2x1000, escludendo candidati e fondazioni politiche private. Questo crea una disparità di trattamento e una mancanza di regolamentazione per un settore significativo del finanziamento politico. In secondo luogo, la normativa non include prescrizioni specifiche per i candidati, limitandosi a disciplinare il finanziamento ai partiti. Questa mancanza di regolamentazione lascia un vuoto normativo che potrebbe compromettere la trasparenza delle campagne elettorali. In terzo luogo, manca qualsiasi riferimento a codici di condotta, lasciando spazio a possibili comportamenti non etici e poco trasparenti. Il dossier di OpenPolis sulle fondazioni politiche private evidenzia ulteriormente il problema della trasparenza: tra le 102 fondazioni esistenti nel 2017 (un incremento esponenziale rispetto alle circa 65 del 2015), solo una piccola percentuale pubblica informazioni essenziali come statuto, bilancio ed elenco dei finanziatori. Questa mancanza di regolamentazione e trasparenza rappresenta un'importante criticità del sistema di finanziamento politico italiano.
III.L Interazione tra Fundraising e Comunicazione Politica
Si evidenzia la forte sinergia tra fundraising e comunicazione politica, sia a livello professionale (competenze necessarie nei team di campagna) che strategico. La nuova legge sul finanziamento dei partiti è vista come un'opportunità per i partiti di presentarsi come un'opzione di investimento valida per gli elettori. Il ruolo della comunicazione nel sostenere le operazioni di fundraising è analizzato, con un focus su come i partiti possono utilizzare la raccolta fondi per riconnettersi con il territorio e contrastare la sfiducia degli elettori nelle istituzioni.
1. La Sinergia tra Fundraising e Comunicazione Politica
Il documento evidenzia una forte sinergia tra le attività di fundraising e la comunicazione politica, sia dal punto di vista professionale che strategico. Questa interconnessione è fondamentale per il successo delle campagne elettorali. A livello professionale, la sinergia si traduce nella necessità di integrare figure professionali specifiche nei team di campagna, capaci di gestire sia la comunicazione che la raccolta fondi. A livello strategico, la comunicazione politica può essere utilizzata efficacemente per supportare le iniziative di fundraising, creando un legame diretto tra la comunicazione del messaggio politico e la richiesta di contributi finanziari. La nuova legge sul finanziamento dei partiti viene presentata come un'opportunità e una sfida per i partiti, spingendoli a sviluppare strategie innovative per attrarre investitori tra gli elettori, trasformando il fundraising in una vera e propria attività di investimento. Come esempio vengono citati casi studio specifici: l'Azione del Giorno del Partito Democratico e la lotteria del Movimento 5 Stelle in Valle d'Aosta, entrambi esempi di come la comunicazione possa essere efficacemente integrata alle strategie di raccolta fondi.
2. Fundraising come Strumento di Ricostruzione del Rapporto con il Territorio
Il documento approfondisce il rapporto tra fundraising e comunicazione politica, richiamando lo studio di Ripoli e Picilli. Quest'ultimo evidenzia due punti chiave: il primo è la capacità dei partiti di sfruttare le strategie di raccolta fondi per riconnettersi con il territorio, recuperando la fiducia degli elettori spesso sfiduciati dalle istituzioni. Il fundraising, in questo contesto, non è solo una questione di finanziamento, ma un mezzo per instaurare un dialogo diretto e coinvolgente con la popolazione. Il secondo punto fondamentale sottolineato da Ripoli e Picilli è il ruolo di supporto che la comunicazione politica svolge nel processo di fundraising. Una strategia di comunicazione ben studiata è in grado di amplificare l'impatto delle iniziative di raccolta fondi, persuadendo gli elettori a contribuire e a sentirsi parte attiva del progetto politico. In sintesi, il fundraising viene presentato non solo come un'esigenza finanziaria, ma come uno strumento strategico per rafforzare il legame tra i partiti e il territorio, incrementando la fiducia e il coinvolgimento degli elettori.
IV.L Analisi dei Programmi Elettorali
L'analisi dei programmi elettorali si basa su diversi strumenti: il tool "Temi" di Facebook, in collaborazione con Censis e il centro LUISS, che ha coinvolto 19 temi; lo strumento di Repubblica, basato sui programmi depositati al Ministero dell'Interno; e lo studio dell'Istituto Cattaneo, basato sul metodo del Comparative Manifesto Project (CMP), che ha analizzato la concretezza delle proposte politiche dei diversi partiti, rivelando che Casapound aveva la percentuale più alta di proposte concrete.
1. Analisi Comparativa di Strumenti per l Analisi dei Programmi
La sezione descrive diversi strumenti utilizzati per analizzare i programmi elettorali dei partiti in vista delle elezioni del 2018. Il primo strumento analizzato è il tool "Temi" di Facebook, sviluppato in collaborazione con il Censis e il centro LUISS. Questo strumento permetteva ai partiti di esporre le proprie posizioni su 19 temi predefiniti, con la possibilità di aggiungere un tema libero e di integrare brevi video (anche se nessun partito ha scelto questa opzione). Un secondo strumento di analisi è stato quello realizzato da Repubblica, basato sui programmi ufficiali depositati al Ministero dell'Interno. A differenza del tool di Facebook, i dati di Repubblica non sono stati raccolti direttamente dai partiti, ma estratti dai documenti ufficiali, con l'eccezione del programma del M5S sulla qualità della vita e quello del PD. Si sottolinea la scelta di raggruppare le proposte del centrodestra, dato che il programma depositato era unico per i quattro partiti della coalizione. Infine, viene descritto il lavoro dell'Istituto Cattaneo, che ha utilizzato il metodo del Comparative Manifesto Project (CMP) per analizzare le unità lessicali utilizzate dai partiti per esprimere i concetti politici, distinguendo tra proposte concrete e affermazioni generali. Lo studio evidenzia che Casapound ha mostrato la maggiore percentuale di affermazioni concrete, a differenza degli altri partiti che hanno prevalentemente utilizzato affermazioni generali.
2. Analisi della Concretezza delle Proposte Politiche
L'analisi dell'Istituto Cattaneo, basata sul Comparative Manifesto Project (CMP), si concentra sulla differenziazione tra proposte politiche concrete e affermazioni generali nei programmi elettorali. L'obiettivo era di verificare la frequenza di ciascun tipo di affermazione. I risultati evidenziano una significativa discrepanza tra i partiti: Casapound si distingue per una percentuale di affermazioni generali inferiore al 35%, a differenza degli altri partiti, che oscillano tra il 70% e l'80%, con solo il 25% di proposte concrete. L'analisi prosegue esaminando i settori politici in cui le affermazioni generali sono più frequenti. Ambiente, Lavoro, Europa e politica estera sono i settori in cui i partiti hanno utilizzato meno proposte concrete (solo il 20%). Questo dato evidenzia una tendenza generale a preferire enunciati generali a programmi dettagliati e specifici, con Casapound come eccezione notevole. Questa analisi fornisce un'indicazione sulla chiarezza e sulla concretezza delle proposte dei diversi partiti, offrendo un ulteriore elemento di valutazione dei programmi elettorali.
V.Il Ruolo dei Social Media e il Microtargeting nella Campagna Elettorale
Lo studio approfondisce l'impatto dei social network sulla campagna elettorale del 2018, analizzando l'utilizzo di Facebook e Twitter da parte dei leader dei principali partiti (Berlusconi, Renzi, Salvini, Di Maio). Viene esaminato il fenomeno del microtargeting, evidenziando i suoi potenziali rischi, come la manipolazione dell'opinione pubblica e la diffusione di dark ads. Si fa riferimento al caso di Cambridge Analytica e alle sue implicazioni per la privacy, confrontandolo con la campagna di Obama del 2008. Si analizza anche l'influenza dei bot nella manipolazione dei flussi informativi online.
1. L Utilizzo dei Social Media da parte dei Leader di Partito
Questa sezione analizza il ruolo dei social media, in particolare Facebook e Twitter, nella campagna elettorale del 2018. L'attenzione si concentra sull'attività online dei principali leader di partito: Berlusconi, Renzi, Salvini e Di Maio. L'analisi non si limita alla semplice presenza online, ma approfondisce il tipo di contenuti pubblicati, cercando di individuare eventuali correlazioni tra questi contenuti e gli eventi di cronaca che hanno caratterizzato le settimane precedenti al voto. Si evidenzia, ad esempio, la connessione tra i post pubblicati online dai leader e fatti di cronaca come gli eventi di Macerata, lo scandalo Rimborsopoli, o altri eventi di rilevanza nazionale. L'analisi considera anche la crescita giornaliera dei follower su queste piattaforme, come indicatore dell'impatto della strategia comunicativa sui social media. In sintesi, la sezione mira a valutare l'efficacia delle strategie di comunicazione digitale dei leader politici nell'influenzare l'opinione pubblica e nel raggiungere gli elettori.
2. Microtargeting e le sue Implicazioni
La sezione approfondisce il tema del microtargeting, una strategia di comunicazione politica basata sulla segmentazione molto precisa degli elettori per veicolare messaggi personalizzati. Vengono descritte le potenziali attività che possono essere svolte utilizzando i dati raccolti tramite microtargeting, ad esempio, telefonate, porta a porta, pubblicità online (social media advertising e dark advertising), email, posta tradizionale e SMS. Il microtargeting, pur offrendo la possibilità di raggiungere in modo efficace specifici segmenti elettorali, presenta anche rischi significativi, come la possibilità di manipolare l'opinione pubblica e di ridurre la partecipazione elettorale (turnout) tramite l'astensionismo. Il documento cita l'esempio della campagna elettorale di Donald Trump del 2016, in cui si ipotizza l'utilizzo di dark ads per scoraggiare il voto degli elettori afroamericani. La definizione di dark ads, tratta dal progetto Who Targets Me, sottolinea la loro natura occulta: pubblicità visibili solo al target selezionato. La sezione conclude sottolineando che i rischi del microtargeting, pur essendo reali e gravi, non devono essere sovrastimati nel contesto europeo, a causa di normative più stringenti sulla privacy, sistemi politici pluripartitici e budget di campagna limitati.
3. Il Caso Cambridge Analytica e il Breach of Trust
Il documento approfondisce il caso Cambridge Analytica, mettendo in luce le implicazioni del microtargeting applicato alla politica. Si evidenzia il doppio standard nell’approccio mediatico al caso Cambridge Analytica rispetto alla campagna di Obama nel 2008, dove l'uso simile di dati degli utenti è stato accolto con entusiasmo. Si sottolinea, tuttavia, che i dati di Cambridge Analytica sono stati raccolti in violazione del contratto di utilizzo, a differenza della campagna di Obama, che dichiarava di aver raccolto solo nome e città degli utenti. La conclusione dell'analisi è che il caso Cambridge Analytica rappresenti più un ‘breach of trust’ che un ‘data breach’, ovvero una violazione della fiducia degli utenti piuttosto che una violazione informatica. Si evidenzia, infine, che gli eventi successivi al caso (deposizione di Zuckerberg, crollo del titolo Facebook, attacchi a Cambridge Analytica) si sono svolti principalmente nel contesto di un “caso mediatico”, in attesa di eventuali sviluppi giudiziari che potrebbero chiarire ulteriormente le modalità di utilizzo dei dati da parte dell'azienda.
VI.Eventi Chiave e Cronaca Nera nella Campagna Elettorale
Vengono descritti alcuni eventi chiave che hanno influenzato la campagna elettorale, come il caso Spelacchio (albero di Natale di Roma), le vicende giudiziarie che hanno coinvolto la sindaca Raggi, il caso Rimborsopoli che ha colpito il Movimento 5 Stelle, e gli eventi di Macerata, con la morte di Pamela e l'attentato razzista di Luca Traini, legato alla Lega. Questi eventi hanno avuto un impatto significativo sull'agenda mediatica e sulle strategie comunicative dei partiti.
1. L Incidente di Spelacchio e le Vicende Giudiziarie di Virginia Raggi
Il periodo di campagna elettorale è stato segnato da diversi eventi mediatici rilevanti. Tra questi, spicca il caso “Spelacchio”, l'albero di Natale di Roma selezionato dalla sindaca Virginia Raggi, che ha generato un ampio dibattito politico, con critiche al suo operato e alla gestione dell’amministrazione capitolina. L'evento, inizialmente considerato di scarsa importanza, ha assunto una rilevanza politica inaspettata, diventando oggetto di satira e di scontri tra i diversi partiti. Inoltre, le vicende giudiziarie legate alla nomina di Marra e Romeo, dalla richiesta del giudizio immediato all'archiviazione dell'indagine, hanno rappresentato un tema rilevante durante la campagna elettorale, influenzando l'immagine della sindaca e, di conseguenza, il dibattito politico. Questi episodi dimostrano come eventi apparentemente minori possano assumere un'importanza significativa nel contesto di una campagna elettorale, influenzando l'opinione pubblica e le strategie comunicative dei diversi partiti. L’apparente banalità di alcuni eventi non impedisce la loro strumentalizzazione nel dibattito pubblico, a conferma della complessità della comunicazione politica.
2. Il Caso Rimborsopoli e le Strategie del Movimento 5 Stelle
All'inizio di febbraio, il Movimento 5 Stelle ha dovuto affrontare il caso “Rimborsopoli”, emerso a seguito di un servizio de Le Iene. Lo scandalo riguarda dei rimborsi non pervenuti da parte di alcuni membri del Movimento, legati al Fondo del Microcredito istituito per finanziare le piccole e medie imprese. Il documento precisa che i rimborsi in questione non rappresentano un'appropriazione indebita di fondi pubblici, ma soldi che gli eletti del Movimento hanno scelto di restituire o di rimborsare ai cittadini tramite bonifici mensili. Nonostante ciò, gli attacchi da parte degli altri partiti si sono concentrati sulla mancanza di coerenza e sull'ipocrisia percepita, in contrasto con l'immagine di onestà che il Movimento 5 Stelle ha sempre cercato di proiettare. Questo caso ha avuto un forte impatto sulla campagna elettorale, evidenziando la difficoltà di mantenere un'immagine coerente in un contesto politico complesso. La gestione della crisi da parte del M5S ha influenzato, in modo significativo, la percezione dell’opinione pubblica nei confronti del partito.
3. Gli Eventi di Macerata e il Dibattito sull Immigrazione
Il mese di febbraio è stato caratterizzato dal tragico evento di cronaca nera a Macerata, dove il corpo di una giovane ragazza è stato trovato fatto a pezzi. L'evento ha catalizzato l'attenzione mediatica e ha generato forti reazioni politiche. Le dichiarazioni di Meloni e Salvini sui social media, che hanno definito il colpevole (inizialmente identificato come un nigeriano) con termini forti (“mostro”, “verme”), hanno inasprito il dibattito sull'immigrazione. Pochi giorni dopo, un altro evento drammatico si è verificato nella stessa città: Luca Traini, legato alla Lega, ha ferito sei persone di origine africana in un raid razzista, dichiarando di voler vendicare la ragazza uccisa. Traini si è poi costituito facendo il saluto romano, un gesto che ha ulteriormente polarizzato il dibattito. Le reazioni politiche sono state marcate: Berlusconi e Salvini hanno parlato di “bomba sociale”, mentre Saviano ha accusato Salvini di essere il “mandante morale”. Renzi ha invece fatto appello alla calma. Gli eventi di Macerata hanno quindi fortemente influenzato il dibattito politico, in particolare sul tema dell'immigrazione, condizionando le strategie di comunicazione dei diversi partiti.
VII.Le Fasi Storiche delle Campagne Elettorali in Italia
Lo studio traccia una panoramica delle diverse fasi storiche delle campagne elettorali in Italia, dalla fase pre-televisiva a quella digitale, facendo riferimento agli studi di Novelli e di altri autori. Viene sottolineato il ritardo italiano rispetto ad altri paesi occidentali nell'adottare nuovi modelli di campaigning, con una particolare attenzione al ruolo della televisione e dell'avvento di internet e dei social network.
1. Evoluzione delle Campagne Elettorali La Tripartizione di Pippa Norris
La sezione analizza l'evoluzione storica delle campagne elettorali in Italia, partendo dalla tripartizione proposta dalla politologa Pippa Norris: campagne premoderne, moderne e postmoderne. In Italia, la fase premoderna, caratterizzata da partiti di massa e strumenti tradizionali come comizi e manifesti, si è protratta più a lungo rispetto ad altri paesi occidentali (dal 1946 al 1960 circa). La fase moderna, influenzata dall'avvento della televisione (a partire dagli anni '60), ha visto l'emergere dei “telecandidati” e l'uso di strumenti come le “tribune elettorali” (format televisivo con lunghi monologhi politici). La fase neotelevisiva (1975-1990) ha ulteriormente consolidato il ruolo della televisione, con l'intervento sempre più massiccio delle agenzie di pubblicità. L'analisi sottolinea il ritardo dell'Italia nell'adozione dei modelli postmoderni, osservando una differenza tra il livello locale e quello nazionale. Mentre a livello locale, già dal 2004, si sono registrati segnali di campagne postmoderne (Cofferati a Bologna, Emiliano a Bari, Soru in Sardegna, Vendola in Puglia, Renzi alle primarie, Zaia in Veneto, Polverini nel Lazio, Pisapia a Milano), a livello nazionale il modello moderno ha prevalso fino al 2013. Questo ritardo evidenzia le peculiarità del contesto italiano e la persistenza di modelli di comunicazione tradizionali.
2. L Era Digitale e il Ruolo dei Social Network
La quinta fase, quella dell'epoca della rete, viene analizzata focalizzandosi sull'importanza crescente di internet e dei social network nelle campagne elettorali. Novelli sottolinea l'impatto significativo dell'utilizzo della rete in termini di risorse economiche e organizzative assorbite dalle campagne. L'avvento di internet ha profondamente modificato il modo in cui i partiti e i candidati diffondono i messaggi, così come la modalità di fruizione da parte dell'elettorato e l'organizzazione stessa delle campagne. Nonostante l'importanza crescente dei social network, la televisione mantiene un ruolo centrale nelle campagne elettorali italiane, evidenziando un ulteriore ritardo dell'Italia rispetto ad altre democrazie occidentali nel passaggio da un modello di campagna all'altro. L'analisi riflette sulla percezione iniziale delle nuove tecnologie come strumenti di potere positivo e liberatorio (es. Primavera Araba), evidenziando poi come, nel tempo, questa percezione si sia modificata, come dimostra il confronto tra diverse copertine di Time Magazine. Si sottolinea, dunque, la complessità dell'adattamento del sistema politico italiano ai nuovi strumenti digitali, e la persistenza di un approccio ibrido tra modelli tradizionali e nuovi media.
