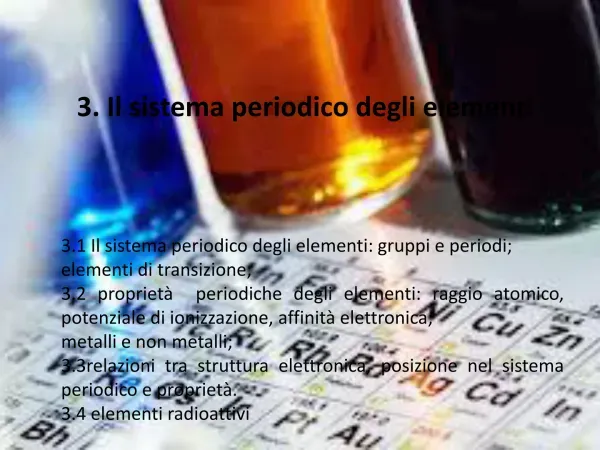
Tavola Periodica: Proprietà e Gruppi
Informazioni sul documento
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 2.59 MB |
| Specialità | Chimica |
| Tipo di documento | Appunti per lezione |
Riassunto
I.Il Sistema Periodico degli Elementi Organizzazione e Proprietà Periodiche
Questo documento tratta il sistema periodico degli elementi, spiegando la sua organizzazione in gruppi e periodi. Il chimico russo Dmitrij Mendeleev è riconosciuto per aver stabilito la relazione tra le proprietà degli elementi e le loro masse atomiche, anche se la comprensione completa arrivò solo nel XX secolo con la scoperta del numero atomico. La disposizione degli elementi è determinata dalla configurazione elettronica esterna, che influenza le proprietà chimiche e fisiche. L'appartenenza allo stesso gruppo indica similitudini chimiche, mentre gli elementi dello stesso periodo mostrano una variazione graduale delle proprietà. Si analizzano le proprietà periodiche, tra cui il raggio atomico, l'energia di ionizzazione, e l'affinità elettronica, evidenziandone le tendenze lungo i gruppi e i periodi. Importanti sono anche i blocchi s, p, d, e f, con particolare attenzione agli elementi di transizione, ai lantanidi e agli attinidi.
1. La Tavola Periodica Organizzazione e Storia
Il documento inizia descrivendo l'organizzazione del sistema periodico degli elementi, evidenziando il ruolo fondamentale dei gruppi e dei periodi nella sua struttura. Si sottolinea il contributo di Dmitrij Mendeleev, che nel 1869 ordinò i 63 elementi noti in base alla massa atomica crescente, gettando le basi per la tavola periodica. Si evidenzia però che la piena comprensione della disposizione degli elementi nella tavola periodica si ebbe solo nei primi decenni del 1900 con l'introduzione del concetto di numero atomico, che rappresenta il numero di protoni nel nucleo di un atomo neutro. La tavola periodica è presentata come una conquista fondamentale della chimica, in quanto ha razionalizzato le informazioni note sugli elementi e i loro composti. Il testo evidenzia che il numero e la disposizione degli elettroni nel livello più esterno dell'atomo sono cruciali per determinare le proprietà chimiche e fisiche degli elementi, e che elementi con configurazioni elettroniche esterne simili appartengono allo stesso gruppo, mostrando quindi affinità nelle loro proprietà. La periodicità delle proprietà è direttamente collegata alla struttura elettronica esterna degli atomi.
2. Gruppi e Periodi Proprietà Chimiche e Tendenze Periodiche
Il documento prosegue definendo i gruppi, o famiglie, come colonne della tavola periodica che raggruppano elementi con la stessa configurazione elettronica esterna. Questa somiglianza nella configurazione elettronica esterna determina la similarità delle proprietà chimiche degli elementi all'interno di ogni gruppo. Si osserva un chiaro andamento delle proprietà lungo un gruppo, correlato all'aumento del peso atomico. Le moderne teorie quanto-meccaniche della struttura atomica supportano questa osservazione, spiegando che gli elementi dello stesso gruppo hanno generalmente le stesse configurazioni elettroniche nel loro guscio di valenza, il che è fondamentale per la comprensione delle loro proprietà simili. Il testo evidenzia come, considerando gli elementi appartenenti allo stesso gruppo, si osservino variazioni monotone del raggio atomico, dell'energia di ionizzazione e dell'elettronegatività. In particolare, muovendosi dall'alto verso il basso in un gruppo, i raggi atomico aumentano a causa dell'aggiunta di livelli di energia e della conseguente maggiore distanza degli elettroni di valenza dal nucleo. Di conseguenza, l'energia di ionizzazione diminuisce, poiché è più facile rimuovere un elettrone meno legato al nucleo. Similmente, l'elettronegatività generalmente diminuisce dall'alto verso il basso a causa dell'aumentata distanza tra gli elettroni di valenza e il nucleo.
3. Periodi e Eccezioni Similitudini e Differenze tra Gruppi e Periodi
I periodi, o serie, sono definiti come le righe orizzontali della tavola periodica, raggruppando elementi con lo stesso numero di orbitali atomici. Ogni periodo inizia con un elemento con un elettrone di tipo ns (dove n è il numero quantico principale), e il numero atomico aumenta di un'unità ad ogni elemento successivo lungo la riga. Mentre il comportamento chimico degli elementi è fortemente influenzato dal gruppo di appartenenza, il documento riconosce che in alcune regioni della tavola periodica, gli elementi che mostrano proprietà chimiche più simili appartengono allo stesso periodo. Un esempio significativo è il blocco f, dove i lantanidi e gli attinidi formano serie orizzontali di elementi con proprietà chimiche piuttosto simili. Questa eccezione sottolinea la complessità delle relazioni tra la posizione nella tavola periodica e le proprietà chimiche degli elementi, mostrando come la semplice organizzazione in gruppi e periodi non sempre catturi completamente le sottili sfumature del comportamento chimico.
II.Proprietà Periodiche Raggio Atomico Energia di Ionizzazione e Affinità Elettronica
Il raggio atomico e il volume atomico diminuiscono da sinistra a destra lungo un periodo e aumentano dall'alto verso il basso lungo un gruppo. L'energia di ionizzazione, ovvero l'energia necessaria per rimuovere un elettrone, aumenta da sinistra a destra e diminuisce dall'alto verso il basso. L'affinità elettronica, ovvero l'energia rilasciata o assorbita acquistando un elettrone, mostra tendenze simili, con la maggior parte degli elementi che presentano un'affinità elettronica negativa.
1. Raggio Atomico e Volume Atomico
Il documento definisce il raggio atomico come metà della distanza minima di avvicinamento tra due atomi dello stesso elemento. Il volume atomico, invece, indica lo spazio occupato da una mole dell'elemento. Il volume atomico è determinato dal movimento degli elettroni attorno al nucleo, paragonabile a delle nubi di densità variabile che rappresenta la probabilità di trovare l'elettrone. Si evidenzia la tendenza del raggio atomico e del volume atomico a diminuire da sinistra a destra lungo un periodo e ad aumentare dall'alto verso il basso lungo un gruppo. Questa variazione è spiegata dalla variazione della distanza degli elettroni di valenza dal nucleo, influenzata dal numero di livelli energetici occupati. Il testo menziona anche che il raggio atomico diminuisce passando da un elemento neutro al suo catione e aumenta passando da un elemento neutro al suo anione, senza approfondire ulteriormente questi aspetti.
2. Energia di Ionizzazione
La sezione sull'energia di ionizzazione spiega che fornire energia ad un atomo può causare salti quantici degli elettroni verso livelli più esterni o, con energia maggiore, l'espulsione definitiva di un elettrone, processo chiamato ionizzazione. L'energia di ionizzazione (di prima ionizzazione) è definita come l'energia necessaria per allontanare a distanza infinita dal nucleo l'elettrone più debolmente legato. Il testo evidenzia che l'energia di ionizzazione decresce dall'alto verso il basso lungo un gruppo e aumenta da sinistra a destra lungo un periodo. Questa tendenza è spiegata dalla minore forza di attrazione tra il nucleo e gli elettroni di valenza man mano che si scende lungo un gruppo, rendendo più facile rimuovere un elettrone. Il documento menziona anche che l'energia di ionizzazione ha un valore convenzionalmente negativo se il processo è energeticamente favorito (rilascio di energia), e positivo se sfavorevole (assorbimento di energia).
3. Affinità Elettronica
L'affinità elettronica è definita come la quantità di energia rilasciata quando un elettrone viene aggiunto ad un atomo neutro isolato in fase gassosa per formare uno ione con carica -1. Questa proprietà si misura in kJ/mol. La maggior parte degli elementi presenta un'affinità elettronica negativa, indicando che il processo di acquisto di un elettrone rilascia energia. Gli atomi più attratti all'acquisto di elettroni hanno un'affinità elettronica più negativa. Il documento non approfondisce ulteriormente le tendenze periodiche dell'affinità elettronica, limitandosi a fornire la definizione e le caratteristiche generali del fenomeno. La relazione tra affinità elettronica e altre proprietà periodiche non è esplicitamente discussa in questa sezione.
III.Relazione tra Struttura Elettronica e Proprietà Chimiche Metalli Non Metalli e Ossidi
La struttura elettronica determina le proprietà chimiche degli elementi. I gruppi all'estrema sinistra della tavola periodica contengono elementi tipicamente metallici, mentre quelli all'estrema destra sono non metallici. La maggior parte degli elementi forma ossidi, classificati in ossidi basici (reagiscono con acidi), ossidi acidi (reagiscono con basi), e ossidi anfoteri (reagiscono sia con acidi che con basi). Le reazioni degli ossidi con l'acqua producono soluzioni basiche o acide a seconda del carattere metallico o non metallico dell'elemento.
1. Carattere Metallico e Non Metallico
Il documento introduce una fondamentale distinzione tra elementi metallici e non metallici. Il carattere metallico degli elementi aumenta procedendo verso sinistra e verso il basso nella tavola periodica. Gli elementi metallici tendono a perdere elettroni di valenza, formando cationi, mentre quelli non metallici tendono ad acquistare elettroni, formando anioni. Questa tendenza è legata alla struttura elettronica e all'elettronegatività degli elementi. Il testo accenna alla presenza di elementi con caratteristiche intermedie, senza ulteriori dettagli su questa classificazione.
2. Gli Ossidi Classificazione e Reazioni
La sezione dedicata agli ossidi afferma che quasi tutti gli elementi formano ossidi. Questi sono classificati in tre categorie: ossidi basici, ossidi acidi e ossidi anfoteri. Gli ossidi basici reagiscono con acidi per dare sali (esempio: CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O), mentre gli ossidi acidi reagiscono con basi per dare sali. Gli ossidi anfoteri, invece, reagiscono sia con acidi che con basi. Il documento approfondisce le reazioni degli ossidi con l'acqua: gli ossidi dei metalli più reattivi (gruppi IA e IIA) reagiscono con l'acqua per formare soluzioni basiche (idrossidi), mentre gli ossidi dei non metalli più elettronegativi formano soluzioni acide. Questo comportamento è legato alla capacità degli elementi di perdere o acquistare elettroni.
3. Blocchi s p d e f Caratteristiche degli Elementi
Il testo fa riferimento ai diversi blocchi della tavola periodica (s, p, d, f), fornendo brevi descrizioni delle caratteristiche degli elementi che appartengono a ciascun blocco. Gli elementi del blocco s (metalli alcalini e alcalino-terrosi, più idrogeno ed elio) e quelli del blocco p (metalli terrosi, calcogeni, alogeni e gas nobili) sono menzionati come esempi, con una breve descrizione delle proprietà chimiche generali. Il blocco d è associato agli elementi di transizione, caratterizzati da proprietà metalliche marcate e dalla capacità di formare composti di coordinazione. Il blocco f contiene i lantanidi e gli attinidi, presentando un comportamento chimico che presenta delle eccezioni rispetto alle semplici tendenze periodiche, evidenziando la complessità delle relazioni tra posizione e proprietà.
IV.Elementi Radioattivi e Decadimento Radioattivo
Il documento introduce gli elementi radioattivi e il decadimento radioattivo, spiegando come i nuclei instabili emettano radiazioni α e radiazioni β, trasformandosi in altri elementi. La stabilità nucleare dipende dal rapporto tra protoni e neutroni.
1. Nuclei Atomici e Stabilità
La sezione inizia descrivendo la composizione dei nuclei atomici, costituiti da protoni e neutroni. Si spiega che i protoni si respingono a causa della loro carica positiva, mentre la forza nucleare attrae sia protoni che neutroni. L'equilibrio tra queste due forze determina la stabilità del nucleo. Gli elettroni contribuiscono alla stabilità nucleare, in quanto la loro attrazione per i protoni aiuta a compensare la repulsione elettrica tra i protoni. Il testo evidenzia che, all'aumentare del numero di protoni, è necessario un rapporto crescente di neutroni rispetto ai protoni per mantenere la stabilità nucleare. Questa relazione è fondamentale per comprendere la radioattività.
2. Radioattività e Decadimento Radioattivo
Il documento definisce la radioattività come il fenomeno in cui i nuclei instabili emettono radiazioni e si trasformano in nuclei più stabili di altri elementi. Questo processo è chiamato decadimento radioattivo. Il testo menziona brevemente tre tipi di radiazioni: le radiazioni α, formate da nuclei di elio (due protoni e due neutroni), che causano una diminuzione del numero atomico di due unità e del numero di massa di quattro unità; le radiazioni β', che comportano la trasformazione di un neutrone in un protone, aumentando il numero atomico di un'unità e lasciando invariato il numero di massa; e le radiazioni β+, formate da positroni ad alta energia, prodotti dalla trasformazione di un protone in un neutrone, diminuendo il numero atomico di un'unità e lasciando invariato il numero di massa. Il documento si concentra maggiormente sul concetto generale di decadimento radioattivo, senza approfondire le caratteristiche specifiche di ciascun tipo di radiazione.
