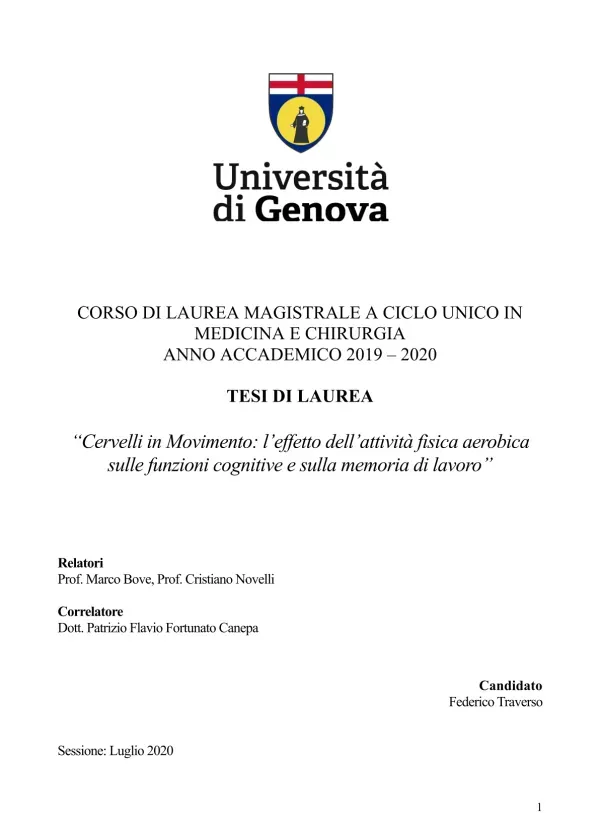
Attività fisica e funzioni cognitive
Informazioni sul documento
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 1.30 MB |
Riassunto
I.I Benefici dell Attività Fisica sulla Salute
Questo documento esplora i numerosi benefici dell'attività fisica per la salute, sia fisica che mentale. L'esercizio fisico, sia aerobico (come la corsa) che anaerobico (come gli allenamenti con i pesi), influenza positivamente il sistema endocrino, il sistema immunitario e il metabolismo, riducendo il rischio di sviluppare diverse patologie, tra cui l'obesità, il diabete di tipo 2, e alcuni tipi di cancro (colon, mammella, endometrio). L'attività fisica migliora inoltre la salute mentale, riducendo il rischio di demenza, depressione e Alzheimer, e incrementando il benessere psicologico attraverso un miglioramento dell'autostima e della qualità del sonno. Studi come il "Finnish Diabetes Prevention Study" (DPS) dimostrano l'efficacia di interventi sullo stile di vita, che includono modificazioni della dieta e un aumento dell'attività fisica, nella prevenzione del diabete di tipo 2. Anche l'esercizio fisico regolare è fondamentale per la crescita e lo sviluppo dei bambini, migliorando la concentrazione e le capacità sociali.
1. Definizione di Attività Fisica e Tipi di Esercizio
Il documento inizia definendo l'attività fisica come qualsiasi movimento che utilizza la muscolatura scheletrica e richiede un dispendio energetico superiore al riposo. Vengono distinti due tipi principali di attività fisica: quella aerobica, che aumenta l'utilizzo di ossigeno e migliora le funzioni cardiovascolari (es. corsa), e quella anaerobica, che aumenta la forza e la massa muscolare (es. allenamento con i pesi). L'importanza dell'attività fisica risiede nella sua influenza su diversi apparati corporei: endocrino, immunitario e metabolismo. Questi effetti possono influenzare il rischio di sviluppare diversi tumori, come evidenziato da Chan et al. (2019). Inoltre, l'attività fisica contribuisce al mantenimento di un peso corporeo sano, prevenendo obesità e dislipidemie.
2. Benefici dell Attività Fisica sulla Salute Mentale
Oltre ai benefici fisici, il documento sottolinea l'importanza dell'attività fisica per la salute mentale. L'esercizio fisico gioca un ruolo chiave nella promozione del benessere psicologico e nella prevenzione di patologie mentali come la demenza, la depressione e l'Alzheimer. Secondo il Physical Activity Guidelines Advisory Committee (2008), l'attività fisica migliora l'autostima, il tono dell'umore e la qualità del sonno, riducendo contemporaneamente ansia e stanchezza. Questi benefici sono direttamente correlati all'intensità e alla durata dell'esercizio: maggiore è l'impegno, maggiori sono i risultati positivi sulla salute mentale.
3. Lo Studio Finnish Diabetes Prevention Study DPS
Il documento cita il Finnish Diabetes Prevention Study (DPS) (Lindström et al., 2003) come uno dei primi studi randomizzati a dimostrare la prevenibilità del diabete di tipo 2 attraverso cambiamenti nello stile di vita. Condotto in diversi centri finlandesi (Helsinki, Kuopio, Turku, Tempere e Oulu), lo studio ha coinvolto un team multidisciplinare (medico, infermiera, nutrizionista, istruttore di attività fisica e fisioterapista) e ha arruolato soggetti ad alto rischio (parenti di primo grado di pazienti diabetici). L'intervento, durato cinque anni, comprendeva modificazioni della dieta e un incremento dell'attività fisica, con check-up annuali. I risultati hanno mostrato una significativa riduzione del peso corporeo nel gruppo di intervento (4.5 kg in media al primo anno) e una minore incidenza di diabete rispetto al gruppo di controllo (9% vs 20% nei primi tre anni, p = 0.0001). Questo evidenzia l'efficacia di un intervento a lungo termine sullo stile di vita, più vantaggioso di diete rigide a breve termine.
4. Attività Fisica e Sviluppo Infantile
Il documento sottolinea l'importanza dell'esercizio fisico nello sviluppo del bambino, un processo che si estende dall'infanzia all'età adulta (Timmons et al., 2007). L'attività fisica contribuisce non solo alla crescita fisica, ma anche allo sviluppo cognitivo, incrementando capacità come la concentrazione, le abilità di relazione e la leadership (Okely et al.). La promozione di uno stile di vita attivo sin dall'infanzia è quindi fondamentale per la salute a lungo termine del bambino, prevenendo problemi legati alla sedentarietà e promuovendo un benessere psicofisico completo.
II. Attività Fisica e Prevenzione del Cancro
Il documento evidenzia il ruolo cruciale dell'attività fisica nella prevenzione del cancro. Studi scientifici, come quelli analizzati nel Third Expert Report del Continuous Update Project (CUP), dimostrano che l'esercizio fisico riduce significativamente il rischio di cancro al colon, alla mammella (soprattutto in post-menopausa) e all'endometrio. L'attività fisica ad alta intensità riduce ulteriormente il rischio di cancro al seno, sia in pre che in post-menopausa. L'American Cancer Society raccomanda almeno 150 minuti di attività fisica di moderata intensità o 75 minuti di attività fisica ad alta intensità a settimana per gli adulti, e almeno 60 minuti al giorno per bambini e adolescenti. Mantenere un peso corporeo sano e ridurre le abitudini sedentarie sono fattori chiave nella prevenzione del cancro.
1. L Attività Fisica e la Riduzione del Rischio di Cancro
Il documento evidenzia una forte correlazione tra l'attività fisica e la riduzione del rischio di cancro. Studi scientifici dimostrano che essere fisicamente attivi diminuisce il rischio di cancro al colon, alla mammella (soprattutto in post-menopausa) e all'endometrio. L'esercizio fisico ad alta intensità sembra offrire una protezione ancora maggiore, riducendo il rischio di cancro alla mammella sia in fase pre che post-menopausale. Anche se le evidenze sull'impatto delle abitudini sedentarie sul rischio di carcinoma endometriale sono limitate, suggeriscono comunque un rischio aumentato. Mantenere un peso corporeo sano, essere fisicamente attivi e seguire una dieta equilibrata sono raccomandazioni chiave per la prevenzione del cancro, secondo le conclusioni del Third Expert Report del Continuous Update Project (CUP).
2. Raccomandazioni dell American Cancer Society e del CUP
L'American Cancer Society raccomanda agli adulti di limitare la sedentarietà e di praticare almeno 150 minuti di attività fisica di moderata intensità o 75 minuti di attività ad alta intensità a settimana. Per i bambini e gli adolescenti, la raccomandazione è di almeno 60 minuti di attività fisica al giorno. Queste raccomandazioni si basano su una vasta analisi della letteratura scientifica, come quella condotta dal Continuous Update Project (CUP), la più grande fonte di ricerca sulla prevenzione del cancro attraverso dieta, nutrizione e attività fisica. Il Third Expert Report del CUP, elaborato da esperti internazionali, riassume le evidenze scientifiche più affidabili per formulare raccomandazioni sulla prevenzione del cancro, sottolineando ancora una volta l'importanza di mantenere un peso sano, di essere fisicamente attivi e di seguire una dieta equilibrata. Ridurre il tempo trascorso seduti è altrettanto importante.
3. Analisi specifiche Cancro al Colon e al Seno
Un'analisi più approfondita evidenzia i benefici dell'attività fisica nella prevenzione di specifici tipi di cancro. Una metanalisi del CUP, che ha incluso 13 studi (8.396 casi), ha mostrato una significativa riduzione del rischio di cancro al colon (RR 0.80 [95% CI 0.72–0.88]) nei soggetti con livelli più alti di attività fisica rispetto a quelli con livelli più bassi. Questi studi sono stati corretti per età, sesso, BMI, fumo, dieta, alcol e anamnesi familiare. Per quanto riguarda il cancro al seno, i benefici dell'attività fisica sono legati principalmente alla riduzione del grasso corporeo, che a sua volta porta a una diminuzione dei livelli di estrogeni circolanti, riducendo l'infiammazione e la resistenza all'insulina (Gunter et al., 2009). Questi fattori sono stati collegati allo sviluppo del carcinoma mammario post-menopausale.
4. Importanza dello Stile di Vita e Studi di Supporto
Il documento evidenzia che oltre all'attività fisica, smettere di fumare, mantenere un peso sano e limitare il consumo di alcolici sono strategie cruciali per ridurre il rischio di cancro. Si stima che il 18% dei casi di cancro e il 16% dei decessi siano attribuibili alla combinazione di sovrappeso, consumo di alcol, inattività fisica e dieta scorretta (Islami et al., 2018). Studi come quello di Topp (1990) hanno dimostrato che anche l'esercizio fisico di bassa intensità, più facilmente praticabile nel tempo, aumenta i livelli di fitness e promuove il benessere. Un altro studio pilota (Headley, 2004) ha valutato l'impatto dell'esercizio fisico su donne con cancro al seno in stadio IV sottoposte a chemioterapia, mostrando che l'attività fisica ha rallentato il declino della qualità di vita e ridotto la stanchezza. Tuttavia, è importante notare che questo studio presentava una limitazione legata allo stato civile dei partecipanti.
III. Attività Fisica e Salute Cardiovascolare
L'esercizio fisico gioca un ruolo fondamentale nella prevenzione e nel trattamento delle malattie cardiovascolari. Studi epidemiologici dimostrano una correlazione inversa tra attività fisica e rischio di patologie cardiovascolari. Un maggiore livello di fitness cardiorespiratoria, misurata anche tramite la VO2 max, è associato a una minore incidenza di eventi avversi. L'esercizio fisico migliora la funzionalità cardiovascolare, riducendo i fattori di rischio come la pressione sanguigna e aumentando le HDL. Uno studio condotto su 936 donne ha evidenziato come l'attività fisica sia un fattore predittivo più importante del peso corporeo nella stratificazione del rischio cardiovascolare. Anche in pazienti con malattie cardiovascolari, l'esercizio fisico porta benefici migliorando la capacità aerobica e la resistenza a carichi di lavoro submassimali.
1. Attività Fisica e Prevenzione Primaria e Secondaria delle Patologie Coronariche
Il ruolo dell'attività fisica nella prevenzione e nel trattamento delle malattie cardiovascolari è ampiamente riconosciuto. Studi epidemiologici dimostrano che maggiori quantità di attività fisica, sia sul lavoro che nel tempo libero, sono associate a un rischio ridotto di patologie cardiovascolari negli individui sani (Morris et al.). Una metanalisi (Berlin et al.) su 27 coorti di adulti sani ha rivelato un rischio maggiore di malattie cardiovascolari per chi svolge lavori sedentari, confermando l'attività fisica come fattore predittivo indipendente, anche dopo aver considerato altri fattori di rischio. Livelli più alti di fitness cardiorespiratoria sono inversamente proporzionali all'incidenza di patologie cardiovascolari in uomini e donne asintomatiche. L'incremento dell'attività fisica nel tempo porta a una riduzione del rischio di insorgenza di malattie cardiovascolari (Florido et al., 2018).
2. Meccanismi Fisiologici dei Benefici dell Esercizio Fisico
Diversi meccanismi fisiologici spiegano i benefici dell'esercizio fisico sulla salute cardiovascolare. L'attività fisica riduce il battito cardiaco e il carico di lavoro submassimale, facilitando l'impegno in attività quotidiane e aumentando la soglia anaerobica. A livello periferico, l'esercizio migliora gli scambi di ossigeno (A-VO2), grazie all'aumento del numero di mitocondri e della capacità enzimatica, e a una migliore regolazione vasomotoria del flusso sanguigno nei muscoli attivi (incremento della densità capillare). Questo porta a un miglioramento della capacità aerobica e della resistenza a carichi di lavoro submassimali. Inoltre, l'esercizio fisico riduce i fattori di rischio cardiologici, incrementando il metabolismo glucidico, le HDL (High Density Lipoprotein) e il rapporto colesterolo totale/HDL, e riducendo la pressione sanguigna.
3. Studio su Donne con Sospetta Ischemia Miocardica
Uno studio (Wessel et al., 2004) su 936 donne (età media 58 anni) con sospetta ischemia miocardica, valutate tramite angiografia, ha mostrato l'importanza dell'attività fisica nella stratificazione del rischio cardiovascolare. Il 39% delle donne presentava una malattia ostruttiva coronarica (CAD) con stenosi del 50%, mentre il 24% aveva una CAD severa (stenosi >70%). La maggior parte era sovrappeso o obesa. L'analisi ha evidenziato una correlazione tra BMI elevato e maggiore prevalenza di ipertensione, diabete e dislipidemia. Utilizzando il Duke Activity Status Index (DASI) e il Post-menopausal Estrogen-Progestin Intervention questionnaire (PEPI-Q), lo studio ha dimostrato una significativa correlazione tra l'attività fisica, la capacità funzionale e la funzionalità cardiovascolare, indipendentemente da altri fattori di rischio come le misure antropometriche. Il livello di esercizio fisico auto-dichiarato e la capacità funzionale risultano più importanti del peso corporeo per la stratificazione del rischio cardiovascolare.
4. Attività Fisica Infiammazione e Qualità di Vita
La perdita di peso e l'esercizio fisico riducono i livelli di marcatori infiammatori nelle donne e nei pazienti con patologie cardiovascolari (Esposito et al.; Ziccardi et al., 2002). Un maggiore livello di fitness è associato a livelli più bassi di insulina, trigliceridi, PCR (proteina C reattiva) e IL-6 (interleuchina 6). L'infiammazione e la resistenza all'insulina aumentano la probabilità di effetti avversi in questa popolazione. Un maggiore fitness score è correlato a minori fattori di rischio per la malattia coronarica e a un minor rischio di eventi cardiovascolari avversi, indipendentemente dall'obesità. Sebbene l'attività fisica sia costantemente correlata a una migliore qualità di vita (HRQL) negli anziani, sono pochi gli studi sistematici sull'impatto di terapie basate sull'esercizio fisico su uomini e donne anziani in programmi di riabilitazione cardiologica. Uno studio (Focht et al., 2004) ha confrontato un programma di intervento comportamentale cognitivo-fisico con un programma tradizionale di riabilitazione cardiaca, mostrando benefici sulla HRQL.
IV. Attività Fisica Funzioni Cognitive e Neuroplasticità
L'esercizio fisico aerobico promuove la neuroplasticità cerebrale, migliorando le funzioni cognitive, tra cui la memoria di lavoro. L'attività fisica influenza i livelli di fattori di crescita come il BDNF, l'IGF-1 e il VEGF, che a loro volta influenzano la neurogenesi, la sinaptogenesi e l'angiogenesi. Studi dimostrano che l'esercizio fisico aumenta il volume della sostanza grigia e bianca in diverse aree del cervello, migliorando le capacità di apprendimento e memoria, ritardando il declino cognitivo legato all'età e riducendo il rischio di neurodegenerazione. L'esercizio fisico è anche utile nella riabilitazione dopo un danno neurologico, come l'ischemia cerebrale, e può rallentare il declino funzionale in malattie come l'Alzheimer e il Parkinson.
1. Esercizio Fisico Aerobico e Neuroplasticità
L'esercizio fisico aerobico induce neuroplasticità nel cervello umano, un processo sfruttato nella riabilitazione di individui con danni neurologici (El-Sayes et al., 2019). I meccanismi coinvolti sono molecolari, cellulari e sistemici (Stillman et al., 2016). A livello molecolare, l'esercizio cronico altera le concentrazioni di brain-derived neurotrophic factor (BDNF), insulin-like growth factor 1 (IGF-1) e vascular endothelial growth factor (VEGF). Il BDNF, una neurotrofina che promuove la neuroplasticità, viene influenzato dall'esercizio che ne aumenta l'assorbimento nel sistema nervoso centrale (Currie et al., 2009). Studi mostrano concentrazioni di BDNF inferiori in soggetti con migliore fitness cardiorespiratoria (Huang et al., 2014), suggerendo un maggiore assorbimento a livello del SNC. L'IGF-1, importante per lo sviluppo e il mantenimento del sistema nervoso, mostra una relazione con l'esercizio dipendente dall'età (Ardawi et al., 2012), mentre il VEGF, coinvolto nell'angiogenesi, è negativamente correlato alla fitness cardiorespiratoria nei giovani (Maass et al., 2016).
2. Cambiamenti Cellulari e Strutturali nel Cervello
BDNF, IGF-1 e VEGF inducono cambiamenti cellulari nel sistema nervoso, tra cui gliogenesi, neurogenesi, sinaptogenesi e angiogenesi (Mandyam et al., 2007). L'esercizio fisico stimola la gliogenesi, influenzata da BDNF e IGF-1 (Carson et al., 1993). Il BDNF aumenta l'espressione del recettore AMPA e riduce quella del recettore GABA A, mentre una riduzione di IGF-1 diminuisce le sinapsi glutammatergiche (Trejo et al., 2001). Il VEGF promuove l'angiogenesi, correlata ai livelli di BDNF (Lin et al., 2014). Neuroimaging mostra cambiamenti strutturali nel cervello dopo l'esercizio, con aumento del volume della sostanza grigia (ippocampo, cervelletto, gangli della base, corteccia frontale, parietale, occipitale, temporale e insulare) e della sostanza bianca (lobi frontale, parietale e occipitale) sia in giovani che anziani (Erickson et al., 2014).
3. Attività Fisica e Miglioramento delle Funzioni Cognitive
Evidenze scientifiche collegano l'esercizio fisico a miglioramenti delle capacità di apprendimento e memoria, rallentamento del declino cognitivo legato all'età, riduzione del rischio di neurodegenerazione e miglioramento della sintomatologia depressiva (Cotman et al., 2007). Questi miglioramenti sono mediati dalla regolazione centrale e periferica dei fattori di crescita, modulati dall'esercizio fisico (Cotman et al., 2007). La riduzione dell'infiammazione indotta dall'esercizio contribuisce a ridurre i fattori di rischio per il declino cognitivo e la neurodegenerazione. L'esercizio incrementa la plasticità sinaptica nell'ippocampo, in particolare nel giro dentato (DG), attraverso l'aumento di proteine sinaptiche, recettori glutammatergici e fattori di crescita come BDNF e IGF-1 (Farmer et al., 2004). La neurogenesi ippocampale, stimolata dall'esercizio, potrebbe essere un meccanismo chiave per i miglioramenti mnemonici e la resistenza alla depressione (Van Praag et al., 1999).
4. Attività Fisica e Patologie Neurodegenerative
L'esercizio fisico ha dimostrato benefici anche in diverse patologie neurodegenerative. In pazienti con ischemia cerebrale, l'esercizio accelera la riabilitazione funzionale. Studi su modelli animali di ischemia cerebrale mostrano che l'allenamento cardiovascolare riduce il danno e favorisce il recupero (Ding et al., 2006). Studi retrospettivi e trasversali suggeriscono che l'attività fisica ritarda l'insorgenza e riduce il rischio di malattie come Alzheimer, Huntington e Parkinson, rallentando il declino funzionale (Podewils et al., 2005; Heyn et al., 2004). In pazienti con Alzheimer, l'esercizio migliora l'ADL (attività della vita quotidiana), rallenta il declino cognitivo e riduce i sintomi depressivi (Teri et al., 2003), mentre in pazienti con Parkinson facilita l'inizio del movimento e migliora la capacità aerobica (Bergen et al., 2002). Su modelli animali di Alzheimer, l'esercizio riduce l'accumulo di placche amiloidi e migliora l'apprendimento (Adlard et al., 2005).
V.Studio Pilota Attività Fisica e Funzioni Cognitive in Giovani
Uno studio pilota condotto a Genova (Italia) ha valutato la correlazione tra attività fisica (misurata tramite il 12m-WRT e il test di Cooper per due diverse fasce d'età), funzioni cognitive (PASAT e SDMT) e memoria di lavoro in studenti di scuole medie, superiori e università, e in bambini delle scuole primarie (Istituti O.Foglietta e N.Tommaseo). Lo studio ha coinvolto 40 studenti delle scuole superiori e università (età media 19.18 ± 6.18 anni) e 79 bambini delle scuole primarie (età media 9 ± 1.06 anni). I risultati indicano una forte correlazione tra VO2 max e performance cognitive, suggerendo che test indiretti di valutazione della fitness cardiorespiratoria possono essere utilizzati per monitorare le capacità aerobiche e cognitive, soprattutto in età scolare, e per adottare misure preventive per migliorare le capacità di apprendimento e memorizzazione. I risultati ottenuti sono stati confrontati con dati normativi, evidenziando differenze significative nella VO2 max e nel BMI in entrambi i gruppi di età.
1. Obiettivi dello Studio Pilota
Lo studio pilota si propone di valutare la correlazione tra funzioni cognitive, memoria di lavoro e attività fisica aerobica in giovani sani appartenenti a tre diversi livelli scolastici: scuole medie, superiori e università. Studi precedenti hanno dimostrato questa correlazione tramite test di laboratorio diretti, ma questo studio si pone l'obiettivo di verificare l'efficacia di un metodo indiretto, utilizzando test da campo, per valutare un campione più ampio di soggetti. L'obiettivo è quindi testare se un metodo di valutazione meno invasivo e più accessibile, come i test da campo, possa fornire risultati altrettanto significativi nella correlazione tra funzioni cognitive, memoria di lavoro e capacità fisica aerobica, rispetto ai metodi diretti di laboratorio.
2. Partecipanti e Metodi
Sono stati arruolati 40 soggetti sani (21 maschi e 19 femmine, età media 19.18 ± 6.18 anni, range 18-24, razza caucasica) che frequentavano scuole medie, superiori o università. Tutti i partecipanti hanno firmato un consenso informato e lo studio è stato approvato dal comitato etico locale (Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino-IST: 452REG2015). Ai partecipanti sono stati somministrati due test cognitivi (PASAT e SDMT) ripetuti due volte, con un intervallo di 5 minuti tra le ripetizioni. Successivamente, hanno eseguito il walk/run test di 12 minuti (12m-WRT) per valutare la VO2 max, calcolata secondo Bandyopadhyay (2006). La frequenza cardiaca è stata misurata con un cardiofrequenzimetro (Polar H10). L'intensità di sforzo percepita è stata valutata con la scala di Borg. I risultati dei test PASAT e SDMT sono stati normalizzati secondo Amato et al.
3. Risultati dello Studio Pilota
L'analisi della varianza (ANOVA) non ha rivelato differenze significative tra i diversi livelli scolastici riguardo a VO2 max, PASAT normalizzato e SDMT normalizzato. Tuttavia, l'analisi bivariata ha mostrato due tendenze differenti nelle correlazioni tra PASAT/SDMT e il livello di istruzione. Negli studenti delle scuole medie e superiori, la fitness aerobica è correlata maggiormente alle capacità di memoria di lavoro (WM) misurate dal PASAT. Negli studenti universitari, invece, all'aumentare della performance aerobica aumenta la capacità cognitiva misurata con l'SDMT. Queste differenze potrebbero essere spiegate dai diversi effetti dell'attività fisica su aree cerebrali differenti e dalla diversa sensibilità dei test PASAT e SDMT alla velocità di elaborazione delle informazioni (Royan et al., 2004; Gielen et al., 2018). Una correlazione significativa è stata trovata tra VO2 max e le performance nei test di memoria di lavoro, confermando l'ipotesi che una migliore capacità cardiorespiratoria migliori il controllo cognitivo della WM (Kamijo et al., 2011).
4. Discussione dei Risultati e Conclusioni
Lo studio indica che, in entrambi i sessi, maggiori capacità aerobiche sono associate a migliori performance nei test di memoria di lavoro (WM), confermando l'ipotesi di una correlazione tra fitness cardiorespiratoria e controllo cognitivo delle funzioni WM. Si osservano differenze nei valori predittivi del PASAT e dell'SDMT in relazione al livello scolastico, probabilmente dovute alla diversa sensibilità dei test e all'effetto tetto raggiunto dagli studenti universitari a causa dell'intervallo inter-stimolo utilizzato (Woods et al., 2018). L'assenza di correlazione tra età e capacità cognitive normalizzate è in linea con studi precedenti, mostrando la capacità aerobica come fattore maggiormente correlato al rendimento scolastico nella fascia preadolescenziale (Castelli et al., 2007). In conclusione, i test indiretti di misurazione della VO2 max risultano associati alle performance cognitive relative alla memoria di lavoro e alla velocità di elaborazione delle informazioni in soggetti giovani e sani, rappresentando un metodo efficace per monitorare le capacità aerobiche e per adottare misure preventive per migliorare l'apprendimento e la memorizzazione.
