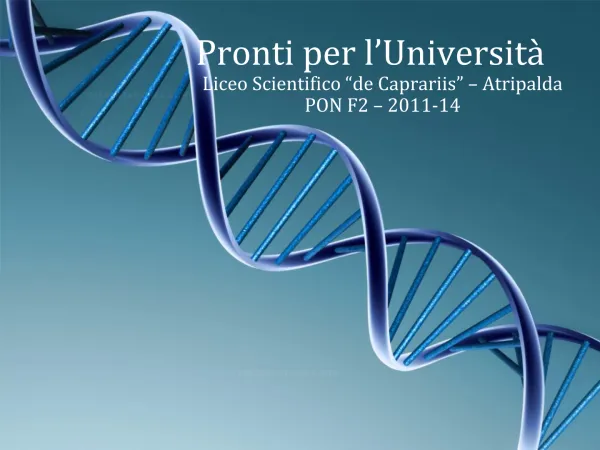
Gruppi Funzionali in Chimica Organica
Informazioni sul documento
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 1.26 MB |
| Specialità | Chimica Organica |
| Tipo di documento | Appunti/Materiale Didattico |
Riassunto
I.Idrocarburi Alcani Alcheni e Alchini
Questo capitolo tratta la chimica degli idrocarburi, suddivisi in tre classi principali: alcani, alcheni e alchini. Gli alcani (formula generale CnH2n+2) sono idrocarburi saturi, relativamente inerti, che reagiscono principalmente tramite reazioni a radicali liberi, come la combustione. Gli alcheni, contenenti uno o più doppi legami C=C, e gli alchini, con uno o più tripli legami C≡C, sono invece molto più reattivi, mostrando tipiche reazioni di addizione elettrofila. Le reazioni degli alcheni includono l'addizione di acidi alogenidrici, l'addizione di acqua (idratazione), l'alogenazione e l'idrogenazione catalitica. Gli alchini subiscono reazioni simili, spesso portando alla riduzione ad alcani tramite idrogenazione catalitica. La geometria molecolare, con ibridazioni sp2 e sp, influenza significativamente la reattività.
1. Alcani Struttura e Reattività
Gli alcani, idrocarburi saturi a catena aperta, presentano la formula generale CnH2n+2. Sono caratterizzati da legami singoli C-C e C-H, poco reattivi con reagenti polari o ionici a causa della simile elettronegatività del carbonio e dell'idrogeno. La loro inerzia chimica è evidente dalla mancanza di reazione con acidi, basi forti e metalli reattivi. Tuttavia, gli alcani bruciano nell'aria producendo anidride carbonica e acqua (combustione), una reazione a catena spesso esplosiva, innescata da luce o calore. Quest'ultima avviene tramite la formazione di radicali, che perpetuano la reazione. In presenza di luce o calore, reagiscono anche con cloro e bromo, formando alogenuri alchilici (R-X), attraverso un meccanismo che inizia con la rottura omolitica del legame Cl-Cl. La loro reattività è quindi basata sulla formazione di radicali liberi.
2. Alcheni Doppio Legame e Reazioni di Addizione
Gli alcheni sono idrocarburi contenenti uno o più doppi legami carbonio-carbonio. La presenza del doppio legame, dovuto all'ibridazione sp2 del carbonio, rende gli alcheni molto più reattivi degli alcani. Essi subiscono principalmente reazioni di addizione elettrofila, dove due porzioni di un reagente si legano ai carboni del doppio legame. Il primo stadio coinvolge la rottura eterolitica del legame π da parte di una specie elettrofila, formando un carbocatione instabile. Esempi di reazioni di addizione includono l'addizione di acidi alogenidrici (HCl, HBr, HI), formando alogenoalcani (seguendo la regola di Markovnikov); l'addizione di acqua in ambiente acido, producendo alcoli (anche questa segue la regola di Markovnikov); e l'alogenazione, che produce dialogenoalcani tramite un'addizione anti-coplanare. L'idrogenazione catalitica, che richiede un catalizzatore metallico (Pt, Pd, Ni), converte gli alcheni in alcani.
3. Alchini Triplo Legame e Reazioni di Addizione
Gli alchini sono idrocarburi caratterizzati dalla presenza di uno o più tripli legami carbonio-carbonio, derivanti dall'ibridazione sp del carbonio. Similmente agli alcheni, mostrano alta reattività, principalmente attraverso reazioni di addizione. L'idrogenazione catalitica (con Pt, Pd o Ni) riduce gli alchini ad alcani, passando attraverso un intermedio alchenico che di solito non è isolabile a causa dell'efficacia del catalizzatore. Altre reazioni di addizione includono l'addizione di acidi alogenidrici e di alogeni, analoghe a quelle degli alcheni, seppur con cinetica differente. L'addizione di acqua, catalizzata da H2SO4 e HgSO4, è più lenta rispetto agli alcheni. La geometria lineare del triplo legame influenza la stereochimica delle reazioni di addizione.
II.Alcoli Fenoli ed Eteri
La sezione descrive gli alcoli, i fenoli e gli eteri. Gli alcoli, caratterizzati dal gruppo ossidrilico -OH, mostrano diverse reattività a seconda del tipo di alcol (primario, secondario, terziario). Le reazioni includono reazioni con acidi alogenidrici e reazioni di ossidoriduzione, che possono portare alla formazione di aldeidi, chetoni o acidi carbossilici. I fenoli, simili agli alcoli ma con il gruppo -OH legato ad un anello benzenico, subiscono principalmente reazioni di sostituzione elettrofila aromatica, come l'alogenazione, la nitrazione e la solfonazione. La nomenclatura dei fenoli e la loro reattività sono dettagliate.
1. Alcoli Reazioni e Classificazione
La sezione introduce gli alcoli, composti organici caratterizzati dal gruppo ossidrilico (-OH) legato ad un atomo di carbonio. La reattività degli alcoli varia a seconda della posizione del gruppo -OH sulla catena carboniosa: alcoli primari, secondari e terziari. Il documento descrive la reazione di un alcol primario con un acido alogenidrico, che porta alla formazione di un alogenuro alchilico e acqua. Un esempio illustra la sostituzione del gruppo -OH con un alogeno (Cl). La reazione con un alcol terziario segue un meccanismo analogo, ma con una maggiore velocità di reazione. Importanti sono anche le reazioni di ossidoriduzione, dove gli alcoli possono essere ossidati a composti carbonilici (aldeidi o chetoni) o acidi carbossilici, a seconda del tipo di alcol e del grado di ossidazione del carbonio. Gli alcoli primari, ad esempio, possono essere ossidati ad aldeidi e poi ad acidi carbossilici, mentre gli alcoli secondari sono ossidati a chetoni. Gli alcoli terziari non sono facilmente ossidabili.
2. Fenoli Struttura e Reazioni di Sostituzione Elettrofila Aromatica
I fenoli sono composti aromatici che presentano un gruppo ossidrilico (-OH) legato direttamente ad un anello benzenico. La presenza del gruppo -OH influenza significativamente la reattività dell'anello aromatico, rendendolo più suscettibile alle reazioni di sostituzione elettrofila aromatica. Il documento fornisce esempi di queste reazioni, tra cui l'alogenazione (sostituzione di un atomo di idrogeno sull'anello con un alogeno), la nitrazione (introduzione di un gruppo nitro -NO2) e la solfonazione (introduzione di un gruppo solfonico -SO3H). La nomenclatura dei fenoli è illustrata con esempi come il p-metilfenolo e il m-clorofenolo, che indicano la posizione dei sostituenti sull'anello benzenico rispetto al gruppo -OH. Le reazioni sono catalizzate da acidi di Lewis.
3. Eteri Cenni Generali
Sebbene menzionati nel titolo, gli eteri non sono approfonditi nel dettaglio nel documento fornito. Vengono solo citati in relazione agli alcoli e fenoli come ulteriore categoria di composti organici, ma non vi è descrizione delle loro proprietà o reazioni chimiche. La trattazione si concentra principalmente sugli alcoli e sui fenoli, lasciando gli eteri come un argomento solo accennato e non sviluppato nel testo.
III.Reazioni Chimiche e Gruppi Funzionali
Il documento evidenzia l'importanza dei gruppi funzionali nella determinazione della reattività delle molecole organiche. Si approfondiscono concetti chiave come elettrofili e nucleofili, spiegando come la presenza di legami polari, come il legame C-O, influenza il comportamento chimico delle molecole. La differenza di elettronegatività tra gli atomi influenza la polarità dei legami e la suscettibilità all'attacco da parte di reagenti polari o ionici. La comprensione di questi principi è fondamentale per prevedere e comprendere le reazioni descritte in questo testo, mettendo in risalto l'importanza dei gruppi funzionali nella chimica organica.
1. Gruppi Funzionali e Classificazione dei Composti Organici
Il testo introduce il concetto fondamentale di gruppi funzionali nella chimica organica. Questi sono piccole unità strutturali presenti nelle molecole organiche che determinano principalmente le loro proprietà chimiche e la loro reattività. La presenza di specifici gruppi funzionali permette di classificare i composti organici in famiglie. Il documento evidenzia l'importanza di comprendere la struttura e la funzione di questi gruppi per prevedere il comportamento chimico delle molecole. Vengono mostrate formule condensate per rappresentare le molecole organiche, semplificando la notazione chimica, in cui i legami C-H sono spesso sottintesi e gruppi come CH2 e CH3 sono utilizzati per rappresentare atomi di carbonio legati a due o tre atomi di idrogeno, rispettivamente. Questa semplificazione è utile per una comprensione più rapida delle strutture molecolari.
2. Polarità dei Legami e Interazione con Elettrofili e Nucleofili
La sezione discute l'influenza della polarità dei legami chimici sulla reattività delle molecole organiche. I legami singoli C-C e C-H, con una simile elettronegatività tra gli atomi, sono poco reattivi con reagenti polari o ionici. Al contrario, il legame C-O, a causa della significativa differenza di elettronegatività tra carbonio e ossigeno, crea un sito polare nella molecola, rendendola reattiva con sostanze ioniche e polari. Questa polarità è ancora più accentuata nei doppi legami C=O, a causa della presenza di elettroni π, con il carbonio che assume una parziale carica positiva (δ+). Il documento introduce i concetti di elettrofili (poveri di elettroni, attratti da atomi ricchi di elettroni come l'ossigeno) e nucleofili (ricchi di elettroni, che attaccano atomi con carenza di elettroni come il carbonio). Questi concetti sono fondamentali per comprendere il meccanismo di molte reazioni organiche.
