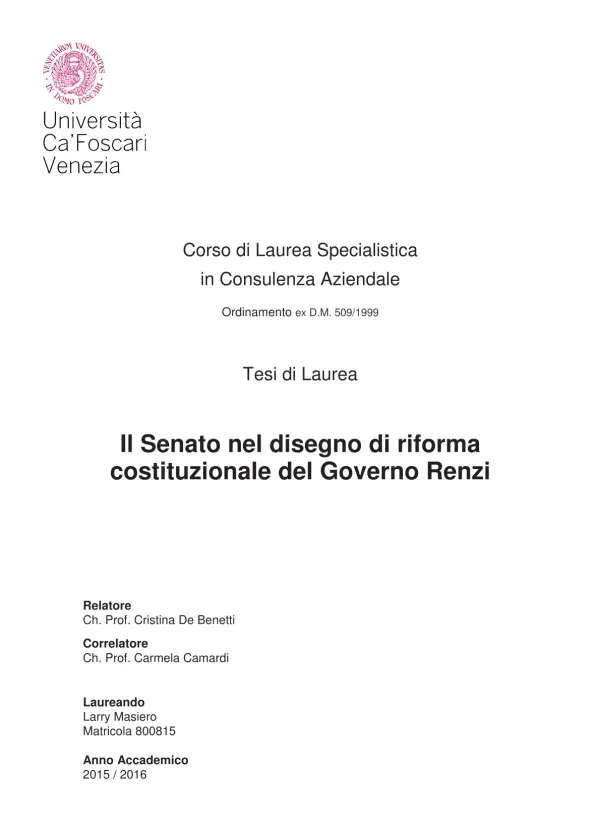
Riforma Senato Renzi: Analisi
Informazioni sul documento
| Scuola | Corso di Laurea Specialistica in Consulenza Aziendale |
| Specialità | Consulenza Aziendale |
| Tipo di documento | Tesi di Laurea |
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 1.84 MB |
Riassunto
I.Il Bicameralismo Italiano Storia Riforme e Confronti Internazionali
Questo documento analizza il sistema bicamerale italiano, confrontandolo con altri sistemi parlamentari a livello internazionale. Si esamina la storia del bicameralismo in Italia, partendo dalla nascita dello Stato unitario e dall'approvazione dello Statuto Albertino, che introduceva un sistema di tre poteri legislativi (Sovrano, Senato, Camera dei Deputati), fino all'attuale Costituzione Italiana. Viene analizzata la composizione del Senato e della Camera dei Deputati, soffermandosi sui diversi sistemi elettorali nel tempo. Particolare attenzione è data alle riforme costituzionali proposte, tra cui quella del 2016, che mirava a superare il bicameralismo perfetto, riducendo il potere del Senato e ridefinendo il rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento. Il documento esplora anche il ruolo del Presidente della Repubblica nello scioglimento anticipato delle Camere e la questione delle immunità parlamentari. Si confrontano, infine, le caratteristiche del bicameralismo italiano con quelle di altri paesi, come Germania (Bundestag, Bundesrat), Regno Unito (House of Commons, House of Lords), Spagna, Belgio e Romania, evidenziando le differenze in termini di composizione, poteri e procedure legislative.
1. L evoluzione storica del bicameralismo italiano
Il documento inizia analizzando l'evoluzione del bicameralismo in Italia, partendo dallo Statuto Albertino. Lo Statuto, redatto da diciassette componenti del Consiglio di Conferenza su pressione della società civile, istituiva una monarchia costituzionale con una suddivisione del potere legislativo tra il Sovrano, il Senato e la Camera dei Deputati. Solo la Camera dei Deputati era elettiva, con deputati scelti dai Collegi Elettorali. I senatori, invece, erano nominati a vita dal Re, senza limiti numerici, e provenienti da venti categorie elencate nello Statuto stesso (vescovi, deputati di lungo corso, ministri, ecc.). Questo sistema rappresentava, almeno formalmente, un esempio di bicameralismo perfetto, dove il dissenso di una delle tre componenti bloccava il processo legislativo. Nella pratica, però, la Camera dei Deputati ebbe maggiore peso politico, in quanto il Governo influenzava la composizione del Senato tramite le cosiddette 'infornate', nominando senatori di sua fiducia. Agostino Depretis, primo Presidente del Consiglio della Sinistra storica, riassunse questa situazione con la frase 'il Senato non fa crisi'. L'ampio consenso (quasi il 90%) sull'approvazione della Costituzione repubblicana, nonostante le divisioni politiche dell'Assemblea Costituente, spiega la sua lunghezza: un compromesso che sommava, anziché selezionava, le diverse istanze e valori.
2. Il Bicameralismo Perfetto e Imperfetto Confronti Internazionali
Il testo prosegue distinguendo tra bicameralismo perfetto, con Camere parificate in funzioni e prerogative, e bicameralismo imperfetto, dove le Camere hanno diversa composizione e poteri, con possibile prevalenza di una sull'altra in caso di disaccordo. Diversi sistemi bicamerali sono presi in esame a titolo di confronto: Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda e Spagna, evidenziando le differenze nelle loro strutture. In alcuni ordinamenti a bicameralismo imperfetto (es. Francia, Germania, Gran Bretagna), la seconda Camera non partecipa alla fiducia al governo; spesso si osserva una prevalenza della prima Camera in materia finanziaria, sia nell'iniziativa legislativa che nella decisione finale. Vengono inoltre menzionati specifici meccanismi per superare eventuali conflitti tra le due Camere, con la prevalenza, in alcuni casi, della prima Camera (come in Francia). Questi confronti internazionali servono a contestualizzare il sistema bicamerale italiano e ad evidenziare le sue peculiarità rispetto ad altre realtà costituzionali.
3. Riforme Costituzionali e il Dibattito sul Bicameralismo
Il documento analizza diverse proposte di riforma costituzionale che hanno interessato il bicameralismo italiano. Si discute di proposte di riforma che si proponevano di modificare il bicameralismo 'perfetto', introducendo un sistema procedimentale ispirato al 'principio della culla', dove una Camera approva il testo e l'altra può richiederne il riesame a maggioranza semplice. Questo meccanismo prevedeva un tempo limitato per il riesame, garantendo un'approvazione definitiva anche in assenza di consenso della seconda Camera. Si fa riferimento ad una relazione presentata alla Camera nel gennaio 1994, mai discussa a causa dello scioglimento anticipato del Parlamento. Un'altra riforma proposta prevedeva un sistema simile a quello tedesco del premierato forte, con l'elezione del Primo Ministro a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, e la possibilità di scioglimento anticipato delle Camere in caso di mancata elezione. Il documento prosegue con l'esame di altre proposte di riforma, tra cui quella che prevedeva un 'Senato federale della Repubblica', con un ruolo di raccordo tra Stato e Regioni, e con un meccanismo di controllo sulla conformità delle leggi regionali all'interesse nazionale. Queste riforme si collocano nel più ampio dibattito sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema bicamerale italiano.
II.Il Senato Italiano Composizione Poteri e Riforme
Il documento approfondisce la composizione e i poteri del Senato italiano, analizzando le diverse proposte di riforma nel corso degli anni. Si discute il passaggio da un Senato nominato dal Re ad uno eletto, l'evoluzione dei sistemi elettorali per l'elezione dei senatori (incluse le proposte di riforma basate su collegi uninominali e proporzionali), e la presenza di senatori a vita. Viene dettagliatamente esaminato il dibattito sulla riforma costituzionale del 2016 e le relative modifiche proposte alla composizione e ai poteri del Senato, in particolare il tentativo di ridurre il bicameralismo paritario a favore di un sistema più efficiente e snello, con una prevalenza della Camera dei Deputati nel rapporto di fiducia con il Governo. La discussione include anche la questione della rappresentanza regionale all'interno del Senato e le tensioni tra interessi nazionali e regionali.
III.Procedure Legislative e Decreti Legge
Questa sezione del documento si concentra sulle procedure legislative italiane, con particolare attenzione al ruolo del Senato e della Camera dei Deputati nell'approvazione delle leggi. Vengono analizzate le procedure ordinarie e quelle speciali, inclusi i meccanismi per risolvere i contrasti tra le due Camere. Viene data particolare importanza ai decreti legge, alla loro conversione in legge e alla pratica della reiterazione dei decreti legge non convertiti, con un'analisi della giurisprudenza costituzionale in materia. Si discute anche la questione della necessità e dell'urgenza, presupposti costituzionali per l'emanazione dei decreti legge, e le possibili conseguenze di una loro applicazione illegittima. Si approfondisce il ruolo del Governo e la sua influenza sulle procedure legislative. Figure importanti in questo contesto sono i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio.
IV.Autonomia delle Camere e Controllo della Corte dei Conti
Il documento tratta l'autonomia delle Camere, sia dal punto di vista normativo e organizzativo che da quello amministrativo e contabile. Viene analizzato il ruolo delle commissioni parlamentari di inchiesta e la questione dell'immunità parlamentare (art. 68 della Costituzione). Si approfondisce il conflitto di attribuzione tra il Parlamento e la Corte dei Conti riguardo al controllo sulla gestione finanziaria delle Camere, ripercorrendo un caso significativo del 1979. Le parole chiave in questo contesto includono: autonomia parlamentare, controllo contabile, commissioni di inchiesta e Corte Costituzionale.
