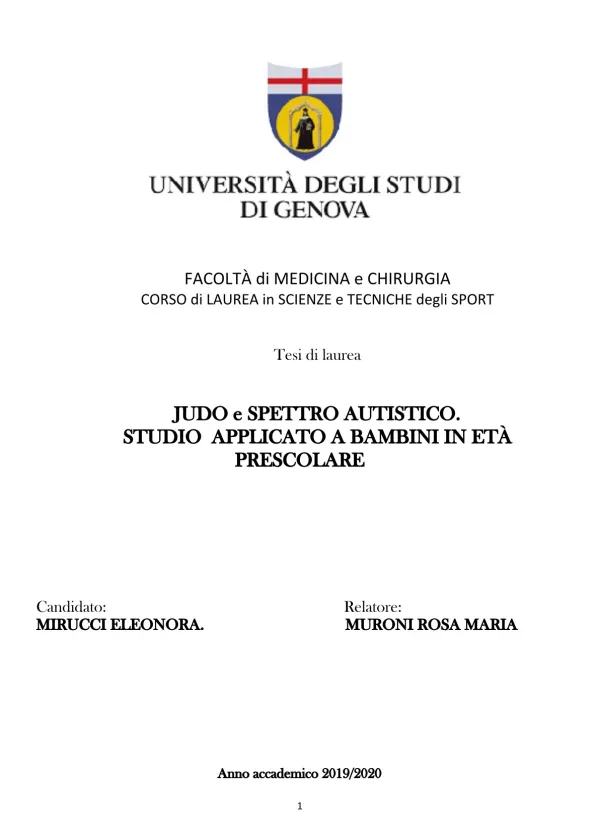
Judo e Autismo: un approccio ludico
Informazioni sul documento
| Scuola | Facoltà di Medicina e Chirurgia |
| Specialità | Scienze e Tecniche degli Sport |
| Tipo di documento | Tesi di laurea |
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 1.75 MB |
Riassunto
I.Judo Una Disciplina Completa per Corpo e Mente
Il Judo è uno sport completo e simmetrico che promuove il miglior utilizzo dell'energia per proiettare o immobilizzare l'avversario. È adatto a persone di tutte le età e migliora la condizione psico-fisica, aumentando le prestazioni atletiche, la concentrazione, la capacità decisionale e l'autocontrollo. Nonostante sia uno sport individuale, il Judo ha una forte valenza sociale grazie all'allenamento di gruppo.
1. Descrizione del Judo e i suoi Principi Fondamentali
Il documento introduce il Judo come una disciplina sportiva completa e simmetrica, basata sul miglior impiego dell'energia per proiettare o immobilizzare l'avversario. Viene sottolineata la sua natura inclusiva, adatta a tutte le persone, senza distinzioni di età o altro. L'enfasi è posta sui benefici a livello psico-fisico derivanti dalla pratica del Judo: miglioramento delle prestazioni atletiche, incremento della concentrazione, sviluppo della capacità decisionale e dell'autocontrollo, rafforzamento della fiducia in se stessi e nelle proprie capacità. Un aspetto rilevante è la sua valenza sociale, nonostante la sua natura individuale, data dalla necessità di allenarsi con compagni, affrontando costantemente situazioni diverse e stimolanti. Questo aspetto sociale contribuisce alla crescita personale e all'integrazione, promuovendo la cooperazione e lo spirito di squadra, aspetti spesso trascurati in altri contesti sportivi individuali. La pratica del Judo si configura, dunque, non solo come un allenamento fisico, ma come un percorso di crescita personale a tutto tondo, coinvolgendo aspetti sia individuali che relazionali.
2. Judo e Sviluppo Affettivo Relazioni e Contesto Familiare
La sezione successiva del documento collega inaspettatamente la pratica del Judo allo sviluppo affettivo, focalizzandosi sulla relazione tra il bambino e gli altri, e in particolare sul ruolo fondamentale della relazione con la madre. Il testo evidenzia l'importanza di distinguere tra umore, emozioni e sentimenti nel processo di sviluppo affettivo del bambino. L'umore viene definito come il temperamento di base, le emozioni come stati affettivi intensi ma transitori, mentre i sentimenti rappresentano stati affettivi più stabili e duraturi. La prima fase dello sviluppo è dominata da questo processo di assimilazione, mentre nella seconda fase prevale l'accomodamento, dove il bambino inizia ad osservare attivamente l'ambiente e a cercare di dominarlo, adattando le proprie capacità alle nuove situazioni. Il processo di assimilazione e accomodamento descritto, seppure collegato allo sviluppo del bambino, non trova una diretta correlazione con l'attività del Judo. La connessione rimane implicita, suggerendo forse che la disciplina e la pratica del Judo possano favorire un miglioramento delle capacità di adattamento e di risposta a situazioni nuove e sfidanti, anche a livello relazionale, ma tale collegamento non viene esplicitamente analizzato nel testo.
II.Lo Sviluppo del Bambino Fasi e Tappe Cruciali
Le prime fasi dello sviluppo del bambino sono caratterizzate da un'evoluzione graduale: dall'esplorazione del proprio corpo e dell'ambiente (0-1 anno), al gioco parallelo (1-3 anni) e al gioco sociale (4-5 anni), dove si sviluppano le abilità sociali e la capacità di comunicazione. Il gioco ha un ruolo fondamentale per lo sviluppo affettivo e cognitivo, aiutando il bambino ad affrontare i traumi e a costruire relazioni significative. L'importanza del legame madre-bambino è sottolineata come base per le relazioni future.
1. Le prime fasi dello sviluppo esplorazione e relazione con la madre 0 1 anno
Il testo inizia descrivendo le prime fasi dello sviluppo del bambino, focalizzandosi sul periodo compreso tra 0 e 1 anno. In questa fase, i primi giochi del bambino sono rappresentati dal suo stesso corpo e da quello della madre, anche se tutti gli oggetti circostanti catturano la sua attenzione. Le azioni principali, come muovere mani e gambe o accarezzare se stesso e la madre, hanno un carattere esplorativo e ripetitivo. Attraverso queste azioni, il bambino impara a distinguere il sé dal non sé, comprendendo i limiti del proprio corpo e la differenza con quello della madre, inizialmente percepita come parte di sé. Questa fase è cruciale per la costruzione della propria identità e per la comprensione della realtà circostante. L'esplorazione sensoriale e motoria è fondamentale per lo sviluppo psicomotorio e per la formazione delle prime rappresentazioni mentali. La relazione con la madre è considerata primaria e costituisce la base per tutte le relazioni future. La ripetizione delle azioni è un meccanismo fondamentale per l’apprendimento e l’interiorizzazione delle esperienze.
2. Il gioco parallelo e l emergere della simbolizzazione 1 3 anni
Tra il primo e il terzo anno di vita, il bambino inizia a interagire con altri bambini, ma il gioco mantiene ancora una forte componente individuale, definito come gioco parallelo. In questa fase emerge il desiderio di integrarsi e comunicare con gli altri, di comprendere il significato delle cose che lo circondano. Il bambino ricorre all'uso dei simboli come strumento per esprimere i propri pensieri e interagire con la realtà. I bambini più estroversi cercano di coinvolgere gli altri in giochi sempre più complessi, assegnando e scambiando ruoli e utilizzando immagini o oggetti inventati. Questo periodo è caratterizzato dalla comparsa della funzione simbolica, che permette al bambino di agire sulla realtà anche attraverso il pensiero, immaginando gli effetti delle azioni senza doverle mettere in pratica. L'imitazione di modelli, anche in assenza di questi, diventa una parte fondamentale del processo di apprendimento e socializzazione. Questo sviluppo del pensiero simbolico apre la strada all'acquisizione del linguaggio e all'espansione delle capacità cognitive.
3. Il gioco sociale e l integrazione 4 5 anni e oltre
Verso i quattro o cinque anni, con l'inizio della fase prescolastica, il gioco sociale diventa prevalente. L'interazione con i fratelli o i compagni di scuola si intensifica, segnando il passaggio dal gioco simbolico individuale a quello sociale. Il gioco socio-drammatico permette al bambino di interpretare ruoli diversi e di organizzare il gioco secondo una sequenza strutturata, applicando le conoscenze acquisite nella vita quotidiana. Questa modalità di gioco integra diverse risorse del bambino, sia cognitive che sociali, facilitando l'apprendimento e la socializzazione. Il documento sottolinea l'importanza del gioco nel processo di sviluppo intellettivo, affettivo e relazionale. Attraverso il gioco, il bambino esplora il mondo interiore ed esteriore, sviluppando le proprie potenzialità e interiorizzando nuove esperienze. L'acquisizione di nuove capacità e la capacità di sorprendere se stesso sono elementi chiave per questo tipo di sviluppo. La teoria di Vygotskij sul gioco come zona di sviluppo prossimale viene menzionata, indicando che durante il gioco, il bambino si comporta in modo superiore alla sua età media.
III.Disturbi da Deficit di Attenzione Iperattività ADHD e Disturbi Comportamentali
Il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD) si manifesta con sintomi di disattenzione, iperattività e impulsività, che compromettono il funzionamento sociale, scolastico e lavorativo. Sono previsti diversi sottotipi: prevalentemente disattento, prevalentemente iperattivo/impulsivo e combinato. Il Disturbo Oppositivo Provocatorio (DOP) è caratterizzato da comportamento negativistico, provocatorio e ostile verso le figure di autorità. Entrambi i disturbi possono coesistere e richiedono un approccio diagnostico e terapeutico attento, considerando l'età e il genere del soggetto. La diagnosi precoce e l'intervento precoce sono cruciali.
1. Disturbo da Deficit di Attenzione Iperattività ADHD Sintomi e Sottotipi
La sezione descrive il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD), caratterizzato da sintomi significativi di disattenzione e/o iperattività-impulsività. Questi sintomi devono causare una compromissione significativa in almeno due contesti (casa e scuola/lavoro) e interferire con il funzionamento sociale, scolastico o lavorativo adeguato al livello di sviluppo. Il documento evidenzia l'esistenza di sottotipi per meglio definire la sintomatologia prevalente: Tipo con Disattenzione Predominante, Tipo con Iperattività/Impulsività Predominanti e Tipo Combinato. La disattenzione si manifesta con cambiamenti frequenti di argomento nelle conversazioni, difficoltà di ascolto, scarsa attenzione alle istruzioni e alle regole. L'iperattività può includere agitazione, incapacità di rimanere seduti, corsa sfrenata, difficoltà nel gioco tranquillo e un'eccessiva loquacità. L'impulsività si caratterizza per impazienza, difficoltà nel controllare le reazioni, interruzioni frequenti e incapacità di attendere il proprio turno. La diagnosi richiede cautela, soprattutto nei bambini piccoli, considerando che i sintomi possono variare con l'età e il livello di sviluppo. È importante raccogliere informazioni da diverse fonti (genitori, insegnanti) e osservare il comportamento in diverse situazioni.
2. Disturbo Oppositivo Provocatorio DOP Caratteristiche e Disturbi Associati
Il Disturbo Oppositivo Provocatorio (DOP) è definito da una modalità ricorrente di comportamento negativistico, provocatorio, disobbediente e ostile verso le figure di autorità, persistente per almeno 6 mesi. Il documento elenca diversi comportamenti che caratterizzano il DOP: perdita di controllo, litigi con adulti, opposizione attiva alle richieste, azioni che infastidiscono gli altri, tendenza ad accusare gli altri, suscettibilità, collera, risentimento e comportamenti dispettosi o vendicativi. Le manifestazioni del DOP variano in base all'età e alla gravità del disturbo. Nei maschi, una maggiore prevalenza si osserva nei bambini in età prescolare con temperamenti difficili o intensa attività motoria. In età scolare possono manifestarsi scarsa autostima (o autostima esagerata), labilità d'umore, scarsa tolleranza alla frustrazione, uso di parolacce e consumo precoce di alcol, tabacco o sostanze illecite. Spesso si osservano conflitti con genitori, insegnanti e coetanei. Il DOP è più frequente in famiglie con cambiamenti frequenti nelle figure di accudimento o con pratiche educative rigide, incoerenti o distratte. Il documento menziona la frequente comorbidità con il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività e con disturbi dell'apprendimento e della comunicazione.
3. Considerazioni sulla Diagnosi e Caratteristiche Specifiche di Età e Genere
Il documento sottolinea la necessità di cautela nella diagnosi del DOP, soprattutto in età prescolare e adolescenziale, data la frequenza di comportamenti oppositivi transitori in queste fasi dello sviluppo. Il numero dei sintomi tende ad aumentare con l'età. Il DOP è più prevalente nei maschi in età prepuberale, ma le percentuali si pareggiano dopo la pubertà. L'ostilità può essere diretta verso adulti o coetanei, manifestandosi con molestie o aggressioni verbali, ma solitamente senza le gravi aggressioni fisiche tipiche del Disturbo della Condotta. I sintomi sono più evidenti nelle interazioni familiari, mentre possono essere meno marcati a scuola o nella comunità. I soggetti con DOP spesso non si considerano oppositivi o provocatori, giustificando il proprio comportamento come reazione a richieste o circostanze irragionevoli. Il documento evidenzia la necessità di una valutazione completa del comportamento in diversi contesti e la raccolta di informazioni da molteplici fonti (genitori, insegnanti).
IV.Disturbo Reattivo dell Attaccamento e Mutismo Selettivo
Il Disturbo Reattivo dell'Attaccamento si manifesta con una relazione sociale inadeguata, dovuta ad un accudimento patologico precoce. Si distinguono un tipo inibito e uno disinibito. Il Mutismo Selettivo consiste nel rifiuto di parlare in situazioni sociali specifiche, pur avendo la capacità linguistica. Questi disturbi richiedono una diagnosi differenziale accurata rispetto ad altri disturbi dello sviluppo, come il Ritardo Mentale e i Disturbi Pervasivi dello Sviluppo, tra cui il Disturbo dello Spettro Autistico (DSA).
1. Disturbo Reattivo dell Attaccamento Caratteristiche e Tipologie
Il Disturbo Reattivo dell'Attaccamento (DRA) è caratterizzato da una modalità di relazione sociale disturbata e inadeguata rispetto al livello di sviluppo del bambino, che inizia prima dei 5 anni ed è associata ad un accudimento grossolanamente patologico. Il documento distingue due tipologie di DRA: il Tipo Inibito, in cui il bambino è incapace di iniziare interazioni sociali e risponde in modo inibito, ipervigile o ambivalente (attenzione fredda, resistenza alle tenerezze o misto di approccio ed evitamento); e un Tipo Disinibito, non descritto nel dettaglio nel testo. Situazioni come ospedalizzazione prolungata, estrema povertà o inesperienza dei genitori possono predisporre allo sviluppo di un accudimento patologico, ma questo non causa sempre il DRA. Condizioni di trascuratezza estrema, soprattutto in istituzioni con limitate possibilità di formare legami selettivi, aumentano il rischio. Il DRA può essere associato a ritardi nello sviluppo, disturbi della nutrizione, pica o disturbo di ruminazione. La diagnosi differenziale è importante per distinguere il DRA dal ritardo mentale, dai disturbi pervasivi dello sviluppo e dalla fobia sociale.
2. Mutismo Selettivo Diagnosi e Disturbi Associati
Il Mutismo Selettivo è descritto come un disturbo in cui il bambino rifiuta di parlare in specifiche situazioni sociali, pur possedendo la capacità di farlo in altri contesti (ad esempio, a casa). Il documento sottolinea che il rifiuto di parlare non deve essere attribuito a mancanza di conoscenza della lingua, come può accadere in bambini di famiglie immigrate. Se la comprensione linguistica è adeguata ma il rifiuto persiste, si può diagnosticare Mutismo Selettivo. Il documento suggerisce che bambini con Disturbi Pervasivi dello Sviluppo, schizofrenia, altri disturbi psicotici o ritardo mentale grave possono avere problemi di comunicazione sociale, ma il Mutismo Selettivo dovrebbe essere diagnosticato solo se il bambino ha acquisito la capacità di parlare in alcuni contesti. Il Mutismo Selettivo può essere associato a fobia sociale, in questi casi, entrambe le diagnosi possono essere considerate valide. Il testo fa cenno alla necessità di distinguere il Mutismo Selettivo da altre condizioni che possono comportare difficoltà di comunicazione, sottolineando la specificità del rifiuto selettivo di parlare in determinati contesti sociali.
V.Disturbo dello Spettro Autistico DSA Caratteristiche e Diagnosi
Il Disturbo dello Spettro Autistico (DSA) è una condizione complessa caratterizzata da difficoltà nella comunicazione, nelle interazioni sociali e dalla presenza di comportamenti ripetitivi e stereotipati. La diagnosi richiede un'analisi approfondita del comportamento del bambino, considerando l'eterogeneità sintomatologica e la variabilità individuale. L'apprendimento sociale è particolarmente compromesso nei bambini con DSA. Un intervento precoce è fondamentale per supportare lo sviluppo del bambino.
1. Caratteristiche del Disturbo dello Spettro Autistico DSA
Il documento descrive il Disturbo dello Spettro Autistico (DSA) come una condizione complessa caratterizzata da difficoltà nelle interazioni sociali e nella comunicazione, e dalla presenza di comportamenti ripetitivi e stereotipati. Queste difficoltà emergono precocemente nello sviluppo, spesso già nel secondo anno di vita. I bambini con DSA mostrano minore propensione ad osservare e imitare gli altri, a ricercare i coetanei e a giocare con loro, a intraprendere interazioni sociali e a rispondere alle iniziative sociali altrui. Inoltre, presentano comportamenti ripetitivi anomali, come avversione ai cambiamenti, rigida aderenza alle routine, e stereotipie motorie (agitare le mani, saltare). Il testo evidenzia un deficit nell'iniziativa dell'attenzione condivisa, con una ridotta condivisione dell'interesse che limita le opportunità di apprendimento sociale. La difficoltà nell'apprendimento sociale, ovvero nell'imparare dalle azioni e dalla comunicazione degli altri, è sottolineata come un aspetto fondamentale del DSA. Questa mancanza di attenzione verso gli altri porta i bambini con autismo a focalizzarsi maggiormente su oggetti, percezioni sensoriali e altre esperienze ambientali.
2. Diagnosi e Considerazioni sulla Variabilità del DSA
La diagnosi del DSA richiede un'analisi approfondita del comportamento del bambino, considerando l'eterogeneità sintomatologica e la variabilità individuale. Il testo menziona la confusione storica tra autismo e schizofrenia, e l'evoluzione del concetto di autismo nella letteratura scientifica, citando autori come Bleuler e Kanner, e il ruolo del DSM-III e DSM-III-R nell'offrire una definizione più precisa e distinta. L'autismo, secondo il testo, non è un disturbo che colpisce l'intero individuo, ma una parte importante del suo sviluppo. Si ipotizza che fattori genetici e ambientali interagiscano, determinando una vasta gamma di tassi di sviluppo e di capacità cognitive. Questa interazione tra fattori specifici e non specifici contribuisce all'eterogeneità sintomatologica del DSA. Il documento accenna alle difficoltà di raggiungere una descrizione definitiva ed esaustiva del DSA a causa della sua complessità, sottolineando la necessità di ulteriori studi in diverse discipline, come le neuroscienze e la genetica, per una migliore comprensione delle differenze individuali.
