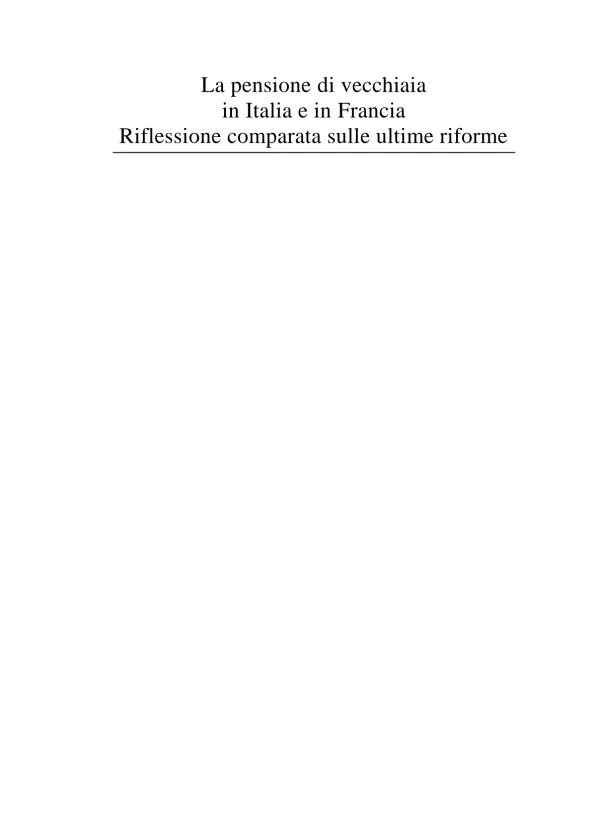
Pensioni Italia-Francia: Confronto Riforme
Informazioni sul documento
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 1.22 MB |
| Autore | Andrea Core |
| instructor | Prof. Giampiero Proia |
Riassunto
I.Il Deficit Democratico e la Crisi del Progetto Europeo
Il documento analizza la crisi dell'Unione Europea (UE), evidenziando il ruolo del deficit democratico e la sfiducia dei cittadini, alimentata da politiche percepite come fonte di sacrifici e imposizioni illegittime. L'ascesa dei populismi nazionalistici e l'inazione di una politica nazionale, dichiarata europeista ma inefficiente, hanno compromesso l'entusiasmo per il progetto europeo. Per evitare un pericoloso ritorno ai nazionalismi, l'UE deve riscoprire la sua vocazione sociale, coniugando libertà economiche e diritti sociali, un elemento centrale nei primi passi del progetto europeo.
1. Le Mancanze del Sistema Comunitario e il Deficit Democratico
La recente depressione economica ha drammaticamente evidenziato le carenze del sistema comunitario europeo, mettendo in luce un significativo deficit democratico. La necessità di una più attenta armonizzazione in specifici settori è emersa come soluzione imprescindibile, strettamente legata alla questione politica del deficit democratico stesso. Il sogno di un'Unione di Stati europei si scontra con gli umori elettorali: i cittadini mostrano riluttanza ad investire in un'Unione percepita come fonte di sacrifici e imposizioni illegittime. Questa situazione è aggravata dall'ascesa dei populismi nazionalistici da un lato, e dall'altro da una politica nazionale, apparentemente europeista ma in realtà pigra, spesso codarda e palesemente incompetente, che ha esaurito il carburante dell'entusiasmo. Per evitare un pericoloso regresso, l'Europa deve riscoprire la sua vocazione sociale, integrando al meglio le libertà economiche con i diritti sociali. Sebbene l'interesse mediatico si sia affievolito, l'attenzione ai temi sociali è stata, nei primi passi del progetto europeo, un elemento centrale e quasi propulsivo.
2. Le Elezioni Europee e il Rischio di un Revival Nazionalista
Le ultime elezioni europee hanno dimostrato come la stessa continuità del progetto europeo sia a rischio. Questo è principalmente dovuto alla percezione, da parte di una consistente fetta di cittadini degli Stati membri, che le misure richieste da Bruxelles siano eccessivamente gravose. Tale delusione rappresenta un potenziale terreno fertile per un ritorno al potere dei nazionalismi nel Vecchio Continente. L'intellighenzia europea si impegna da anni per il recupero della dimensione sociale dell'Unione, un recupero che deve essere non solo formale (giuspositivo), ma tangibile nel diritto vivente. La Corte di Giustizia, pur affermando di operare un bilanciamento rispettoso del principio di proporzionalità, ha spesso privilegiato le libertà e i poteri economici rispetto ai diritti sociali, come dimostrato dalle sentenze Viking e Laval.
II.La Clausola Sociale Orizzontale e il Bilanciamento tra Diritti Sociali e Libertà Economiche
Un tema cruciale è la clausola sociale orizzontale, contenuta nell'articolo 9 del TFUE, che impegna l'UE a considerare le esigenze connesse alla promozione di un elevato livello di occupazione, alla protezione sociale, alla lotta contro l'esclusione sociale e alla salute umana. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte di Giustizia (casi Viking e Laval) ha spesso anteposto le libertà economiche ai diritti sociali, creando un squilibrio che il documento critica. La clausola sociale, se correttamente applicata, potrebbe diventare uno strumento fondamentale per riequilibrare la situazione, ma necessita di un maggiore impegno da parte delle Istituzioni.
1. La Clausola Sociale Orizzontale Contenuto e Struttura
Il documento analizza la cosiddetta "clausola sociale orizzontale", presente nell'articolo 9 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Questa clausola, definita "orizzontale" per la sua struttura trasversale e non direttamente applicabile nei rapporti interprivati, afferma che l'Unione Europea, nella definizione e attuazione delle sue politiche e azioni, deve tener conto delle esigenze connesse alla promozione di un elevato livello di occupazione, alla garanzia di un'adeguata protezione sociale, alla lotta contro l'esclusione sociale e a un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana. Il suo contenuto generico richiede l'intervento applicativo delle istituzioni sovranazionali e nazionali, rendendo impossibile al singolo individuo agire direttamente per far valere i diritti derivanti da essa. Secondo numerosi studiosi, questa clausola potrebbe rappresentare uno strumento potente, un 'cavallo di Troia', in grado di permeare gran parte del diritto comunitario, a patto che le istituzioni le riservino lo spazio adeguato, superando la sudditanza psicologica al mercato.
2. Il Bilanciamento Precario tra Diritti Sociali e Libertà Economiche
Il quadro normativo attuale dell'Unione Europea e degli Stati membri risulta carente nel garantire un effettivo bilanciamento tra diritti sociali e libertà economiche. La clausola sociale orizzontale, pur auspicata come elemento chiave di questo bilanciamento, è ancora lontana dal raggiungere tale obiettivo. La 'garanzia di un'adeguata protezione sociale' reclamata dall'articolo 9 del TFUE non trova sufficiente supporto nel resto del Trattato e nella sua implementazione, dovendo affidarsi ad altri canali, come i libri bianchi e il metodo aperto di coordinamento. La giurisprudenza della Corte di Giustizia, in casi come Viking e Laval, ha dimostrato una tendenza a privilegiare le libertà economiche e i poteri economici a discapito dei diritti sociali. Questo approccio, seppur potenzialmente produttivo di risultati positivi, presenta un problema di fondo: per un'evoluzione ordinata della previdenza nazionale in armonia con il diritto comunitario e le libertà dei Trattati, è necessario un modello sociale chiaro, di origine politica, e non costruito a pezzi da pronunce giurisprudenziali. Si rischia, infatti, di creare un sistema di diritti senza doveri corrispondenti, alterando gli equilibri distributivi e allontanandosi da una reale solidarietà sociale europea.
III.Le Pensioni nell Unione Europea Sostenibilità e Adeguatezza
La spesa per le pensioni è un elemento centrale, in quanto rappresenta una voce consistente dei bilanci nazionali. La crisi economica ha spinto l'UE ad aumentare l'attenzione in questo settore, anche a causa delle forti interconnessioni tra gli Stati membri. Il documento analizza i tentativi di riforma dei sistemi pensionistici, spesso condotti in nome dell'austerità e della sostenibilità finanziaria, evidenziando i dilemmi tra l'onorare gli impegni con la BCE e garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche per i cittadini. Il Libro Bianco sulle Pensioni 2012 è citato come documento chiave per comprendere la politica dell'UE in materia.
1. L Importanza della Spesa Pensionistica nei Bilanci Nazionali
La spesa per le pensioni rappresenta la voce più rilevante nei bilanci nazionali di molti Paesi europei, tra cui Italia e Francia. Questo crea un dilemma cruciale: onorare i patti con la Banca Centrale Europea (BCE) oppure mantenere gli impegni presi con i propri cittadini, dai pensionati ai lavoratori più giovani. A livello comunitario, si apre la possibilità di ridiscutere l'ineluttabilità di questa scelta, intervenendo sui numeri, sulle soglie e sulle voci di spesa, o immaginando strategie complessive alternative. L'Unione Europea ha numerosi obiettivi sociali, tra cui piena occupazione, progresso sociale, lotta all'esclusione sociale e alle discriminazioni, promozione della giustizia e protezione sociale, parità tra uomini e donne, solidarietà tra generazioni e tutela dei diritti dei minori. Questi obiettivi, seppur presenti, non trovano sempre una traduzione effettiva nelle politiche concrete.
2. L Intervento dell UE e la Crisi Economica
L'interesse dell'UE per le pensioni ha due origini principali. La prima è la visione a lungo termine della Commissione Europea, testimoniata da un'azione di sottofondo presente dall'inizio del secolo. La seconda, e più evidente, è la crisi economica. La stretta relazione tra sistema pensionistico e bilanci nazionali, unita alle forti interconnessioni tra i Paesi membri, rende il fallimento di una politica pensionistica in uno Stato membro potenzialmente dannoso per la stabilità dell'euro e per l'economia dell'intera Unione. Inoltre, la crescente mobilità dei cittadini implica che politiche pensionistiche inadeguate possano avere effetti diretti sui sistemi di sicurezza sociale di altri Paesi. La crisi ha quindi spinto l'UE ad un intervento più incisivo. Prima della crisi, i governi mostravano già una crescente sensibilità verso la sostenibilità finanziaria dei sistemi pensionistici nel lungo termine e la loro capacità di resistere agli stress economici e demografici. Questo ha portato ad un rafforzamento del quadro normativo e degli incentivi fiscali per le forme pensionistiche complementari.
3. Il Libro Bianco sulle Pensioni 2012 e le Strategie dell UE
Il Libro Bianco del 2012, dedicato a pensioni adeguate, sicure e sostenibili, costituisce il principale riferimento per comprendere la politica dell'Unione Europea nel settore previdenziale. A differenza di altri documenti che trattano le pensioni incidentalmente, il Libro Bianco si concentra specificamente su questo tema, evidenziando la necessità di garantire la sostenibilità finanziaria e l'adeguatezza delle prestazioni. La Commissione auspica un ruolo maggiore del risparmio destinato alle pensioni complementari, spronando gli Stati membri a risolvere i problemi legati alla redditività, alla sicurezza e all'equa accessibilità a questi regimi. Strumenti importanti a questo scopo includono imposte, incentivi finanziari, contrattazioni collettive, parità dei sessi, la direttiva sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro e la direttiva sulle attività e la supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP). Il Libro Bianco sottolinea la necessità che i cittadini abbiano un quadro chiaro dei propri diritti maturati, suggerendo la creazione di servizi di ricostruzione delle pensioni a livello UE.
IV.L Esempio Italiano e Francese Riforme Pensionistiche e Pressione Europea
Il documento esamina le riforme pensionistiche in Italia e Francia, evidenziando le pressioni esercitate dall'UE e dalla BCE per il contenimento della spesa pubblica. In Italia, le riforme, come quella Fornero, hanno mirato a ridurre il debito pubblico, innalzando l'età pensionabile e introducendo il sistema contributivo. In Francia, le riforme, influenzate dalle pressioni europee, hanno comportato aumenti dell'età pensionabile e modifiche ai contributi sociali. Si sottolinea come queste riforme, pur perseguendo la sostenibilità finanziaria, possano compromettere l'adeguatezza delle pensioni e la solidarietà sociale.
1. Riforme Pensionistiche in Italia La Riforma Fornero e le sue Conseguenze
Il documento analizza le riforme pensionistiche italiane, focalizzandosi sull'impatto della riforma Fornero. Questa riforma, attuata per ridurre il debito pubblico, ha portato ad un innalzamento dell'età pensionabile e all'introduzione del sistema contributivo. Il documento cita il 'Decalogo per le pensioni' del Partito Democratico (febbraio 2014), che, partendo dal presupposto di un consistente risparmio ottenuto grazie alla riforma Fornero (oltre 300 miliardi di euro, circa il 15% del debito pubblico tra il 2020 e il 2060), propone interventi correttivi per migliorare il sistema, implicando che le pensioni abbiano contribuito significativamente alla riduzione del debito pubblico. L'analisi evidenzia la difficoltà del sistema di previdenza sociale italiano nel rispondere adeguatamente ai bisogni sociali, a causa della spesa pensionistica dominante e di trasferimenti sociali non mirati alla lotta contro la povertà e alla promozione dell'inclusione sociale. La riforma del 2011, innalzando ulteriormente l'età pensionabile, ha ulteriormente aggravato le difficoltà di garantire l'occupabilità dei lavoratori più anziani.
2. Riforme Pensionistiche in Francia Pressione Europea e Scelte Politiche
In Francia, il dibattito sulle riforme pensionistiche del 2013 è stato fortemente influenzato dalle pressioni europee, in modo simile a quanto avvenuto in Italia nel 2011. La riforma del 2010, che ha innalzato gradualmente l'età pensionabile da 60 a 62 anni entro il 2017, ha introdotto altre misure come l'armonizzazione dei tassi di contribuzione tra sistemi pubblici e privati e il diritto al prepensionamento per lavoratori con incapacità parziale. Successive modifiche hanno parzialmente annullato i benefici iniziali. La Commissione Europea ha accolto positivamente sia la riforma del 2010 che quella del 2013, pur riconoscendo che quest'ultima potrebbe essere insufficiente nel medio termine. Le misure si sono concentrate sull'aumento dei contributi sociali per dipendenti e datori di lavoro, ma con la critica di una limitazione agli interventi sul regime generale e la mancanza di revisione dei regimi speciali. Il Consiglio Europeo, prima dell'approvazione della riforma del 2013, aveva rilevato che il sistema pensionistico francese sarebbe stato comunque deficitario nel 2018, suggerendo ulteriori misure per il riequilibrio, mantenendo l'adeguatezza del sistema. Il dibattito in Francia, come in Italia, è legato alla questione più ampia dell'adesione al progetto europeo, con la possibilità di scegliere tra riforme radicali in linea con le regole europee o riforme palliative in attesa di cambiamenti negli equilibri.
