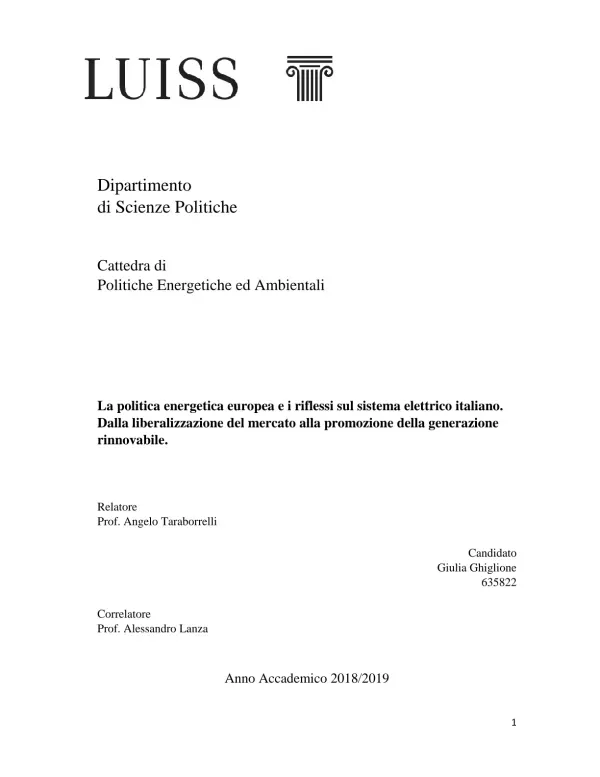
Liberalizzazione Mercato Elettrico Italiano
Informazioni sul documento
| Autore | Giulia Ghiglione |
| instructor | Prof. Angelo Taraborrelli |
| Scuola | Dipartimento di Scienze Politiche |
| Specialità | Politiche Energetiche ed Ambientali |
| Tipo di documento | Tesi |
| Lingua | Italian |
| Formato | |
| Dimensione | 2.89 MB |
Riassunto
I.La Domanda di Energia Elettrica Caratteristiche e Sfide
La domanda di energia elettrica in Italia, strettamente legata a fattori climatici e ambientali, si presenta anelastica rispetto alle variazioni di prezzo. Questa inelasticità, dovuta all'eterogeneità dei consumatori e alla funzione sociale dell'energia, crea una domanda instabile e difficile da prevedere, rendendo fondamentale una continua attività di dispacciamento per mantenere l'equilibrio tra offerta e domanda e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Un sistema elettrico deve avere una potenza installata superiore al 15% della domanda massima, con impianti che rispondono con diversa tempestività alle variazioni di domanda (es. impianti a gas a ciclo combinato più reattivi rispetto a quelli a carbone).
1. Anelasticità della Domanda e Fattori Influenzanti
Il documento inizia evidenziando l'anelasticità della domanda di energia elettrica rispetto alle variazioni di prezzo. Questa caratteristica è attribuita all'eterogeneità dei consumatori e ai loro diversi fabbisogni, che rendono la domanda variabile nel tempo e difficile da prevedere. La quantità di energia richiesta può essere costante o fluttuare nel corso della giornata, a seconda del tipo di consumatore. Questa dinamica, fondamentale per il settore elettrico, rappresenta una sfida significativa per il buon funzionamento del sistema. L'instabilità della domanda rende necessaria una gestione continua del servizio di dispacciamento, ovvero il mantenimento di un equilibrio dinamico tra produzione e consumo di energia. La capacità di risposta del sistema alle variazioni di domanda è fondamentale, con la necessità di un mix energetico flessibile che consenta di incrementare la produzione anche in caso di eventi imprevisti. Il documento sottolinea come un sistema elettrico debba avere una potenza installata almeno del 15% superiore al valore della domanda massima per garantire la continuità del servizio. Anche la velocità di risposta degli impianti alla variazione di domanda è un fattore chiave, con gli impianti a gas a ciclo combinato che risultano avvantaggiati rispetto a quelli a carbone per la loro maggiore tempestività.
2. Il Ruolo del Dispacciamento e la Necessità di un Sistema Integrato
La produzione di energia elettrica, come descritto, si basa sulla trasformazione dell'energia ricavata da fonti primarie, come carbone e gas, dato che l'energia elettrica non esiste in natura. La fase successiva della filiera comprende la trasmissione e il dispacciamento. Il dispacciamento, in particolare, assume un ruolo fondamentale nel garantire l'equilibrio costante tra energia prodotta e immessa in rete e energia prelevata e consumata da imprese e famiglie. Questa attività di bilanciamento è essenziale per la stabilità del sistema, mantenendo frequenza e tensione entro limiti stabiliti e gestendo i flussi di energia in modo da non superare la capacità massima della rete. L'importanza del dispacciamento emerge come un elemento cruciale per il buon funzionamento del sistema elettrico, sottolineando la sua funzione di bilanciamento tra domanda e offerta in tempo reale. Si evidenzia come il dispacciamento diventi parte integrante della filiera solo con lo sviluppo di un vero sistema elettrico integrato, a differenza delle prime fasi di sviluppo del settore, dove la produzione e distribuzione erano molto più localizzate e meno complesse.
3. Caratteristiche della Domanda e Difficoltà di Stoccaggio
Il testo approfondisce le caratteristiche della domanda di energia elettrica, sottolineando la sua inelasticità rispetto al prezzo. Cioè, le variazioni di prezzo hanno un impatto minimo sulla quantità di energia consumata, a causa della funzione sociale dell'energia elettrica come bene essenziale. La domanda è influenzata maggiormente da fattori stagionali e climatici piuttosto che dal prezzo, rendendo difficile la previsione accurata dei consumi. Questa imprevedibilità della domanda, combinata con l'impossibilità di immagazzinare grandi quantità di energia elettrica a costi ragionevoli, costituisce una sfida significativa per la gestione del sistema elettrico. Sebbene esistano sistemi di accumulo di energia (chimici, elettrochimici, meccanici), questi non sono ancora economicamente competitivi su larga scala. Di conseguenza, la complessità della gestione dell'energia elettrica risiede nella gestione della domanda, richiedendo meccanismi adeguati per far fronte a picchi improvvisi e prevenire interruzioni del servizio (blackout). L'obiettivo primario è dunque quello di rispondere in modo tempestivo e affidabile alle fluttuazioni della domanda.
II.Produzione Trasmissione e Distribuzione dell Energia Elettrica
La produzione di energia elettrica avviene tramite la trasformazione di energia da fonti primarie (carbone, gas, ecc.). La filiera elettrica comprende poi la trasmissione (trasformatori, linee ad alta tensione) e il dispacciamento, che garantisce l'equilibrio tra produzione e consumo. L'energia elettrica non è immagazzinabile, rendendo cruciale la gestione efficiente della rete e la previsione della domanda. Lo sviluppo del sistema elettrico, a partire dai primi impianti di illuminazione a New York (1882) e Milano (1883), ha portato alla nascita di monopoli naturali, prima con ENEL (nazionalizzazione nel 1962), poi con la successiva liberalizzazione del mercato.
1. Produzione di Energia Elettrica Fonti e Trasformazione
Il processo di produzione di energia elettrica parte dalla trasformazione dell'energia ricavata da fonti primarie, principalmente carbone e gas, in quanto l'elettricità non esiste in natura. Questo processo di conversione energetica è il primo stadio della filiera elettrica. La scelta delle fonti primarie e l'efficienza della trasformazione influenzano significativamente i costi di produzione e l'impatto ambientale. Il documento accenna alla diversificazione del mix energetico come elemento chiave per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, in grado di far fronte ad eventi straordinari e garantire una fornitura continua di elettricità. La scelta degli impianti, inoltre, tiene conto della loro convenienza economica e della velocità di entrata in servizio, con gli impianti a gas a ciclo combinato che offrono una maggiore flessibilità e tempestività nel rispondere alle variazioni di domanda rispetto agli impianti a carbone. L'importanza della scelta di un mix energetico ottimale e flessibile è cruciale per la stabilità della rete e la sicurezza degli approvvigionamenti.
2. Trasmissione e Dispacciamento Il Ruolo della Rete Elettrica
La trasmissione dell'energia elettrica rappresenta il secondo stadio della filiera, coinvolgendo trasformatori di altissima tensione nelle centrali elettriche nazionali o ai punti di confine, linee elettriche ad altissima e alta tensione per il trasporto, e stazioni di trasformazione che adattano la tensione per la distribuzione alle società di distribuzione locale. Questa complessa infrastruttura è fondamentale per il trasporto efficiente dell'energia prodotta ai consumatori. Un aspetto cruciale è l'incapacità di immagazzinare l'energia elettrica in grandi quantità, rendendo necessario un costante bilanciamento tra produzione e consumo. Questo bilanciamento viene garantito dall'attività di dispacciamento, che regola i flussi di energia sulla rete, mantenendo frequenza e tensione entro i limiti consentiti. Il dispacciamento è un elemento chiave per la stabilità e l'affidabilità del sistema, intervenendo per assicurare l'equilibrio in tempo reale tra la produzione e il consumo di energia elettrica. Il buon funzionamento della rete elettrica dipende fortemente da questa attività di monitoraggio e controllo dei flussi energetici.
3. Evoluzione Storica del Sistema Elettrico Dai Primi Impianti al Monopolio
Il documento traccia una breve storia dell'evoluzione del sistema elettrico, partendo dalla costruzione del primo impianto a New York nel 1882, rapidamente imitato l'anno successivo a Milano da Edison, che illuminò il Teatro alla Scala. Questi primi impianti, simili a quello di New York, consentivano una generazione elettrica continua per brevi linee di illuminazione, lontani dal concetto di monopolio. All'epoca, il gas era ancora la fonte energetica predominante per usi domestici e industriali, mentre l'elettricità si affermava inizialmente solo per l'illuminazione pubblica, come dimostrato dall'esposizione universale di Parigi del 1881. L'espansione dell'uso dell'elettricità si estese poi al settore dei trasporti urbani, con lo sviluppo di reti tranviarie elettriche in tutta Europa, con la Germania in prima posizione a inizio 1895. La nazionalizzazione del settore elettrico in Italia nel 1962, con la creazione di ENEL, ha segnato un passaggio fondamentale, creando un monopolio nazionale nella produzione, importazione, esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte. ENEL, con personalità giuridica di diritto pubblico, ha potuto investire negli impianti di produzione e regolare le tariffe per garantire la disponibilità e l'economicità dell'energia.
III.La Liberalizzazione del Mercato Elettrico e il Ruolo di ENEL
La liberalizzazione del mercato elettrico, iniziata negli anni '90, ha portato alla trasformazione di ENEL in società quotata in borsa e alla creazione di diverse società (Erga, ENEL Distribuzione, ENEL Trade, Terna, Sogin). La privatizzazione di ENEL è stata accompagnata dalla creazione dell'Autorità di regolazione (oggi ARERA) e dalla definizione di nuove norme per la concorrenza nel settore. L'ENEL, inizialmente monopolista, ha mantenuto un ruolo chiave nella trasmissione e distribuzione, con obblighi di servizio pubblico. Il Decreto Bersani ha segnato un passaggio fondamentale in questa trasformazione del settore.
1. La Nazionalizzazione del Settore Elettrico con ENEL 1962
Il testo descrive la completa nazionalizzazione del settore elettrico italiano nel 1962, con l'acquisizione da parte di ENEL di tutte le società preesistenti, tra cui Edison, Centrale, SADE, SIP, SME e altre più piccole. Questo evento ha segnato un passaggio fondamentale, creando un monopolio statale nella gestione dell'energia elettrica. Prima di questa data, lo sviluppo del settore si basava principalmente sull'energia idroelettrica, abbondante in Italia, e la scelta delle località per gli impianti era fortemente condizionata dalla geografia. ENEL, in qualità di ente pubblico, aveva il compito di esercitare tutte le attività connesse alla produzione, importazione, esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita di energia elettrica da qualsiasi fonte. Questa struttura monopolistica consentiva investimenti mirati negli impianti di produzione e un controllo sulle tariffe, garantendo disponibilità ed economicità dell'energia. La legge istitutiva prevedeva la vigilanza da parte del Ministero per l'Industria e il Commercio, con direttive decise da un Comitato di Ministri presieduto dal Presidente del Consiglio.
2. Le Crisi Energetiche degli Anni 70 e il Piano Energetico Nazionale
Le crisi energetiche del 1973 e del 1977 hanno portato per la prima volta all'attenzione pubblica i temi del risparmio energetico e dello sviluppo di fonti alternative. Il Piano Energetico Nazionale del 1975 ha puntato sulla produzione da fonti alternative e sull'energia nucleare per ridurre la dipendenza dal petrolio e coprire il fabbisogno nazionale. ENEL ricevette l'incarico di realizzare una nuova capacità di generazione nucleare di 20.000 MW entro il 1985. Questa decisione, presa in un contesto di crisi e basata su previsioni di crescita dei consumi che si rivelarono poi errate (nel 1995 i consumi furono molto inferiori alle previsioni del 1975), evidenzia la difficoltà di pianificazione a lungo termine nel settore energetico. La discrepanza tra previsioni e consumi effettivi sottolinea l'importanza di previsioni accurate e di una pianificazione flessibile in un settore così complesso e sensibile a fattori esterni imprevedibili.
3. La Liberalizzazione e la Trasformazione di ENEL Nascita di Nuove Società
Il processo di liberalizzazione del settore elettrico, iniziato negli anni '90, ha portato alla trasformazione di ENEL in una società quotata in borsa. Questo processo ha coinciso con l'istituzione dell'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità (precursore dell'attuale ARERA), una fase propedeutica alla privatizzazione di ENEL (Legge n. 481/1995). Il decreto legislativo ha mantenuto l'uniformità delle tariffe elettriche sul territorio e ha definito gli oneri connessi all'abbandono del nucleare da parte di ENEL e altre imprese. La Convenzione tra il Ministero dell'Industria ed ENEL del 1995 ha disciplinato le attività elettriche in Italia per quarant'anni, confermando il ruolo di ENEL nella trasmissione e distribuzione con l'obbligo di servizio pubblico. Il Decreto Bersani ha poi segnato una svolta, trasformando ENEL da monopolista a società finanziaria che controlla società separate per diversi settori della filiera (Erga per le rinnovabili, ENEL Distribuzione, ENEL Trade, Terna per la rete di trasmissione, e Sogin per lo smantellamento delle centrali nucleari). Sebbene la liberalizzazione abbia favorito l'ingresso di nuovi attori, alcuni aspetti, come gli investimenti infrastrutturali, hanno mantenuto un carattere monopolistico.
IV.Il Ruolo dell Unione Europea nella Regolamentazione del Settore Elettrico
L'Unione Europea ha gradualmente definito una politica energetica attraverso diversi strumenti (Libri Verdi, Direttive, ecc.), promuovendo la liberalizzazione e integrazione dei mercati dell'energia, l'aumento delle fonti rinnovabili, e la sicurezza degli approvvigionamenti. Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) stabilisce obiettivi specifici in materia di energia, tra cui il mercato interno dell'energia, la sicurezza energetica, l'efficienza energetica, e le energie rinnovabili. Direttive come la 96/92/CE hanno introdotto obblighi per i gestori di rete (es. priorità di dispacciamento per le fonti rinnovabili). La creazione di ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) mira a migliorare il coordinamento tra i regolatori nazionali.
1. Evoluzione delle Politiche Energetiche Europee
Il documento evidenzia che, inizialmente, le politiche comunitarie in campo energetico hanno risentito della mancanza di una competenza esplicita in materia nei Trattati. Nonostante ciò, l'Unione Europea ha sviluppato una politica energetica lungimirante rispetto ad altri Paesi, intervenendo con documenti programmatici (Libri Verdi, Libri Bianchi, Programmi d'azione) e direttive specifiche sul settore energetico. Questi strumenti hanno affrontato diverse esigenze di regolamentazione, dalla liberalizzazione e integrazione dei mercati energetici all'integrazione delle fonti rinnovabili nei sistemi energetici nazionali. I tentativi di inserire un capitolo specifico sull'energia nei Trattati di Maastricht e Amsterdam non hanno avuto successo, nonostante la dipendenza energetica e la sicurezza degli approvvigionamenti fossero considerate questioni prioritarie. Tuttavia, questi tentativi hanno evidenziato la connessione tra la necessità di una strategia energetica unitaria e la sua sostenibilità ambientale, con la riduzione delle emissioni che è diventata un tema centrale negli interventi europei e internazionali.
2. Il Trattato sul Funzionamento dell Unione Europea TFUE e la Governance dell Energia
Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) contiene disposizioni specifiche sulla sicurezza energetica, le reti energetiche, il carbone, l'energia nucleare, il mercato interno dell'energia e la politica energetica estera. Il TFUE definisce gli obiettivi di politica energetica, ponendo enfasi sul funzionamento del mercato interno dell'energia e sulle reti di interconnessione, sulla sicurezza degli approvvigionamenti, sull'efficienza energetica, sulla promozione delle rinnovabili e sull'innovazione. Il Trattato di Lisbona ha modificato radicalmente le relazioni tra Commissione e Stati membri nella governance dell'energia, creando un intreccio di competenze e ruoli tra tutti gli attori. L'efficacia del coordinamento tra i diversi soggetti risulta quindi un fattore determinante per il successo degli interventi comunitari e nazionali in materia energetica. Il documento cita la Direttiva 96/92/CE e l'obbligo per il gestore della rete di dare priorità agli impianti di generazione da fonti rinnovabili o da cogenerazione, a dimostrazione dell'attenzione della normativa comunitaria verso la sostenibilità e la sicurezza degli approvvigionamenti.
3. Integrazione dei Mercati e Ruolo dei Regolatori Nazionali
L'Unione Europea mira a creare meccanismi di cooperazione tra gli Stati membri per migliorare l'integrazione dei mercati nazionali dell'energia e ridurre le differenze nel grado di apertura. Il documento evidenzia la mancanza di uniformità nel recepimento e nell'attuazione delle normative all'interno dei singoli Stati membri, con l'avvio di procedure di infrazione per gli Stati inadempienti. La mancanza di interventi in materia di scambi transfrontalieri di energia è un altro punto critico sottolineato dalla Commissione, che ha proposto la creazione di un'agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali per migliorare il coordinamento. La Commissione favorisce la separazione integrale della proprietà delle reti dalle attività di generazione e fornitura, ritenendola la soluzione più efficace per rimuovere gli ostacoli agli investimenti nelle infrastrutture e risolvere i conflitti di interesse. La normativa comunitaria prevede il potenziamento dei poteri dei regolatori nazionali e la creazione di ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) per coordinare le loro attività, garantendo l'indipendenza dai governi nazionali e dai soggetti regolati.
V.Regolamentazione Italiana Mercati e Incentivi per le Fonti Rinnovabili
La regolamentazione italiana del settore elettrico si concentra sulla tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, e l'efficienza del sistema. L'ARERA svolge un ruolo cruciale nella regolamentazione delle tariffe, nella definizione degli standard di qualità, e nel monitoraggio del mercato. Il Mercato per il Servizio di Dispacciamento (MSD) e il mercato infragiornaliero sono strumenti chiave per la gestione dell'offerta e della domanda. Gli incentivi alle fonti rinnovabili, inizialmente basati su schemi come il CIP6 e i Certificati Verdi (CV), hanno contribuito allo sviluppo di queste tecnologie. L'introduzione di nuovi modelli di business, come gli aggregatori e i prosumer, rappresenta una sfida per il futuro della regolamentazione.
1. Il Ruolo dell ARERA nella Regolamentazione del Settore
In Italia, la regolamentazione del settore elettrico è affidata all'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), precedentemente nota come AEEG e AEEGSI. L'ARERA ha il compito di tutelare i consumatori, promuovere la concorrenza e garantire l'efficienza del sistema. Opera in piena autonomia e indipendenza dagli indirizzi politici. La sua attività di regolazione e controllo si esplica attraverso provvedimenti e deliberazioni che riguardano la determinazione delle tariffe, la definizione di livelli minimi di qualità dei servizi, la promozione di investimenti infrastrutturali, la garanzia di trasparenza e la tutela dei consumatori. L'Autorità svolge inoltre attività di monitoraggio e vigilanza sulla qualità del servizio, la sicurezza, l'accesso alle reti, le tariffe e gli incentivi alle rinnovabili. Un esempio di intervento dell'ARERA è la regolamentazione della continuità di distribuzione dell'energia elettrica, con delibere che definiscono obblighi di registrazione delle interruzioni, indicatori di qualità e standard per la riduzione delle interruzioni, con penalità per le imprese che non rispettano i target. Il focus è sulla tutela del consumatore e l'efficienza del sistema elettrico.
2. Mercati Elettrici MSD e Mercato Infragiornaliero
Il documento descrive il Mercato per il Servizio di Dispacciamento (MSD) come strumento attraverso cui Terna, gestore della rete, si approvvigiona delle risorse necessarie per la gestione e il controllo del sistema (risoluzione delle congestioni, creazione di riserva, bilanciamento in tempo reale). Terna stipula contratti di acquisto e vendita, agendo come controparte centrale. Le offerte sul MSD sono presentate dai diretti utenti del dispacciamento, senza possibilità di delega. Il GME (Gestore del Mercato Elettrico) determina il corrispettivo di non arbitraggio per ogni offerta di acquisto accettata, con una remunerazione al prezzo offerto (pay-as-bid). Il MSD si articola in una fase di programmazione (ex-ante) e un Mercato del Bilanciamento (MB), entrambi suddivisi in sei sessioni. Il documento menziona anche l'istituzione del Mercato Infragiornaliero (MI), precedentemente Mercato di Aggiustamento, la sua integrazione con il MSD e lo sviluppo dei mercati a termine, fisici e finanziari, come parte di una più ampia riforma del settore, frutto anche di decreti legge e altre normative specifiche che regolamentano la borsa elettrica e l'accesso al mercato libero.
3. Incentivi alle Fonti Rinnovabili CIP6 e Certificati Verdi
Il sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili in Italia è stato inizialmente implementato con il CIP6, un meccanismo di incentivazione di tipo "Feed-in Tariff", introdotto nel 1992. Questo sistema stabiliva prezzi incentivanti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e "assimilate", includendo anche impianti di cogenerazione e impianti da fonti tradizionali che utilizzavano fonti fossili da giacimenti minori. Successivamente, si è affermato il sistema dei Certificati Verdi (CV), che prevedeva lo scambio di titoli sul mercato corrispondenti a una certa quantità di emissioni di CO2, assegnati gratuitamente dal GSE (Gestore Servizi Energetici). In contemporanea esisteva la "Tariffa Omnicomprensiva" (TO) per impianti di piccola taglia. Sia i CV che la TO sono stati poi modificati e sostituiti da nuove tariffe incentivanti. L'evoluzione dei meccanismi di incentivazione riflette l'adattamento continuo delle politiche energetiche italiane per promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili e l'integrazione di nuove tecnologie nel mix energetico nazionale. Il testo evidenzia l'importanza di questi incentivi nel contesto della transizione energetica.
VI.La Transizione Energetica e gli Obiettivi del 2030 e Oltre
Il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Quadro per l'Energia e il Clima 2030 e dall'Unione per l'Energia, richiede una profonda trasformazione del settore elettrico. L'elettrificazione, l'aumento della quota di energie rinnovabili, e l'efficienza energetica sono elementi chiave. Il Pacchetto Clean Energy for all Europeans introduce una serie di misure per guidare questa transizione, tra cui la Direttiva sull'efficienza energetica e la Direttiva sulle prestazioni energetiche degli edifici. La Strategia a lungo termine per un'economia a basse emissioni di carbonio definisce una roadmap per un futuro a zero emissioni entro il 2050, enfatizzando il ruolo dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili, e della mobilità sostenibile. La sfida consiste nell'integrare le fonti intermittenti nel sistema e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti.
1. Il ruolo di ARERA e la regolamentazione della continuità del servizio
L'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), nel suo ruolo di garante del mercato elettrico italiano, si occupa della tutela dei consumatori e della promozione della concorrenza. L'ARERA definisce le tariffe, stabilisce standard minimi di qualità del servizio e promuove investimenti infrastrutturali. Un aspetto rilevante della sua attività è la regolamentazione della continuità del servizio elettrico. Attraverso delibere specifiche (ad esempio, n. 128/99 e n. 202/99), l'ARERA ha definito gli obblighi di registrazione delle interruzioni di corrente, gli indicatori di continuità e i livelli di qualità del servizio, introducendo anche standard per la riduzione delle interruzioni e penalità per le imprese che non li rispettano. Il percorso di miglioramento della continuità del servizio, definito dall'ARERA per il periodo 2000-2003, prevedeva un obiettivo complessivo del 34%, con interventi mirati nelle aree geografiche con livelli di servizio inferiori alla media. L'ARERA svolge un ruolo fondamentale nel bilanciamento tra la necessità di efficienza del sistema e la soddisfazione delle esigenze dei consumatori, attraverso un costante monitoraggio e un'azione regolatrice volta a garantire livelli adeguati di qualità e continuità del servizio elettrico.
2. Mercati Elettrici struttura e normative
La regolamentazione italiana del mercato elettrico, oltre al ruolo dell'ARERA, comprende diverse normative e strumenti. Il documento cita il Decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 (convertito con legge 3 agosto, n. 125), che introduce il servizio di tutela e il servizio di salvaguardia nel mercato libero. Sono menzionate anche la Delibera ARG/elt 115/08 e la Delibera AEEG ARG/elt 203/08, che riguardano rispettivamente l'attività di monitoraggio da parte dell'Autorità e la partecipazione delle unità di consumo al Mercato Infragiornaliero e l'abolizione della PAB (Piattaforma di Aggiustamento Bilaterale per la Domanda). La legge n. 2 del 28 gennaio 2009 istituisce il Mercato Infragiornaliero (MI), riforma il Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD) e ne integra il funzionamento con il MI, promuovendo lo sviluppo dei mercati a termine. Infine, si fa riferimento alla legge n. 99 del 23 luglio 2009 sulle disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, anche in materia di energia. Questa pluralità di strumenti legislativi sottolinea la complessità della regolamentazione del settore elettrico, che deve adattarsi alle continue evoluzioni del mercato e alle nuove sfide tecnologiche e normative.
3. Incentivi per le Fonti Rinnovabili e sfide future
Il documento tratta gli incentivi per le fonti rinnovabili, partendo dal CIP6 (un meccanismo di tipo "Feed-in Tariff") e dai Certificati Verdi (CV), successivamente modificati e sostituiti da nuove tariffe incentivanti. Questi schemi di incentivazione hanno mirato a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tuttavia, la crescente diffusione delle energie rinnovabili e la conseguente decentralizzazione della produzione hanno portato alla nascita di nuove figure, come gli "aggregatori" e i "prosumer", che richiedono un adeguamento del quadro normativo. Gli aggregatori, definiti come centrali elettriche virtuali con sistemi di accumulo, permettono modelli di business peer-to-peer indipendenti dalla rete nazionale. L'integrazione di fonti intermittenti richiede maggiore flessibilità e reattività da parte del sistema, e la progettazione di meccanismi di remunerazione della capacità (capacity market) è fondamentale per evitare conseguenze negative sul funzionamento dei mercati. L'integrazione di queste nuove realtà, con le sfide della concorrenza nei mercati europei e la necessità di incentivare gli investimenti nelle infrastrutture, rappresenta una delle principali sfide per il futuro della regolamentazione del settore elettrico.
